Concetti Chiave
- I poemi cavallereschi del Cinquecento riflettono una trasformazione sociale, con i cavalieri che diventano più umani e guidati dalle passioni.
- Nell'epica rinascimentale, i temi del ciclo carolingio si mescolano con quelli del ciclo bretone, come amore, avventura e magia.
- L'Orlando furioso di Ludovico Ariosto è il capolavoro dell'epica cavalleresca rinascimentale, rappresentando un complesso quadro della natura umana.
- La metà del Cinquecento vede una crisi della cultura umanistica, con un declino della fiducia nelle capacità dell'uomo e un aumento dell'insicurezza.
- La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso riflette la crisi di valori del periodo, con una visione malinconica e tormentata dell'uomo.
Nel Cinquecento i poemi cavallereschi hanno una larga diffusione, sia nelle corti rinascimentali italiane, sia in quelle dei principi d’Europa. Cantori e menestrelli intrattengono con i racconti dei paladini di Carlo Magno un pubblico vasto e composito, formato sia da nobili che da popolani. Con il passare del tempo queste storie di cavalieri cominciano però a modificarsi.
Nell’epica rinascimentale ritroviamo personaggi e situazioni del ciclo carolingio, ma anche e soprattutto temi e motivi del ciclo bretone: l’amore, l’avventura e la magia. I paladini di Carlo Magno continuano dunque a combattere contro i saraceni, ma smettono di essere eroi tutti d’un pezzo, puri e virtuosi, mossi esclusivamente dalla fede in Dio e dalla devozione nei riguardi del sovrano. Diventano più simili a uomini veri, guidati dalle passioni più che dal senso dell’onore, capaci di grandi imprese, ma anche di manifestare debolezze e sentimenti. Questa trasformazione riflette quella avvenuta nella società in epoca rinascimentale. La cultura umanistica ha posto al centro dell’universo l’uomo, con i suoi sentimenti e le sue passioni; contemporaneamente, la cavalleria ha perso il suo antico prestigio, a causa dell’affermarsi degli eserciti mercenari, ma anche dell’invenzione delle armi da fuoco.
Il capolavoro dell’epica cavalleresca rinascimentale è L’Orlando furioso di Ludovico Ariosto, che infatti nel suo articolato intreccio di situazioni e di personaggi presenta un quadro estremamente vario della natura umana, colta nel contraddittorio avvicendarsi delle posizioni e dei sentimenti che la agitano.
La crisi degli ideali rinascimentali
Intorno alla metà del Cinquecento la cultura umanistica entra in crisi e, con essa, la fiducia nelle capacità intellettuali e creative dell’uomo. Nell’Italia dominata dagli spagnoli e pesantemente condizionata dal clima della Controriforma, cioè dalla reazione della Chiesa cattolica al diffondersi della dottrina protestante, intellettuali e artisti si ritrovano ad operare in una situazione di sempre minore libertà, sia politica, sia culturale. L’ottimismo e lo spirito di ricerca che avevano dominato nella prima metà del secolo lasciano così il posto a un progressivo smarrimento, a un diffuso sentimento di ansia e di insicurezza nei riguardi del futuro. Gli ideali di armonia, serenità e perfezione dell’età rinascimentale cedono il passo a una visione dell’uomo tormentata e cupa, dominata dal senso del peccato e dei limiti delle capacità umane. Questa generale crisi di valori si riflette appieno nella Gerusalemme liberata, il travagliato e malinconico capolavoro di Torquato Tasso.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali trasformazioni nei poemi cavallereschi del Cinquecento?
- Qual è il capolavoro dell’epica cavalleresca rinascimentale e cosa rappresenta?
- Come si manifesta la crisi degli ideali rinascimentali nella letteratura del Cinquecento?
Nel Cinquecento, i poemi cavallereschi iniziano a includere temi del ciclo bretone come l'amore, l'avventura e la magia, e i paladini diventano più umani, guidati dalle passioni piuttosto che dall'onore.
Il capolavoro è "L'Orlando furioso" di Ludovico Ariosto, che rappresenta un quadro vario della natura umana, mostrando la complessità dei sentimenti e delle posizioni umane.
La crisi si manifesta in opere come "Gerusalemme liberata" di Torquato Tasso, che riflette un sentimento di ansia e insicurezza, abbandonando l'ottimismo e l'armonia del Rinascimento.

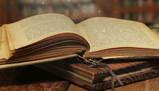





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo