
Le materie della Maturità 2020 sono state ormai comunicate. I maturandi sanno quindi che il prossimo 18 giugno, data della seconda prova, si troveranno davanti una traccia mista, ovvero pluridisciplinare, che contiene sia greco che latino. Ma come si compone questa traccia, e come si svolge? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla seconda prova per gli studenti del classico, come gli alunni di tutti gli indirizzi dovranno affrontarla durante gli esami di maturità.
Una pratica guida dove troverete tutte le informazioni, le novità e qualche consiglio.
-
Guarda anche:
- Che materie si fanno negli esami di maturità 2020
- Materie maturità 2020: lista completa e news in diretta
- Maturità 2020: guida alle prove
- Maturità 2020: tutte le novità
Maturità seconda prova liceo Classico, come cambia
L’esame di maturità con il susseguirsi degli anni è stato ripetutamente oggetto di novità e di cambiamenti. Nel novembre 2018 il Miur ha pubblicato i quadri di riferimento per le prove scritte riformate e le griglie di valutazione, che illustrano le modalità dello svolgimento della seconda prova nei Licei Classici. In sede di esame nella seconda prova, infatti, il Miur può scegliere più di una materia e sottoporre quindi agli studenti una prova di conoscenza in entrambe le lingue. Nelle tracce, inoltre, ci saranno dati di contesto e dei quesiti di analisi del testo a cui dover rispondere.
Seconda prova liceo classico 2020: struttura e tracce
La seconda prova del liceo classico 2020 sarà articolata in due parti:
- Prima parte: traduzione di un testo in lingua greca. Sarà proposto un testo in prosa, tratto dagli autori proposti nelle Indicazioni nazionali che definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento del liceo classico: la versione sarà contenuta entro le 10-12 righe, e può essere anche un dialogo.
- Seconda parte: analisi del testo Dopo aver svolto la versione, viene richiesta la risposta a tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione del brano.
- Terza parte: analisi del testo di un brano di latino (con traduzione a fronte) Verrà proposto un testo in lingua latina con traduzione a fronte in italiano. Questo secondo testo sarà di contenuto analogo o correlato al precedente.
Il testo sarà corredato di un titolo e di un breve brano introduttivo che aiuterà a contestualizzare la versione.
I quesiti prevedono quindi risposte aperte, di massimo 10/12 righe di foglio protocollo.
Verranno quindi sottoposti 3 quesiti su entrambi i testi e su possibili comparazioni e confronti.
Seconda prova Maturità Classico: quanto dura e possibili autori
Per svolgere la traccia in greco o in latino (o entrambe le materie), agli studenti sono state date 6 oredi tempo, con la possibilità di usare il vocabolario bilingue (latino/greco-italiano e italiano-latino/greco).
Anche l’autore della prova viene scelto dal Ministero dell’Istruzione e, proprio per la vastità del repertorio letterario sia greco che latino, è difficile capire di preciso con quale fra tutti i maturandi dovranno confrontarsi. Si possono comunque fare delle previsioni in base alla frequenza degli autori usciti negli ultimi anni.
In generale possiamo dire che quelli più gettonati sono gli stessi che si studiano nella letteratura dell’ultimo anno, anche se talvolta il Miur ha depistato ogni previsione e fatto decadere ogni aspettativa presentando autori più marginali.
Al di là di queste sporadiche ma possibili inversioni di rotta, possiamo citare alcuni fra gli autori più richiesti nelle seconde prove degli ultimi anni. Per la traccia di latino sono Tacito, Seneca, Cicerone, Tito Livio, Quintiliano, Petronio mentre per quella di greco sono Platone, Aristotele, Plutarco, Lisia, Luciano, Isocrate.
Se non amate i virtuosismi della poesia e delle opere drammatiche greche e latine, non preoccupatevi perché i testi previsti nella seconda prova non sono mai poesie o tragedie/commedie. Si tratta di prose, di media lunghezza, spesso a carattere storiografico o filosofico, e della stessa complessità delle altre versioni svolte durante l’ultimo anno.
Come prepararsi alla seconda prova Maturità liceo classico
Qui vi daremo alcuni consiqli su come prepararsi alla versione di greco o latino alla maturità 2019:
- Conoscere la letteratura Per prima cosa è importante conoscere l’autore e il suo usus scribendi che varia da autore ad autore, in relazione all’epoca, al ruolo che ricopriva e allo scopo dell’opera stessa.
- Ripassare la grammatica Inutile raccomandare fortemente il ripasso di tutta la grammatica, con un riguardo particolare però a tutte quelle forme che risultano più lacunose e difficili per ciascuno da memorizzare.
Ogni scrittore in genere ha un repertorio fisso nella costruzione dei periodi e nell’uso virtuoso della grammatica. Se si conosce inoltre anche la sua storia e la letteratura da lui prodotta, si ha sicuramente un vantaggio ulteriore poiché avere cognizione della sua posizione nel quadro della letteratura, può aiutare a capire le intenzioni espresse nella versione e a costruire così una traduzione nel migliore dei modi.
Poiché siamo di fronte ad un Esame di Stato con il quale ci congediamo dalla scuola superiore, non ci si può aspettare un brano facile con le strutture basiche della lingua, poiché le conoscenze messe in campo verteranno su tutta la grammatica esercitata nei 5 anni, in special modo sulle forme più complesse come i periodi ipotetici, le perifrastiche, le proposizioni subordinate (soprattutto quelle rette dai congiuntivi come le relative improprie), i verbi irregolari e deponenti (o semideponenti), l’accusativo alla greca, e, più in generale, ogni costrutto più difficoltoso da individuare e tradurre.
Se avete dubbi o non avete capito alcune forme della grammatica, lasciate da parte paura e vergogna e durante le lezioni a scuola ricordate di chiederne spiegazione ai docenti che potranno aiutarvi costantemente a fare chiarezza nello studio della lingua.
Come affrontare la versione il giorno della seconda prova
Ma come fare a tradurre in maniera perfetta la versione che proporrà il Miur tra le tracce di seconda prova? Ecco alcuni suggerimenti da tener presente:
- Leggere per intero tutto il testo La prima cosa da evitare una volta che avete in mano il foglio del brano consegnato dalla commissione esaminatrice, è quella di non essere frettolosi nell’iniziare a sfogliare il vocabolario per tradurre. Una strategia per iniziare bene è quella di leggere con calma tutto il testo e cominciare a farsi un’idea dell’argomento e delle strutture generali che si incontrano.
- Sottolineare tutte le forme verbali Tenete sempre a mente la ‘regola d’oro’ che in genere gli insegnanti ripetono nelle classi, ovvero quella di individuare e sottolineare sempre tutte le forme verbali incontrate e di distinguere quelle principali dirette e reggenti da quelle indirette e subordinate. Dalla coniugazione possiamo individuare già molte informazioni tra cui il modo, il tempo del verbo e il numero singolare o plurale del soggetto. Questo è il primo passo per evitare la tipica e frequente confusione che le declinazioni dei sostantivi (come degli aggettivi) generano a causa delle terminazioni uguali nei diversi casi sia latini che greci.
- Costruire il periodo A questo punto possiamo costruire e ordinare tutte le frasi del periodo (cioè fino al punto), iniziando dalla principale (soggetto, verbo reggente e complemento oggetto se transitiva) e snodando poi le subordinate ad essa collegate (temporali, causali, relative, infinitive, dichiarative, finali ecc), tenendo sempre a mente la consecutio temporum per evitare di sbagliare i tempi verbali e la contestualizzazione degli argomenti a cui si riferisce la voce dell’autore (se sta parlando di qualcosa con riferimento al suo presente, ai tempi passati o al futuro).
- Leggere bene il dizionario Il dizionario, se usato con cognizione, non solo è un sostegno di cui nessuno studente può e deve fare a meno, ma spesso se letto e sfogliato con attenzione può rivelarsi una vera e propria salvezza. Esistono infatti costrutti che non sempre si possono sciogliere e tradurre per il semplice fatto che sono fissi e si ripetono così, come i nostri proverbi e modi di dire. Il dizionario può essere fondamentale in questi casi poiché nell’elenco degli esempi riportati per ciascun lemma, vengono riportati gli usi in cui si trova frequentemente.
- Tradurre alla lettera Spesso si pensa che una traduzione ‘abbellita’ sia superiore ad una più letterale, ma non è così. Premesso che una resa in un italiano di livello alto è un elemento fondamentale durante ogni prova che gli studenti devono affrontare nella Maturità, tuttavia una traduzione pomposa e troppo esagerata in tal senso, potrebbe essere deviante nei contenuti e considerata dalla commissione esaminatrice come possibile esito di una copiatura dal web.
- Rileggere e ricopiare in bella copia prima della consegna L’ultima mezzora della prova vi consiglio di rileggere interamente il testo e di verificarne la coerenza generale e delle singole parti. In questo lavoro di revisione spesso ci si accorge di sviste, e di piccoli errori in cui si inciampa per la fretta (come quello frequente tra singolare e plurale) che rileggendo e confrontando il testo e la vostra traduzione parola per parola, potete scoprire e correggere. Sono piccoli errori sì ma da non sottovalutare poiché in sede di correzione farebbero calare il punteggio complessivo della prova.
Non fatevi prendere dall’ansia di iniziare a tradurre e ricordate che il tempo che impiegate in questa fase di ‘ricognizione’ non lo state perdendo ma piuttosto investendo per una resa migliore alla fine.
Dobbiamo pensare alla versione come ad una piccola impalcatura a cui piano piano diamo un senso e in cui ogni periodo è un piccolo mattoncino per giungere poi alla costruzione finale dell’edificio rappresentato dal brano completo.
Saper usare il vocabolario non significa dunque soltanto saper ‘cercare’ la parola ma anche e soprattutto riuscire a conoscerne l’uso contestualizzato.
Ricordate che la cosa fondamentale a cui presta attenzione un docente che corregge una versione è verificare che lo studente abbia compreso e collegato coerentemente tutte le forme della grammatica contenute nel brano.
Distaccarsi troppo da questo potrebbe rivelarsi un rischio. Quindi scrivere bene sì, ma senza strafare!
Dopo aver riletto e corretto la vostra traduzione, non vi rimane che ricopiarla in bella copia secondo le modalità imposte dalla commissione (lasciando uno spazio tra un rigo e l’altro oppure direttamente in colonna), cercando di essere ordinati e con un’ortografia il più possibile chiara e leggibile poiché spesso molti errori vengono segnalati per mancanza di comprensione da parte del docente, spesso esterno alla classe, a cui spetta la correzione.


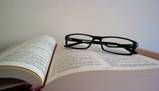




 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo