Concetti Chiave
- Blaise Pascal, enfant prodige, contribuì alla scienza e alla matematica inventando la calcolatrice pascalina a 18 anni e scrivendo saggi significativi.
- Pascal si unì all'abbazia di Port-Royal, influenzato dal giansenismo, opposto alla dottrina gesuitica, partecipando a dibattiti religiosi dell'epoca.
- La sua opera incompiuta "Pensieri" esplora la condizione umana, la fede in Dio e la critica alla scienza e filosofia per la loro limitatezza nel rispondere alle domande esistenziali.
- Pascal introduce la "scommessa" su Dio, suggerendo che credere è una scelta logica e vantaggiosa, poiché rischia il finito per guadagnare l'infinito.
- Contrapponendo razionalità e fede, Pascal sostiene che il cuore è l'organo che percepisce Dio, superando i limiti della ragione cartesiana.
Indice
Infanzia e prime opere di Pascal
Blaise Pascal, francese anche lui come Cartesio, e vissuto tra il 1623 e il 1662. A soli 3 anni, Pascal visse uno dei traumi più grandi che si possano avere ossia perse sua madre, Il padre invece era un magistrato esattore delle tasse molto appassionato di scienza e Pascal, sin da piccolo, fu un vero e proprio enfant prodige, un ragazzino molto talentuoso, tanto da scrivere il suo primo saggio “sulle sezioni coniche” a soli 16 anni e poi a 18 anni riuscì ad inventare la calcolatrice pascalina.
Vita religiosa e giansenismo
Un piccolo genio della matematica e della fisica ma anche con una vocazione religiosa che, nel 1654, lo portò ad entrare tra i solitari dell’abbazia di Port-Royal, come sua sorella Jacqueline; qui si occupò del calcolo delle probabilità e altre invenzioni. In questa comunità religiosa non c’erano regole prestabilite ma si viveva di studio, insegnamento e meditazione, si seguiva la dottrina del giansenismo, derivante dalle teorie dell’olandese Cornelio Giansenio che supportava le tesi di Agostino (scrisse Augustinus): il peccato originale aveva portato l’uomo a perdere la propria libertà e a compiere il male per incapacità di fare del bene, alla fine è Dio che sceglie i propri eletti da salvare. Un’idea in contrapposizione con quella dei più ottimisti gesuiti (l’uomo può operare per la propria salvezza).
Contributi letterari e filosofici
Nel 1653 papa Innocenzo X condannò il giansenismo con una bolla papale e Pascal intervenne nella disputa pubblicando nel 1656 una lettera con lo pseudonimo di Luigi di Montalto per non farsi riconoscere; Pascal poi continuò polemizzando contro la dottrina gesuitica attraverso le sue Lettere provinciali che caratterizzano la letteratura francese oltre che la filosofia (parla ad esempio della “grazia sufficiente” e il possesso delle nostre azioni). L’ultima opera di Pascal è l’Apologia del cristianesimo che purtroppo rimase incompiuto perché il filosofo morì molto giovane, a soli 39 anni a causa degli innumerevoli problemi di salute che lo avevano afflitto sin dall’infanzia. Morì nel 1662 e dopo la sua morte alcuni suoi amici raccolsero i pezzi del suo ultimo lavoro e lo pubblicarono sotto il titolo di Pensieri.
Pensieri sull'esistenza e la fede
Pascal si pone domande sul senso della vita, correlato all’uomo e la sua anima da trovare solo con la fede in Dio, ma è anche uno scienziato, per lui seguire un metodo scientifico razionale non basta per rispondere a certe domande, l’uomo è un mostro incomprensibile, un dissidio naturale soggetto alla società; per lui tutti gli altri studi sono “libido sciendi” e “inutile curiosità”. Si inserisce qui l’illusione del “divertissement” usato per indicare lo sviamento dell’uomo all'interrogativo primario, il termine è inteso come uno “stordimento di sé”, un “oblio”, una “fuga da sé”. L’uomo fugge da sé stesso attraverso le attività quotidiane pur di non pensare all’esistenza e per paura della noia, la quale, secondo Pascal, provoca la miseria perché rivela la fragilità umana e il vuoto interiore, quindi, l’uomo fugge dalla propria infelicità costitutiva.
Pascal sottolinea qualcosa di importante anche in psicologia: l’uomo non vive il presente perché è sempre proiettato verso l’avvenire, ciò che dovrà fare assilla i suoi pensieri: se pensiamo al presente è solo per predisporre l’avvenire ma non è mai il nostro fine bensì un mezzo e così, non viviamo mai, speriamo soltanto e rincorriamo la felicità legata ad eventi futuri che non appagano del tutto. La soluzione ai limiti della mentalità comune, secondo Pascal, è accettare cercare risposte nel cristianesimo. Pascal delinea anche i limiti della scienza e della filosofia; c’è infatti una limitatezza strutturale delle scienze nel rispondere alla domanda chiave, innanzitutto l’esperienza (nonostante sostenesse il metodo sperimentale) poiché limita il potere della ragione che già non è assoluto e poi l’indimostrabilità dei principi primi ai quali bisogna inevitabilmente fermarsi.
Limiti della scienza e della filosofia
Quindi la scienza va in crisi a casa propria e si blocca, ma non deve comunque far entrare Dio o la metafisica in sé perché è autonoma nel suo ambito. In contrapposizione alla ragione c’è, per il filosofo, il “cuore” un organo intuitivo che coglie gli aspetti più profondi dell’esistenza su cui la ragione è impotente e che sa rapportarsi a Dio: quindi si hanno “esprit de géométrie" (realtà naturale) ed “esprit de finesse” (sentimento). Veniamo ora ai limiti della filosofia, essa mostra l’intento nobile di interrogarsi sin dai suoi albori ma si è dimostrata incapace di risolvere alcuni problemi, di comprendere a pieno il dualismo dell’uomo tra grandezza e miseria ossia infinitamente grande e piccolo (posizione mediana tra essere e non essere), di motivare l’oscura ed emblematica presenza di Dio ed infine ha fallito anche nei principi pratici etici, morali e politici perché non ha trovato nulla di universale sulle regole del vivere e del comportamento. Per Pascal la medietà è anche nell’ordine della conoscenza tra ignoranza e scienza assolute perché l’uomo non sa tutto ma sa qualcosa in quanto desideroso di conoscere (vuole ma non può) grazie ad una vocazione verso l’essere; la coscienza della propria miseria è già un segno di grandezza, la facoltà del pensiero è solo del paradosso umano.
La scommessa di Pascal su Dio
Secondo Pascal, tutto è partito dal peccato originale che ha sancito la caduta dell’uomo che prima era un re e poi è stato spodestato dal suo trono e si è ritrovato nella miseria più totale. Per questo motivo, secondo il filosofo, la religione cristiana è l’unica vera religione: ha conosciuto la grandezza e la miseria, e le cause dell’una e dell’altra a differenza di tutte le altre. L’uomo quindi è inquieto,non riesce a darsi pace perché possiede due forze contrapposte che lo spingono ad innalzarsi verso l’infinito e ad abbassarsi verso il finito (dove cerca di soddisfarsi). L’uomo, quindi, deve scegliere se credere in Dio o no e, in questo, Pascal ci fornisce la metafora della scommessa. Credere in Dio è una scommessa, proprio come quando si va a giocare alla roulette (di cui per altro lui aveva studiato una teoria) e punti o sul rosso o sul nero. Hai il 50% di possibilità di vincere, puoi scommettere che Dio esiste o scommettere che Dio non esiste. Nel primo caso se Dio realmente esiste allora guadagni l’infinito, la vita eterna, se invece Dio non esiste hai perso il finito ossia il divertissement e il godimento dei beni terreni di quando sei in vita; nel secondo caso Se Dio esiste hai perso l’infinito, la vita eterna, Se invece Dio non esiste hai guadagnato il finito, ossia il godimento dei beni terreni quando sei in vita. Allora, secondo Pascal, è molto meglio e più logico anche scommettere su Dio perché è meglio rischiare di perdere il finito piuttosto che l’infinito.
Fede e ragione secondo Pascal
Non possiamo però obbligarci a credere in Dio perché non implica solo la ragione ma anche e soprattutto il cuore, è lui che sente Dio. “Ecco che cos’è la fede: Dio sensibile al cuore, e non alla ragione”. Bisogna quindi impegnarsi e abituarsi a credere in lui in modo costante, tutti i giorni facendo tutto come se si credesse fino a convincersene e zittire i dubbi à
+ù); ancora una volta, Pascal si allontana tantissimo dal razionalismo cartesiano sottolineando i limiti della ragione che non arriva a tutto perché con uno schietto salto solo la fede col cuore nel Dio cristiano (un messaggio sovra-razionale) sa veramente portare a capire qual è il senso della vita. Alla fine il Pascal teologo smentisce quello filosofo, annullando di fatto la ricerca umana che sembra valorizzare, a favore della sua ambigua concezione di grazia.
Domande da interrogazione
- Quali sono stati i principali contributi di Blaise Pascal alla matematica e alla scienza?
- Come si è evoluta la vocazione religiosa di Pascal e quale ruolo ha avuto il giansenismo nella sua vita?
- Qual è la visione di Pascal sulla scienza e la filosofia in relazione alla fede?
- Cosa intende Pascal con il concetto di "divertissement"?
- In cosa consiste la "scommessa" di Pascal su Dio?
Pascal è stato un enfant prodige, scrivendo un saggio sulle sezioni coniche a 16 anni e inventando la calcolatrice pascalina a 18 anni. Ha anche contribuito al calcolo delle probabilità.
Pascal si unì ai solitari dell'abbazia di Port-Royal nel 1654, seguendo la dottrina del giansenismo, che enfatizzava la predestinazione divina e si opponeva alle idee gesuitiche.
Pascal credeva che la scienza e la filosofia avessero limiti nel rispondere alle domande esistenziali e che solo la fede cristiana potesse fornire risposte significative, superando i limiti della ragione.
Il "divertissement" è l'illusione che distoglie l'uomo dalle domande esistenziali, un modo per fuggire dalla propria infelicità e dalla noia, che rivela la fragilità umana.
La "scommessa" di Pascal suggerisce che è più logico credere in Dio, poiché se Dio esiste, si guadagna l'infinito; se non esiste, si perde solo il finito. La fede è vista come un atto del cuore, non solo della ragione.

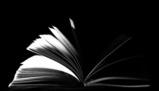





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo