Concetti Chiave
- Nel Trecento, l'occamismo favorisce lo studio scientifico della natura attraverso la "conoscenza intuitiva", spostando l'attenzione dalla metafisica al comportamento fenomenico.
- Buridano, con i suoi studi sull'impetus, avanza verso il principio di inerzia, considerando l'impeto una forza impressa che spiega il movimento celeste.
- Nicola d'Oresme anticipa l'uso di coordinate geometriche per descrivere fenomeni, ponendo le basi per la rappresentazione grafica di leggi temporali.
- Oresme introduce l'idea che la matematica possa descrivere non solo traiettorie spaziali ma anche variazioni temporali, trasformando la scienza in uno strumento quantitativo del divenire.
- Il nuovo corso della scienza, emerso nel tardo Medioevo, supera la separazione tra sfera ideale ed empirica, segnalando l'inizio della scienza moderna.
Indice
L'influenza dell'occamismo sulla scienza
Nel Trecento lo studio scientifico della natura viene favorito dall'impostazione occamistica della "conoscenza intuitiva", che porta a trascurare la metafisica per considerare il comportamento fenomenico del reale.
Contributi di Buridano e Alberto di Sassonia
Gli studi sull'impetus, del Buridano, autore della "Quaestiones super physicorum libros", furono un passo avanti verso il principio di inerzia (sebbene l'impeto sia ancora una "forza impressa", concepita come un principio di attività). Un impeto di questo genere, impresso all'atto della creazione, sarebbe quello che fa ruotare i cieli. Le idee del Buridano furono sviluppate da Alberto di Sassonia (morto verso il 1390), citato ripetutamente da Leonardo da Vinci col nome di "Albertucco". Egli fu rettore a Parigi intorno al 1353, e più tardi a Vienna.
Innovazioni di Nicola d'Oresme
Importanza ancor maggiore, tra i pensatori di questa corrente, ebbe Nicola d'Oresme (1323-1382 circa), rettore del collegio di Navarra a Parigi, e poi vescovo di Lisieux. Nel suo "Tractatus de latitudine formarum", molto letto fino a tutto il Quattrocento, egli precede di oltre due secoli Descartes nell'usare coordinate geometriche per descrivere l'andamento dei fenomeni. Il modo in cui, con l'aumentare della longitudo, o lunghezza, aumenta o diminuisce la latitudo, o ampiezza di una figura, ci permette di valutare il grado dell'ampiezza e l'excessus graduum, ossia la misura in cui quel grado varia. Unendo i valori, che variano, per mezzo di una linea continua, si ottiene una curva che ci dà una rappresentazione grafica del variare di una grandezza in dipendenza dal variare di un'altra (in particolare, dal passare del tempo): ossia, di quella che sarà detta una "funzione". Nicola d'Oresme non sviluppa tutte le possibilità che questo metodo offre, ma la novità che introduce è estremamente importante: la rappresentazione grafica non si presta più, ormai, soltanto a esprimere una traiettoria spaziale, bensì anche la legge di una andamento temporale, e la matematica si avvia, così, a divenire lo strumento, non più soltanto di una descrizione statica delle cose, bensì di una determinazione quantitativa esatta dello stesso divenire.
La matematica e la scienza del divenire
La scienza, da Platone in poi, era sempre stata concepita come conoscenza di un oggetto che "è sempre a un modo", che non muta, che non è soggetto alle variazioni accidentali dell'esperienza. E la matematica, nella sfera ideale, era sempre stata considerata il prototipo di questa scienza dell'immutabile. A un certo punto, senza che questa concezione venga meno, si scopre che, attraverso queste relazioni in sé stesse immutabili, si può tuttavia afferrare, nel conoscere scientifico, la stessa mutabilità del divenire. La "separatezza" della sfera ideale dalla sfera empirica, che già era stata la spina dell'ultimo Platone, e poi era stata criticata aspramente da Aristotele, attraverso la scienza esatta del divenire è superata, in un modo che, per certi aspetti, va oltre le speranze di Platone medesimo. Ciò si potrò constatare compiutamente solo nella scienza del Seicento. Ma già sul finire del Medioevo comincia a venire in luce questo nuovo corso, che sarà il corso tipico della scienza moderna.
Domande da interrogazione
- Qual è l'importanza dell'occamismo parigino nel Trecento?
- Qual è il contributo di Giovanni Buridano alla scienza?
- In che modo Nicola d'Oresme ha influenzato la matematica e la scienza?
- Come ha cambiato la concezione della scienza il nuovo corso iniziato nel Medioevo?
L'occamismo parigino nel Trecento ha favorito lo studio scientifico della natura attraverso la "conoscenza intuitiva", trascurando la metafisica per concentrarsi sul comportamento fenomenico del reale.
Giovanni Buridano ha contribuito con gli studi sull'impetus, un passo avanti verso il principio di inerzia, concependo l'impeto come una "forza impressa" che fa ruotare i cieli.
Nicola d'Oresme ha introdotto l'uso di coordinate geometriche per descrivere fenomeni, anticipando di due secoli Descartes, e ha reso possibile la rappresentazione grafica di leggi temporali, avviando la matematica verso una determinazione quantitativa del divenire.
Il nuovo corso ha superato la "separatezza" tra la sfera ideale e quella empirica, permettendo di afferrare la mutabilità del divenire attraverso relazioni immutabili, anticipando la scienza moderna del Seicento.

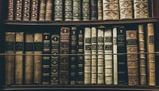





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo