Concetti Chiave
- Leucippo, vissuto nel VI secolo a.C., è considerato il padre dell'atomismo, con il suo pensiero spesso associato a quello di Democrito di Elea.
- Gli atomi, impercettibili ai sensi, possono essere compresi solo dall'intelletto, distinguendosi dalla visione platonica ma attribuendo un ruolo fondamentale al Nous.
- Le differenze qualitative percepite derivano dalle combinazioni quantitative degli atomi, che di per sé sono privi di qualità e vicini all'Essere parmenideo.
- Gli atomi sono dotati di movimento intrinseco che causa l'aggregazione e disgregazione delle cose, introducendo un radicale meccanicismo.
- Il meccanicismo atomistico influenzerà l'Epicureismo e sarà ripreso durante la Rivoluzione scientifica come teoria esplicativa della natura.
Leucippo e l'atomismo
Di Leucippo, vissuto nel VI secolo a.C., abbiamo solo scarse notizie: egli è considerato il padre dell’atomismo, il suo pensiero, si ritiene, può essere assimilato a quello di Democrito di Elea, suo discepolo, certamente ben più noto: sotto il suo nome, diversamente dal maestro, ci sono numerosi scritti, che rappresentano oggi il corpus lasciato dagli atomisti.
Il ruolo dell'intelletto
Per la loro struttura non possono essere percepiti dai sensi, ma colti soltanto dall’intelletto (visione che, pur distinguendosi dalla prospettiva platonica, già attribuisce un ruolo decisivo alla dimensione dell’intelletto, lo stesso che poi Platone definirà Nous). Al contrario, le differenze qualitative percepite dai sensi e riscontrabili nelle cose sensibili (a cui Parmenide negava l’esistenza) sono il risultato di combinazioni di queste connotazioni quantitative (mentre l’atomo è singolarmente privo di qualità). Proprio questa indifferenziazione qualitativa rende gli atomi, rispetto ai princìpi degli altri fisici, paradossalmente più vicini all’Essere parmenideo (in sé indifferente alla materia).
Movimento e meccanicismo
Gli atomi sono originariamente dotati di movimento e conseguentemente non hanno nessuna causa che li muova, è il loro movimento a causare l’aggregazione e la disgregazione, il nascere e il morire delle cose: sembra qui già affermato quel radicale meccanicismo che verrà ripreso nell’ellenismo con l’Epicureismo (che, introducendo la teoria del clinàmen, ne modificherà sostanzialmente la natura, posto a fondamento della libertà dell’uomo, grazie alla quale l’uomo può essere ed in seguito aspirare alla felicità) e si affermerà più tardi nella Rivoluzione scientifica del Seicento, dove diviene la teoria esplicativa della natura come organo oggettivo.

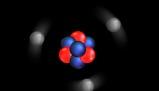





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo