Concetti Chiave
- Il conte Ugolino della Gherardesca, sebbene ghibellino, si alleò con il genero guelfo Giovanni Visconti per difendere i loro interessi in Sardegna.
- Dopo la sconfitta nella battaglia della Meloria contro Genova, Ugolino ottenne pieni poteri e cercò di rompere l'alleanza di Genova con Firenze e Lucca cedendo alcuni castelli.
- Durante il governo di Ugolino e Nino Visconti a Pisa, furono fatte concessioni al guelfismo e ai ceti popolari, mantenendo però una politica essenzialmente ghibellina.
- Nel 1288, l'arcivescovo Ruggieri riuscì a imprigionare Ugolino e i suoi familiari, che furono lasciati morire di fame in carcere.
- Dante rappresenta Ugolino e Ruggieri nell'Inferno, sottolineando i loro tradimenti reciproci e usando l'episodio per evidenziare un male generale piuttosto che la colpa individuale.
La figura di Ugolino
Il conte Ugolino della Gherardesca era, nella giovinezza di Dante, uno dei personaggi più in vista della vita politica toscana. La politica di lui non fu lineare, e anche gli storici moderni hanno motivi di perplessità. Ghibellino per famiglia e per posizione personale, egli era però naturale alleato di suo genero, il guelfo Giovanni Visconti, nella difesa, contro il comune ghibellino di Pisa, dei possessi che ambedue avevano in Sardegna; banditi dalla città, la Lega guelfa li protesse. bene impose il richiamo in patria.Nella difficile situazione creata dalla sconfitta nella battaglia della Meloria contro Genova, Ugolino ebbe i pieni poeti: probabilmente per rompere l'alleanza di Genova con Firenze e Lucca, assai pericolosa per Pisa, cedette alcuni castelli alle due città toscane. Appena assunto il potere, si era associato al governo il nipote Nino Visconti, guelfo come suo padre Giovanni; pare che durante il loro quadriennale governo la politica generale di Pisa restasse essenzialmente ghibellina; ma è certo tuttavia che essi fecero molte concessioni al guelfismo e ai ceti popolari.
Aspetti storici
Il partito ghibellino e nobiliare, capeggiato dall'arcivescovo Ruggieri, mordeva il freno, e nel 1288, mentre Ugolino era lotto dalla città, riuscì a scacciarne Nino. Il nonno non l'aiutò, anzi cercò di accordarsi con l'arcivescovo; rientrò in città sicuro di riprendere il potere, ma l'arcivescovo lo fece imprigionare insieme coi figli Gaddo e Uguccione e i nipoti Nino detto il Brigata e Anselmuccio, figli d'un altro figlio o di due figli di Ugolino. Tenuti in carcere per circa 9 mesi, i cinque furono alla fine lasciati morire di fame. Secondo una versione dei fatti che Dante sembra seguire, l'arcivescovo avrebbe tradito il conte, attraendolo in Pisa con la prospettiva di accordi, e facendolo invece imprigionare.Dante condanna tutto questo groviglio di mutui odi e tradimenti, veri o creduti tali, ficcando in una stessa buca i due principali antagonisti, Ugolino e Ruggieri; esclude il terzo personaggio principale di quelle vicende, Nino Visconti, e anzi gli dedicherà un lungo affettuoso episodio nel Purgatorio, colà compiacendosi di vederlo salvo, no tra i dannati, cioè esplicitamente negando la responsabilità di lui in quegli avvenimenti pisani. Quanto agli altri due, poiché il poeta sembra lasciare impregiudicata la questione circa la cessione dei castelli, e quindi del tradimento della patria di cui si sarebbe reso colpevole Ugolino, dato che lo colloca in questa zona di Cocito, è da pensare che rimproverasse al conte la sua defezione dal partito ghibellino.
All'arcivescovo imputa certamente, oltre la sua politica generale di continui mutamenti di fronte, per la quale è punito nel ghiaccio insieme gli altri traditori della patria e del partito, lo specifico tradimento consumato contro Ugolino: il traditore dal traditore tradito, come lo chiama, echeggiando Dante, Giovanni Villani, ha pertanto una pena supplementare: il nemico mangia il suo teschio.
Tuttavia i tradimenti dell'uno e dell'altro sono il presupposto dell'episodio, ma non vi lasciano echi: essi non vi sono ricordati, come invece sono ricordati quelli dei dannati precedenti, e l'altro, poi, di Alberigo. Più che la responsabilità di singoli preme al poeta mettere in luce un male generale; l'episodio è la reazione morale di Dante maturo a un avvenimento che aveva suscitato l'orrore di lui giovane di 24 anni.
Domande da interrogazione
- Chi era il conte Ugolino della Gherardesca e quale ruolo aveva nella politica toscana?
- Quali furono le conseguenze della sconfitta nella battaglia della Meloria per Ugolino?
- Come si concluse il governo di Ugolino e Nino Visconti a Pisa?
- Come Dante rappresenta Ugolino e Ruggieri nella sua opera?
- Qual è il messaggio morale che Dante vuole trasmettere attraverso l'episodio di Ugolino?
Il conte Ugolino della Gherardesca era un personaggio di spicco nella politica toscana durante la giovinezza di Dante. Sebbene fosse ghibellino per famiglia, si alleò con il genero guelfo Giovanni Visconti per difendere i loro possessi in Sardegna.
Dopo la sconfitta nella battaglia della Meloria contro Genova, Ugolino ottenne pieni poteri e cercò di rompere l'alleanza di Genova con Firenze e Lucca, cedendo alcuni castelli a queste città.
Il governo di Ugolino e Nino Visconti a Pisa, sebbene ghibellino, fece concessioni ai guelfi e ai ceti popolari. Tuttavia, nel 1288, il partito ghibellino guidato dall'arcivescovo Ruggieri riuscì a scacciare Nino e imprigionare Ugolino e i suoi familiari, che morirono di fame.
Dante colloca Ugolino e Ruggieri nella stessa buca dell'Inferno, condannando i loro tradimenti reciproci. Ugolino è punito per la sua defezione dal partito ghibellino, mentre Ruggieri è punito per il tradimento contro Ugolino.
Dante utilizza l'episodio di Ugolino per evidenziare un male generale, piuttosto che la responsabilità di singoli individui. L'episodio riflette la reazione morale di Dante maturo a un evento che lo aveva profondamente colpito da giovane.

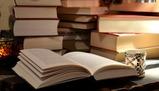





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo