Concetti Chiave
- Il romanzo "Giacinta" di Capuana esplora il dialogo tra la protagonista e il dottor Follini, riflettendo la poetica naturalista e verista.
- Capuana adotta lo stile dell'impersonalità, evitando commenti diretti e lasciando che i personaggi esprimano la loro complessità interiore.
- Giacinta, la protagonista, vive un conflitto interiore tra apparenza e realtà, dovuto a un trauma infantile e a pressioni sociali.
- Il dottor Follini rappresenta l'approccio scientifico positivista, studiando Giacinta con distacco per comprendere le cause della sua nevrosi.
- Capuana riscrive il romanzo per rispettare il principio dell'impersonalità, concentrandosi sui nudi fatti e sugli elementi determinanti della personalità.
Indice
Un medico e la sua paziente
Analizziamo una pagina molto significativa di Giacinta, romanzo d’esordio di Capuana: il colloquio tra la protagonista e il dottor Follini, che indaga su di lei per curiosità scientifica. Il testo è tratto dalla prima edizione (1879) dell'opera.
Uno specchio della poetica naturalista e verista
Il testo rivela due elementi tipici della narrativa naturalista e verista: da una parte, la fiducia nella scienza, qui incarnata dal personaggio del dottor Follini (è lui a studiare lo strano caso della protagonista Giacinta); dall’altra, la rinuncia del narratore a interventi diretti (commenti, giudizi ecc.), in ossequio al principio dell’impersonalità.
Le contraddizioni di Giacinta
Capuana è interessato soprattutto ad analizzare il mondo interiore di Giacinta. La donna apparentemente è piena di vita («Una sera la Giacinta pareva allegrissima. La sua allegria scoppiettava», r. 23), ma in realtà soffre di una segreta, profonda ossessione (la gelosia, qui non dichiarata, per l’amante Andrea). In certi momenti non è ben padrona di se stessa («la sua lingua era legata, la sua mente si distraeva, i suoi pensieri diventavano incoerenti», rr. 29-30); perciò, rendendosi conto del proprio stato, nelle ultime righe che abbiamo letto chiede l’aiuto del medico.
Il modello del dottor Follini
Capuana cerca d’illuminare le zone della psiche di Giacinta che restano in ombra. Si identifica con il dottor Follini, convinto che «i nervi, il sangue, le fibre, le cellule» (gli elementi fisici, cioè) «non spiegavano tutto nell’individuo» (rr. 3-4). Il medico incarna il perfetto modello dello scienziato positivista: pur dotato di profonda umanità, si accosta alle sofferenze psichiche di Giacinta con un atteggiamento obiettivo e distaccato («Per quanto grande fosse la simpatia ispiratagli dalla Giacinta, egli conservava rimpetto a lei la sua freddezza scientifica», rr. 13-14). Segue per questo un preciso metodo investigativo: interessato ad accertare la natura della malattia della donna e le cause che hanno concorso a generarla, esamina con rigore gesti, parole e azioni della protagonista. Oltre che ottimo scienziato, dunque, il dottor Follini è anche l’immagine perfetta di ciò che dovrebbe essere, secondo Capuana, il narratore verista: un ricercatore scrupoloso e neutrale.
Lo stile della narrazione
Lo scopo di verità che ispira Capuana dà forma anche allo stile. Assumendo il punto di vista del medico (focalizzazione interna) e lasciando a questo personaggio il compito di esprimere riflessioni e commenti sulla vicenda della protagonista, il narratore cerca di mantenersi in disparte, di restare nascosto e pressoché inavvertibile da parte del lettore. I dialoghi assumono qualche volta la forma del discorso diretto libero, cioè con battute non introdotte da verbi dichiarativi né accompagnate da commenti: si ottiene così quell’effetto di presa diretta, di realtà dal vivo, che è tipico della narrativa naturalista.

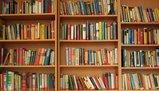





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo