Concetti Chiave
- Il Neorealismo è un movimento letterario italiano degli anni 1940-55, influenzato da eventi storici come la guerra, la Resistenza e la ricostruzione post-bellica.
- Centrale nel Neorealismo è l'impegno politico degli intellettuali, che si oppongono alla letteratura del passato accusata di connivenza col fascismo.
- Il movimento si caratterizza per un ritorno al realismo ottocentesco, rifiutando il soggettivismo della letteratura ermetica per concentrarsi su temi concreti e collettivi.
- Neorealisti utilizzano un linguaggio nuovo e anti-letterario, ricco di elementi dialettali e gergali, per esprimere valori sociali e umani delle classi popolari.
- Il Neorealismo si manifesta in vari ambiti, tra cui cinema e letteratura, con esponenti come Cesare Pavese, Elio Vittorini e Italo Calvino.
Il Neorealismo
Il termine neorealismo indica oggi un’esperienza letteraria che ha caratterizzato gli anni 1940-55 e che trova i suoi presupposti nelle condizioni venutesi a creare In Italia negli anni della guerra e del dopoguerra. Questo movimento fu infatti il frutto delle esperienze storiche di quel periodo: la guerra, la Resistenza, l’occupazione straniera, gli anni duri e difficili della ricostruzione. Questi eventi portavano infatti gli scrittori a proclamare, per l’intellettuale, la necessità dell’impegno politico e, al tempo stesso, a pronunciare una decisa condanna verso la letteratura precedente, accusata di aver collaborato col fascismo o di averlo subito passivamente.Centrale nella poetica dei neorealisti è dunque il concetto di impegno, che implicava la necessità di scelte politiche nette e di una responsabile e attiva partecipazione alle vicende della storia. Questa nuova concezione della letteratura e dell’arte, intese come mezzo di indagine della condizione umana e come contributo alla risoluzione dei problemi concreti della società, diede un nuovo volto e un nuovo prestigio allo scrittore italiano. L’esigenza dell’impegno spinge gli scrittori ad avvicinarsi ai partiti di sinistra: scaturisce qui l’egemonia dell’ideologia marxista sul mondo intellettuale. Un’incidenza determinante ha il pensiero gramsciano, che proprio in quegli anni viene alla luce con la pubblicazione dei “Quaderni del carcere”; in particolare esercitano forte suggestione le esigenze, poste dal pensatore comunista, di una letteratura nazional-popolare e della figura di un intellettuale organico alle masse popolari e ai partiti che le rappresentano.
Cosa rappresenta il Neorealismo
Il neorealismo non è una scuola, ma piuttosto uno stato d’animo diffuso, in cui si trovano a convergere molti intellettuali. Come suggerisce anche lo stesso termine, si tende a recuperare i modelli realistici dell’Ottocento, che la letteratura decadente e primo novecentesca aveva abbandonato. Al soggettivismo della letteratura ermetica si oppone un bisogno di oggettività: lo scrittore non vuol più mettere in primo piano il suo io, ma lasciar parlare direttamente le cose, fornire documenti e testimonianze. La scelta del realismo è legata proprio alla necessità di affrontare temi concreti che riguardano la collettività, quali il dramma della guerra e la tragedia della Shoah. La narrativa neorealista mette al centro i personaggi appartenenti alle classi operaie. Per quanto riguarda il linguaggio, utilizzano un linguaggio nuovo, fortemente anti-letterario, che da un lato rappresentasse il modo di esprimersi delle classi popolari, dall’altro potesse esprimere nuovi valori umani e sociali; nella maggior parte dei casi, ciò si risolse nell’inserimento di elementi dialettali e gergali nella lingua tradizionale.Il neorealismo riguardò ambiti diversi, dal cinema alla narrativa, dalle arti figurative alla poesia. In ambito letterario, l’esperienza neorealista può essere scandita in tre momenti: il primo, caratterizzato dai precursori, Moravia, Bernari e Silone; il secondo, segnato dalla pubblicazione delle opere propriamente neorealiste; il terzo, dopo il 1955, che è caratterizzato dalla crisi della corrente.
Nel corso degli anni 50, infatti, si manifestano i segni dell’esaurimento del neorealismo. All’inevitabile logoramento interno delle forme letterarie si aggiungono fattori esterni: la fine degli entusiasmi e delle speranze di rinnovamento civile propri dell’immediato dopoguerra, la crisi delle sinistre, la nascita di problemi nuovi che richiedono nuovi strumenti conoscitivi ed espressivi.
Tra i maggiori esponenti del Neorealismo abbiamo: Cesare Pavese, Elio Vittorini, Alberto Moravia, Beppe Fenoglio, Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini, Primo Levi.
Domande da interrogazione
- Quali sono le origini storiche del Neorealismo?
- Qual è il concetto centrale nella poetica dei neorealisti?
- Come si differenzia il Neorealismo dalla letteratura precedente?
- Quali sono le caratteristiche linguistiche del Neorealismo?
- Chi sono alcuni dei principali esponenti del Neorealismo?
Il Neorealismo nasce dalle esperienze storiche della guerra, della Resistenza, dell'occupazione straniera e della ricostruzione in Italia tra il 1940 e il 1955.
Il concetto centrale è l'impegno politico e sociale, con una partecipazione attiva alle vicende storiche e una condanna della letteratura precedente.
Il Neorealismo si oppone al soggettivismo della letteratura ermetica, promuovendo l'oggettività e il realismo per affrontare temi concreti e collettivi.
Il Neorealismo utilizza un linguaggio anti-letterario, con elementi dialettali e gergali, per rappresentare l'espressione delle classi popolari e nuovi valori sociali.
Tra i principali esponenti ci sono Cesare Pavese, Elio Vittorini, Alberto Moravia, Beppe Fenoglio, Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini e Primo Levi.

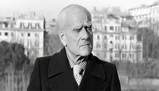





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo