Concetti Chiave
- Il sonetto "Voi ch'ascoltaste in rime sparse il suono" di Petrarca funge da introduzione al Canzoniere e riflette il suo conflitto interiore e il pentimento per l'amore giovanile per Laura.
- Petrarca si rivolge a chi ha sperimentato l'amore, chiedendo comprensione e perdono per il suo passato, riconoscendo la fugacità dei piaceri terreni.
- Il sonetto si caratterizza per un linguaggio ricco e una struttura complessa, con allitterazioni e un uso sapiente del chiasmo, che riflettono la profondità dei sentimenti del poeta.
- Temi principali includono lo scorrere del tempo, il conflitto interiore, e la riflessione sulla vanità delle cose terrene, influenzati da fonti bibliche e classiche.
- La figura di Laura rappresenta un amore platonico e idealizzato, attraverso cui Petrarca esplora le sue aspirazioni e il suo dissidio tra amore terreno e spirituale.
Indice
- Voi ch'ascoltaste in rime sparse il suono di Petrarca
- Voi ch'ascoltaste in rime sparse il suono, analisi
- Voi ch'ascoltaste in rime sparse il suono, parafrasi
- Voi ch'ascoltaste in rime sparse il suono, descrizione
- Voi ch'ascoltaste in rime sparse il suono, spiegazione
- Voi ch'ascoltaste in rime sparse il suono, riflessioni
- Voi ch'ascoltaste in rime sparse il suono: altri aspetti
Voi ch'ascoltaste in rime sparse il suono di Petrarca
Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono
di quei sospiri ond'io nudriva 'l core
in sul mio primo giovenile errore
quand'era in parte altr'uom da quel ch'i' sono,
del vario stile in ch'io piango e ragiono
fra le vane speranze e 'l van dolore,
ove sia chi per prova intenda amore,
spero trovar pietà, nonché perdono.
Ma ben veggio or sì come al popol tutto
favola fui gran tempo, onde sovente
di me medesmo meco mi vergogno;
e del mio vaneggiar vergogna è 'l frutto,
e 'l pentersi, e 'l conoscer chiaramente
che quanto piace al mondo è breve sogno.
Parafrasi 1: Voi che ascoltate in poesie staccate tra di loro il suono di quei sospiri con i quali nutrivo il cuore al tempo del primo traviamento giovanile, quando in parte ero un altro uomo rispetto a quello che sono, delle varie forme poetiche nelle quali piango e ragiono tra le vane speranze e il vano dolore, spero di trovare pietà, non solo perdono, dove ci sia qualcuno che conosca l'amore per averlo provato.
 Ma vedo ormai come fui per tutto il popolo motivo di riso da gran tempo, per cui spesso mi vergogno di me stesso; e il frutto del mio amore impossibile è la vergogna, il pentimento e la chiara consapevolezza che tutto quello che piace al mondo è vano.
Ma vedo ormai come fui per tutto il popolo motivo di riso da gran tempo, per cui spesso mi vergogno di me stesso; e il frutto del mio amore impossibile è la vergogna, il pentimento e la chiara consapevolezza che tutto quello che piace al mondo è vano.Parafrasi 2: Voi che ascoltate, espressi in componimenti slegati tra loro,
il suono di quei sospiri che alimentavano la mia passione amorosa
al tempo del mio primo traviamento amoroso giovanile
quando ero, seppur in parte (traccia di quella passione permane ancora) un altro uomo rispetto a quello che sono ora:
spero di trovare comprensione, nonché perdono,
del mutevole stile con cui esprimo la mia sofferenza e parlo
oscillando tra le vane speranze e il vano dolore (vani perché terreni).
ovunque vi sia qualcuno che, avendolo provato, sappia cosa sia Amore.
Ma ora mi rendo ben conto di come fui per molto tempo una favola
per tutta la gente ignorante, visto che
io stesso mi vergogno di me,
e del mio perdermi dietro a cose vane sono conseguenze
il vergognarmi, il pentirmi e il capire chiaramente
che quanto piace nella vita terrena non è altro che una breve illusione.
Analisi del testo: Il giudizio di Petrarca è estremamente negativo perché il Canzoniere testimonia l'oscillazione di sentimenti e il dissidio interiore del poeta. Inoltre, egli riponeva le speranze di gloria nelle opere in latino e non in quelle in volgare. Petrarca, nel Canzoniere, ha una concezione dell'amore terrena e si sofferma non tanto sulla lode di Laura quanto sui propri sentimenti, e in questo prende spunto da Cavalcanti. Inoltre, la concezione della vanità delle cose era già presente in una fonte biblica, l'Ecclesiaste. Nel passato è un giovane che ha perso la retta via mentre, nel presente, è un uomo pentito, anche se ancora innamorato. Petrarca ha una concezione dell'amore terrena. Nel sonetto Padre del ciel, dopo i perduti giorni, Petrarca, oltre ad essere pentito dei suoi gravi errori giovanili, prega Dio affinché lo liberi dal peccato e gli confessa le proprie colpe.
Nel sonetto “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” il poeta parla dell’esperienza amorosa ormai superata nella prospettiva cristiana (il pentimento, la coscienza della brevità e della illusorietà dei beni terreni).
Il poeta offre al lettore quattro tipi di informazioni:
- sono stato a lungo innamorato
- ora sono cambiato
- chiedo pietà e perdono
- (l’unico non esplicito) sono degno di riceverli.
Egli si rivolge a coloro (Voi), che, come lui, soffrono le pene dell’amore e spera di trovare in loro perdono e comprensione (spero trovar pietà, nonché perdono – di me medesimo che meco mi vergogno) poiché, a causa di questo sentimento, frutto di uno sbaglio giovanile (giovanile errore) egli era ben diverso dall’uomo che è oggi (quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’ sono). Non solo ha commesso un errore morale, mettendo da parte Dio, ma anche un errore letterario, visto che ha fatto produrre dei componimenti slegati fra loro (Rime sparse) che esprimono sentimenti contrastanti, frutto di diversi stati d’animo.
Nel proemio troviamo termini specifici della materia amorosa (sospiri e core al v. 2, piango et ragiono al v. 5, speranze e dolore al v.6, amore al v. 7). Ma vi sono però nel sonetto anche alcuni riferimenti alla prospettiva cristiana, quali il richiamo alla trasformazione dell’individuo(v.4), che allude implicitamente al tema della conversione (con rimando alla vergogna ai v. 11e12), il motivo della inutilità e della illusorietà dei beni terreni (errore al v. 3, vane/van al v. 6, favola al v. 10).
Lo stesso tema si delinea nel sonetto “Io mi rivolgo indietro” in cui il poeta si paragona ad un viandante che, piangendo, si volge indietro e sospirando procede, proprio come un innamorato che è costretto ad abbandonare il suo amore.
Ne “Era il giorno ch’al sol si scoloraro” il poeta ripensa invece al giorno in cui si innamorò di Laura, giorno di commemorazione dellla morte di Cristo.
La coincidenza tra l’innamoramento e il giorno della Passione suggerisce il significato attribuito da Petrarca alla propria vicenda amorosa: un traviamento morale.
Dominatrice al centro dell’esistenza di Petrarca vi è una donna, Laura; ma, mentre per Dante l’amore per Beatrice è un punto di partenza, per giungere a una visione religiosa del mondo, alla fede in Dio, Laura resta una donna, amata per la sua bellezza, per il fascino dei suoi occhi, delle chiome bionde, delle mani sottili, del bel fianco (Chiare, fresche et dolci acque). Ad attirare Petrarca è la terra con tutte le sue seduzioni. Nella “Vita Nova” i segni che accompagnano la morte di Beatrice sono gli stessi che accompagnano la morte di Gesù: con questo Dante sottolinea il misticismo della donna. In Petrarca invece l’amore per la donna e l’immagine di Cristo sono in opposizione, anzi l’amore è di ostacolo alla salvezza (Era il giorno ch’al sol si scoloraro).
Questo concetto di amore che fa scaturire tutte le più basse passioni dell’animo è ripreso anche nel terzo libro del Secretum dove Agostino, con abili argomentazioni, fa confessare a Petrarca di aver amato la bellezza fisica di Laura e che questo amore è stato origine di traviamento.
Petrarca nel sonetto “Padre del ciel, dopo i perduti giorni” rivolge a Dio una preghiera nel quale lo supplica di perdonarlo per essere stato preda dell’amore. In questo sonetto l’amore è definito come un fero desio mentre nel “Benedetto sia’l giorno, e’l mese, et l’anno” viene addirittura benedetto. Queste sono le alternanze di sentimenti alle quali alludeva il poeta in “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”.
Il poeta chiede a Dio di farlo ritornare ad una vita degna di modo che il demonio, suo avversario, resti sconfitto.
In “Chiare, fresche et dolci acque” il poeta descrive Laura che aveva visto in quegli stessi luoghi utilizzando molti termini della bellezza stilnovista (bionda, occhi luminosi, voce soave, capelli d’oro, viso di perla….). Qui, la bellezza di Laura, che è tutt’uno con le meraviglie del paesaggio avvicina il poeta, invece, in “ A qualunque animale alberga in terra” sono le stesse virtù della donna ad allontanarlo.
La donna è anche occasione per parlare ed esplorare se stessi, per affrontare problematiche teologiche. Nel Secretum Agostino mira a liberare l’animo di Francesco da due errori pericolosi: l’amore per la gloria e l’amore per Laura.
Nel terzo libro Francesco si difende sostenendo che il suo amore è stato solo spirituale. Agostino, invece, lo induce a confessare che ha amato la bellezza fisica di Laura e che questo amore è stato origine di basse passioni. Anche nei sonetti “Io mi rivolgo indietro” e in “Solo et pensoso” sono affrontate le tematiche del tormento esistenziale.
Decisivo appare nel Canzoniere il tema della memoria legato al tema della lontananza e alla fugacità del tempo. Nel sonetto “Io mi rivolgo indietro” vengono trattate entrambe le tematiche. La lontananza nel verso “io mi rivolgo indietro” e “poi ripensando al dolce ben ch’io lasso e la labilità del tempo nel “viver corto”.
Il rapporto con la donna, impossibile nella realtà, si costruisce nella assenza, affidato al potere rievocativo ed elaborativo.
La figura femminile assume spessore e prende concretezza anche fisica grazie al ricordo. Nel sonetto “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” Laura viene addirittura descritta mentre sta invecchiando. La bellezza è sfiorita, i capelli un tempo splendidi come la sua giovinezza si sono fatti più grigi e radi, gli occhi un giorno lampeggianti hanno conosciuto il tramonto. Tutto è diverso, sconvolto , distrutto; una cosa però resta immutabile perché non può morire: l’amore.
In questo sonetto il poeta si rivolge ad un pubblico ben specifico, ovvero a quelli che soffrono le pene dell'amore, presso il quale spera di trovare perdono e comprensione poiché a causa di questo sentimento, frutto di uno sbaglio giovanile, quando il poeta era ben diverso dall'uomo che è oggi, non solo ha commesso un errore dal punto di vista morale, mettendo da parte Dio, ma anche dal punto di vista letterario, visto che l'amore ha prodotto sotto quest'aspetto dei componimenti slegati fra loro e che esprimono sentimenti contrastanti, frutto di diversi stati d'animo del poeta. Dopodiché si rende conto che a causa del suo vaneggiar d'amore egli è divenuto la favola del popolo e quindi si vergogna di sé stesso e il frutto del suo amore è la vergogna stessa. Il sonetto si conclude con la presa di coscienza che tutto ciò che c'è di terreno è vano.
Ecco i topoi presenti nella poesia (se il vostro docente è fissato con questa roba!!):
Sospiri, topos che risale agli stilnovisti; solo alla vista della donna amata l'amante sospira.
Verso 11, in cui il Petrarca dice di essere la favola del popolo, già usato da Orazio nell'Epodo libro 11 versi 7-8
Il verso 14, in cui Petrarca afferma che tutto quello che è terreno è vano, esprime un concetto già definito nelle "Ecclesiaste".
Voi ch'ascoltaste in rime sparse il suono, analisi
Questo sonetto costituisce il proemio del Canzoniere: spiega quali argomenti verranno trattati, indica i personaggi presenti e le scelte linguistiche dell'autore.Probabilmente fu composto intorno al 1347, durante il secondo ordinamento delle opere della raccolta destinata al Canzoniere.
Il "VOI" che troviamo all'inizio del sonetto non coincide con l'espressione "POPOL TUTTO", ma si riferisce solamente a coloro che hanno provato le emozioni e le sensazioni provocate dall'amore e che, di conseguenza, sono in grado di comprendere e apprezzare la poesia.
L'autore con l'uso di questi termini sembra voglia dare spiegazioni per le scelte fatte durante la scrittura della sua opera, alla quale attribuisce scarsa importanza.
"RIME SPARSE"= Petrarca vuol dire che le sue opere parlano di vari argomenti.
"VARIO STILE"= le poesie sono state scritte con uno stile che rispecchia lo stato d'animo del poeta al momento della composizione.
L'io narrato e l'io narrante coincidono perchè il sonetto riassume sia la sua vita passata che quella presente.
Il sonetto racchiude in sè tutta la vita dell'autore, i suoi sentimenti, e le sue esperienze (compresa quella dell'amore per una donna, nonostante ciò non gli fosse permesso).
L'ultimo verso del sonetto spiega che ogni cosa è destinata a finire e questo vale anche per la vita, quindi non vale la pena di trascorrerla alla ricerca di piaceri terreni.
Il testo in questione è un sonetto, composto da due quartine e due terzine di versi endecasillabi:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +1
(VOI) (CH'AS) (COL) (TA) (TE IN) (RI) (ME) (SPAR) (SE IL) (SUO) (NO)
Lo schema delle rime nelle quartine è ABBA ABBA, mentre nele terzine è CDE CDE.
Troviamo allitterazioni come:
- la ripetizione della lettera F ["Favola fui..."]
- la ripetizione della lettera M [...Me medesimo meco mio..."]
- la ripetizione della lettera V ["...Vaneggiar vergogna..."]
Le quartine presentano una particolare costruzione sintattica detta "chiasmo": nella prima quartina i pensieri sono scritti seguendo il rigore ordine degli elementi (soggetto, verbo, ...) mentre nella seconda troviamo la stessa costruzione speculare: per riordinare il pensiero è necessario partire dall'ultimo verso della quartina e concludere col primo. Nonostante questa struttura sia intricata, la sensazione trasmessa non è irrequieta perché tutto è stato studiato e predisposto secondo criteri ben definiti.
La sintassi rispecchia il percorso dell'esame interiore.
Le terzine hanno un andamento più duro e secco rispetto alle quartine: questo cambiamento indica forse che avvengono nella vita e il tono più rigido rende l'idea delle difficoltà.
Nel testo troviamo una variazione dei tempi verbali, dal tempo passato (nudriva, era, fui...) al presente (sono, veggio, mi vergogno, è...).
Nei versi 5-6 possiamo individuare un chiasmo tra le parole PIANGO-RAGIONE e SPERANZA-DOLORE. Sono fortemente contrapposte, ma la loro posizione nel testo permette di ricostruire il verso collegato ogni parola con quella sottostante:
PIANGO va abbinata a DOLORE, mentre RAGIONO va abbinata a SPERANZA.
Petrarca, durante una Messa tenutasi in periodo di Pasqua (probabilmente il 6 aprile del 1326) incontra e si innamora di una donna: Laura.
QUesto amore nasce e cresce attraverso sguardi e poesie che l'autore dedica a lei. Per tale motivo possiamo definire l'amore tra i due esclusivamente platonico.
Riguardo a questa donna non conosciamo nulla, se non l'aspetto fisico: è alta, bionda, occhi azzurri, tutti elementi che suggeriscono l'idea di una donna fortemente stereotipata, evidenziando probabilmente quali caratteristiche dovesse avere la donna ideale a quei tempi.
Analizzando il suo nome (LAURA), si può però attribuire a questa figura femminile un significato differente: la si può infatti associare alla laurea tanto desiderata da Petrarca.
questo non è l'unico significato: si può fare riferimento ai testi delle metamorfosi di Ovidio, molto conosciute all'epoca.
Per concludere si può notare che, come ha fatto Dante Alighieri con Beatrice, Petrarca identifica in Laura l'oggetto a cui tanto aspira per tutta la vita e continua a descriverla nel corso degli anni senza però evidenziare alterazioni fisiche e mantenendo alto il suo valore.
Voi ch'ascoltaste in rime sparse il suono, parafrasi
Voi che ascoltate in queste rime il suon dei miei sospiri dei quali nutrivo il mio cuore.al tempo del mio primo errore giovanile quand'ero in parte un uomo diverso da quello che sono ora spero di trovare pietà e perdonare per il vario stile nel quale mi lamento e ragiono oscillando tra speranze e sofferenze se c'e chi sa, per averlo provato, che cos'è l'amore, ma per tutti fui oggetto di discorsi di risate di cui con me stesso tra a me e me il risultato del mio errore amoroso e la vergogna dopo il pentimento e la vergogna di viene la consapevolenza che i beni terreni durano poco.
Voi ch'ascoltaste in rime sparse il suono, descrizione
Scritto probabilmente intorno al 1350, subito dopo la mutatio animi e in concomitanza con la decisione di raccogliere le opere dedicate a Laura in un unico libro, Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono è l'incipit, il sonetto introduttivo del Canzoniere di Francesco Petrarca.Si apre con un "Voi" che può trarre in inganno, poichè rimane sospeso, privo di verbo, fino alla fine della seconda quartina, quando, con il verbo principale "spero",si rivela il vero soggetto della frase e dell'intero sonetto, lo stesso Petrarca.
Nelle quartine Petrarca si rivolge a quel pubblico che già era stato lettore, "in modo sparso", delle sue liriche giovanili dedicate a Laura. In questo sonetto, scritto, come si è già detto, successivamente alla mutatio animi, Petrarca considera già l'amore per la donna un errore, e sembra scusarsi con il suo pubblico per la varietà di versi che, a causa del suo cambiamento interiore, potrà essere riscontrata nel Canzoniere.
Nelle terzine c'è una presa di coscienza da parte del poeta del fatto di essere stato, insieme a Laura, oggetto di scherno per il "popol tutto", quindi per chiunque; a questa riflessione seguono quindi la vergogna e il pentimento per il suo "errore giovanile".
Il sonetto contiene già tutti i più innovativi temi principali del Canzoniere:
-lo scorrere del tempo;
-il conflitto interiore del poeta e la conseguente costante presenza di un "io" poetante;
-la generalizzazione dell'esperienza del poeta non come personale, ma come storia esemplare di un qualsiasi individuo.
Del Canzoniere, nel sonetto si può anche già riconoscere l'intera struttura: è diviso in due blocchi (nella poesia quartine e terzine), uno antecedente alla mutatio animi, che tratta dell'amore giovanile del poeta, l'altro successivo, sulla vergogna e il pentimento. Il "ma" all'inizio delle terzine rappresenta la mutatio animi.
Voi ch'ascoltaste in rime sparse il suono, spiegazione
Questo è il sonetto proemiale cioè funge da proemio, da introduzione per il canzoniere. Questo sonetto Petrarca lo inserisce come sonetto proemiale perché lui vuole offrire ai suoi lettori sin dall’inizio i termini di contrasto e di dissidio interiore entro cui la sua vicenda amorosa va collocata. Inoltre Petrarca definisce giovanile errore il suo amore per la donna e per questo chiede perdono. L’intero sonetto quindi si pone come una sorta di confessione e di autocondanna delle scelte dell’autore; è dunque del tutto naturale che i versi oscillino tra presente e passato. Petrarca ripercorre in queste rime la sua vicenda amorosa con Laura. La ricerca nella propria interiorità porta Petrarca a definire il tempo presente in parte diverso dal precedente: è il tempo della vergogna, da cui consegue il pentimento.Solo et pensoso i più deserti campi
Questa è un opera tratta dal canzoniere; qui il poeta cerca un luogo per rimanere solo per pensare e questo è il locus amoenus, in questo caso, rappresentato dai “monti e piaggie”. E quindi la natura sa i suoi tormenti, i suoi problemi come se fosse la sua consigliera, mentre gli altri uomini non sanno nulla.
perché Petrarca trasmette l’immagine dell’incontro simbolico con Dio. Questo è l’incontro con il numinoso cioè con la divinità che porta smarrimento all’uomo dato che l’incontro tra il finito e l’infinito gli porta dolore.
Voi ch'ascoltaste in rime sparse il suono, riflessioni
E' il primo sonetto dell' opera petrarchesca e funge da proemio alle altre 365 opere che seguono . Questo sonetto è stato composto nell'anno domini 1347, allorché Petrarca stava sistemando i nove ordinamenti del canzoniere fatti durante la sua vita, il cui ordinamento conclusivo risale a pochi mesi prima della morte del poeta.Questo sonetto contiene un tono pensoso e meditabondo, di riflessione, non su dio o sulla natura, bensi verso se stessi e verso gli animi degli altri. In questa poesia chiama l'amore il "giovanile errore" in quanto errore è una parola chiave del lessico di Petrarca che esprime il suo dissidio interiore.
è molto probabile che questo sonetto, inizialmente sia stato pensato come epilogo dell'opera,ma poi fu messo come introduzione.
C'è una chiara reminiscenza di Orazio, il quale scrive: "Non sum qualis eram" mentre Petrarca conclude con il verso: "spero di trovar comprensione, non che perdono del vario stile".
Voi ch'ascoltaste in rime sparse il suono: altri aspetti
Questo sonetto è contenuto nel “Canzoniere” ed è il primo, il che lo rende quasi una sorta di proemio. È stato composto abbastanza tardi, circa nel 1350 e posteriore alla morte di Laura.Lo schema metrico è ABBA ABBA CDE CDE. Il poeta parla, facendo risuonare tra i versi un certo pentimento verso la passione amorosa, di un bilancio sentimentale, che suggerisce anche una chiave di lettura sulla sua produzione poetica in volgare. La sua poesia si rivolge a tutti coloro che ascolteranno le parole presenti nella raccolta. Il poeta ci invita a comprendere il dramma d’amore e a perdonarlo.
La prospettiva amorosa appare superata nella prospettiva cristiana fatta di pentimento, coscienza della brevità e dell’illusorietà dei beni terreni. Sente di aver compiuto un giovenil error, che lo ha reso oggetto di chiacchere. Si pente per l’amore profuso per Laura, che definisce semplicemente un sogno fugace. Ci tiene a ribadire che quell’amore sia stato solo parte di una fase giovanile e che lui solo ora si senta realmente cambiato.
Notevole è la costruzione lirica, che ricalca decisamente uno stile elevato e ricercato e ci riporta alla mente anche qualche eco classicheggiante, precisamente riconducibile al Carme 8 del poeta latino Catullo.
Domande da interrogazione
- Qual è il tema principale del sonetto "Voi ch'ascoltaste in rime sparse il suono" di Petrarca?
- Come si presenta il conflitto interiore di Petrarca nel sonetto?
- Qual è la struttura metrica del sonetto e come contribuisce al suo significato?
- In che modo Petrarca si rivolge ai lettori nel sonetto?
- Qual è il significato del "giovanile errore" menzionato nel sonetto?
Il tema principale del sonetto è l'amore, in particolare l'amor cortese tipico dello stilnovismo, e il pentimento per gli errori giovanili legati a questo sentimento.
Petrarca esprime un conflitto interiore tra il passato, quando era innamorato e commetteva errori giovanili, e il presente, in cui prova vergogna e pentimento, riconoscendo la vanità dei piaceri terreni.
Il sonetto segue lo schema metrico ABBA ABBA CDE CDE, con quartine che introducono il tema dell'amore e terzine che riflettono il pentimento e la consapevolezza della vanità dei beni terreni.
Petrarca si rivolge ai lettori che hanno provato le emozioni dell'amore, sperando di trovare comprensione e perdono per i suoi errori giovanili e per la varietà di stili poetici che riflettono i suoi stati d'animo.
Il "giovanile errore" si riferisce all'amore giovanile di Petrarca per Laura, considerato un errore morale e letterario, che lo ha portato a trascurare Dio e a produrre poesie slegate e contrastanti.

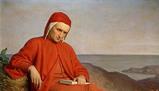





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo