Concetti Chiave
- Il letterato barocco si distingue dal cortigiano, cercando autonomia dall'influenza dei principi, mentre la Chiesa tenta di controllare le novità culturali emergenti.
- Le accademie barocche fungono da rifugio per intellettuali, offrendo uno spazio neutrale per lo scambio di idee, ma limitandone la diffusione all'interno del loro ambito.
- Nell'arte barocca, l'accento è posto sull'anomalia e sull'eccezione, con l'uso di simboli e metafore per esplorare e rappresentare il mondo complesso e sfuggente.
- Galileo Galilei rivoluziona la comunicazione scientifica con l'uso del volgare, rendendo la scienza accessibile e promuovendo un cambiamento di mentalità.
- Nel teatro barocco, la Commedia dell'Arte e il melodramma emergono come forme espressive che combinano elementi musicali, letterari e teatrali, raggiungendo un ampio pubblico.
Indice
- Il ruolo del letterato e del cortigiano
- La Chiesa e il controllo culturale
- Le accademie e il Barocco italiano
- Arte e simbolismo nel Barocco
- Innovazione e rottura nel Barocco
- Marino e la poesia barocca
- Antimarinismo e poesia classicista
- Tommaso Campanella e la poesia
- Politica e Chiesa nel 1600
- Galileo e la scienza nuova
- La novella e il teatro barocco
- Commedia dell'Arte e melodramma
- La questione della lingua nel 1600
Il ruolo del letterato e del cortigiano
La figura del letterato si distanzia da quella del cortigiano.
Il cortigiano rinascimentale si trasforma in segretario del principe, esecutore della sua volontà più che consigliere capace di interpretare la situazione. Il letterato aspira a svincolare la propria attività dalla protezione di un principe, cosa che risulta praticabile solo da pochissimi, come il Marino, che sono sorretti da una vasta reputazione che li porta da una corte all'altra. 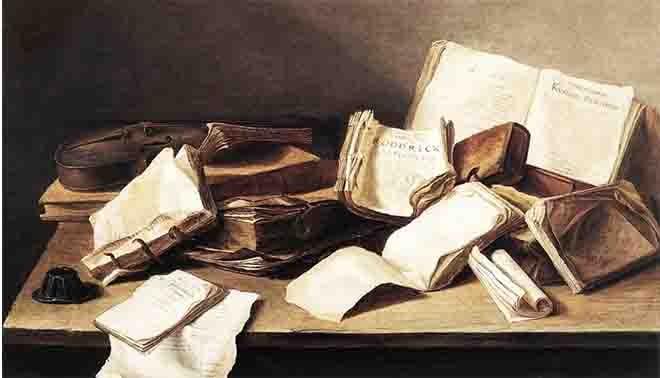 Nei primi secoli si vede sviluppare, spesso all'ombra delle corti, l'esperienza innovatrice della poesia barocca e Galilei tenta di divulgare le sue teorie con la complicità del granduca di Toscana e spera di superare la diffidenza della Chiesa
Nei primi secoli si vede sviluppare, spesso all'ombra delle corti, l'esperienza innovatrice della poesia barocca e Galilei tenta di divulgare le sue teorie con la complicità del granduca di Toscana e spera di superare la diffidenza della Chiesa
La Chiesa e il controllo culturale
La Chiesa è indirizzata con sempre maggior efficacia a controllare, far proprie e privare delle implicazioni più pericolose le novità culturali emerse in inizio di secolo. Le verità fondamentali vengono poste come irrinunciabili e non perfezionabili. La nascita di un mercato librario, retto da regole proprie, aveva offerto al letterato del 1500 una collocazione sociale nuova e per certi versi autonoma dai poteri tradizionali. Colpita da una crisi di sovrapproduzione, l'editoria italiana soffre delle restrizioni imposte dalla Chiesa, che si riserva il diritto di concedere l'imprimatur o di proibire la stampa delle singole opere oppure di operare tagli e correzioni. La Chiesa non si limita a perseguire gli autori delle opere che giudica pericolose ma condanna anche gli stampatori e i librai che contravvengono alle sue disposizioni. Mentre si riduce per tutto il secolo la pubblicazione di opere storiche e filosofiche, il 1600 vede una inattesa fioritura di opere letterarie e di romanzi in prosa. Il pubblico diventa ampio, di collocazione sociale medio-bassa. Galilei, ad esempio, decide di scrivere il suo Dialogo in Italiano, ampliando il numero dei possibili lettori, comprendendo categorie sociali che fino a quel momento erano tenute ai margini della conoscenza scientifica che doveva essere espressa solo in latino.
Le accademie e il Barocco italiano
Nel periodo del Barocco italiano le accademie erano piccole corti dotate di un loro cerimoniale, come organizzazioni che assicurano all'intellettuale il conforto di appartenere a un piccolo gruppo di pari, solidali e compatti per garantirsi a vicenda onore e reputazione spesso negati dalla realtà esterna. Nelle accademie i letterati trovano un luogo neutrale di confronto di idee e di comunicazione dei risultati delle loro attività e la circolazione delle idee resta limitata nel loro ambito
Arte e simbolismo nel Barocco
All'opposto dell'era rinascimentale, il barocco italiano scopre nel disegno ordinato della natura l'anomalia, l'eccezione, e su di essa concentra la sua attenzione. Non stupisce che, l'arte figurativa, preferisca alla riproduzione degli oggetti la finzione: le chiese barocche presentano volte affrescate in modo da suscitare la sensazione di uno spazio verticale potenzialmente infinito, che si identifica con il cielo. Dall'evidenza visiva dipende la dimostrazione della fondatezza delle scoperte celesti di Galilei. Come il cielo di Galilei, ogni aspetto della vita umana è sottoposto all'esame della vista e l'occhio del pittore barocco, come quello dello scienziato e del poeta, indaga zone del reale mai prima osservate e riprodotte. Soltanto il simbolo pare adatto a spiegare fenomeni sfuggenti; soltanto i collegamenti forniti dalla metafora a dall'allegoria permettono all'artista e al letterato di intuire ciò che i sensi e la ragione non sono più in grado di decifrare con sicurezza. La riflessione critica, nata dal contrasto tra sostenitori della classicità e difensori del primato della modernità, costringe lo scrittore del barocco in Italia a riconoscere il collegamento tra gli strumenti espressivi impiegati e la concezione del mondo. Ne deriva la necessità di adeguare la tecnica della scrittura alla concezione del mondo che lo scrittore scopre, esprime e propone al lettore. Nel barocco italiano, troviamo l'intrecciarsi strettissimo di razionalità e di fantasia, di riflessione e di creazione, di astrazione e di concretezza.
Innovazione e rottura nel Barocco
L'Italia è la prima a proporre in letteratura i primi esempi dell'innovazione barocca, che trova nella poesia la sua espressione più piena e caratteristica. Se il Manierismo aveva rappresentato l'inizio dello sgretolamento di un sistema di regole non più giustificato dall'esperienza di vita e dagli orientamenti profondi degli scrittori, il Barocco letterario nasce e si definisce come consapevole e volontaria rottura con quegli ideali di equilibrio e di composizione delle tensioni che la realtà generale del mondo rende sempre meno credibili e praticabili. Ciò che il polemista barocco non intende fare, per colpire il lettore con la spregiudicatezza dei modi, è non rispettare le regole del buongusto. I maggiori esponenti del poema barocco italiano furono Francesco Bracciolini, Girolamo Graziani, Alessandro Tassoni e Giovan Battista Marino.
Marino e la poesia barocca
Nel giustificare le proprie prese di posizione, Marino porta spesso l'argomento della svogliatezza dei lettori che li allontana dai testi tradizionali e li spinge ad acquistare invece le sue opere. Parlando dell'ossequio alle "regole" in una lettera inviata al poeta Girolamo Preti, Marino non si limita a negare che le regole abbiano validità eterna ma sottrae il giudizio sulla validità dell'opera ai critici per affidarlo ai lettori. Dei lettori, Marino, apprezza la quantità e non la qualità. La spregiudicatezza con cui Giovan Battista Marino persegue i suoi scopi gli assicura quel successo di pubblico che gli apre la strada alle corti più prestigiose e fa di lui il punto di riferimento obbligato di tutta l'ampia e variegata produzione poetica del secolo. Anche nella poesia d'amore l'urgenza della novità amplia la gamma delle raffigurazioni della donna, tradizionalmente ritratta un figurino bidimensionale con pochi tratti stereotipati (capelli biondi, occhi azzurri). Accanto alla bellezza della donna mediterranea, castana o nera, negra o orientale, il poeta barocco celebra donne che si segnalano per altri particolari come la vecchia, la sdentata, la zoppa, la balbuziente o la donna con gli occhiali. La donna è colta nei diversi atti della giornata, atti banali che il carattere generale aveva escluso dalla rappresentazione, così si trova ampio spazio agli oggetti legati alla donna che diventano preziosi dopo che l'attenzione del poeta si esercita per trasformarli, attraverso analogie e metafore, in particolari allusivi di mondi più ampi e distanti che si aprono, in uno scorcio precario, all'osservatore. Alla metafora, Tesauro, attribuisce una fondamentale funzione conoscitiva che pone questa figura retorica al centro dell'esperienza della poesia. La ricerca di una emozione attraverso un gioco intellettuale scoperto e compiaciuto è lo scopo che la poesia barocca persegue. I canzonieri del barocco in Italia non si presentano più come raccolte organiche di componimenti ma come una collezione di frammenti su cui l'intelligenza è chiamata ad appuntarsi in una ripetizione senza fine di occasioni di meraviglia e di emozione di fronte alla varietà del reale. La costruzione tipica del sonetto marinista vede lo sviluppo una incalzante serie di immagini suggerita dalla metafora iniziale di una serie di concetti che si conclude con una metafora di origine più ampio che serve a ribadire la condizione di sorpresa che ha dato avvio al componimento. Non c'è speranza di raggiungere un risultato definitivo, una definizione certa e stabile della realtà su cui basare una fondata morale di vita con personaggi che appaiono e scompaiono nel nulla come una serie di incalzanti videoclip televisivi.
Antimarinismo e poesia classicista
Apertamente antimarinista, risulta fortemente condizionata dalla novità sostanziale della situazione. L'esistenza di un partito moderato all'interno della poesia del seicento permise di evitare una frattura radicale tra il mondo della scienza e quello della letteratura, il che permetterà un riavvicinamento caratteristico del 1600 tra scienza e letteratura. La poesia classicista del 1600 rappresenta una variante dell'esperienza barocca più che una realtà opposta a questa.
Tommaso Campanella e la poesia
Nel barocco italiano è la poesia potente e oscura del frate Tommaso Campanella. In lui la tensione intellettuale e il rigore morale fanno della metafora lo strumento che illumina l'uomo del suo progredire verso la costruzione di un mondo nuovo, in cui questi, liberato dalle tenebre dell'oppressione, possa vivere in pieno accordo con la natura un'esperienza di cristianesimo radicale basato sul superamento dell'egoismo, della superstizione e della violenza. Per trovare nel suo isolamento un linguaggio che permetta di percepire l'essenza profonda delle cose, che egli va decifrando nella natura, egli è costretto a elaborare un linguaggio personale che trova nella Bibbia e in Dante. La potente concretezza e il ricorso a voci popolari contribuiscono a fare della poesia di Campanella un prodotto originale della crisi del 1600. Per quanto riguarda la trattatistica, le novità delle situazioni, dei problemi e dei metodi provocano profonde trasformazioni nelle forme tradizionali della comunicazione.
Politica e Chiesa nel 1600
La subordinazione del potere del principe al magistero e al controllo della Chiesa resterà per secoli il caposaldo ideologico della Chiesa di Roma. Botero resta sulla base del dibattito politico che, nei territori sottoposti al controllo dell'Inquisizione, presenta margini molto ridotti di libertà pur nel risorgere continuo ed evidente delle difficoltà a risolvere nella pratica l'opposizione tra due esigenze tanto lontane. Zoccolo definisce la politica come la tecnica rivolta a individuare i mezzi adatti a conservare e a ordinare qualsivoglia costituzione di repubblica. Secondo lui la ragion di stato sarà buona se sarà usata per rafforzare uno stato giusto, malvagia se usata per rafforzare uno stato tirannico. Sarpi invece prodiga tutta la sua vita di credente e di studioso a combattere l'ingerenza del papato nella sfera della legittima sovranità dello Stato. Boccalini propone una interpretazione di Tacito che permette di utilizzare le spietate rivelazioni dello storico latino sui meccanismi reali del potere come strumenti di demistificazione e di difesa dal potere stesso. Torquato Accetto dice che la dissimulazione diventa atteggiamento volontariamente scelto a difesa della propria intimità e della propria integrità. In un suo trattato spiega come la dissimulazione sia l'arma con la quale il saggio si difende dall'oppressione esterna e dal pericolo costituito dall'emergere improvviso dei propri sentimenti. L'intervento gesuita è caratterizzato nei fini dalla difesa dell'ordine costituito e nelle forme da uno stile sostenuto e ricercato.
Il controllo rigoroso attuato sulla vita culturale italiana dalla Chiesa controriformistica impedisce lo sviluppo in Italia di quel dibattito religioso che produce profonde innovazioni nella religiosità cattolica dei paesi in cui la Chiesa è costretta ad affrontare quotidianamente il confronto con la Riforma. L'attenzione della Chiesa si concentra in Italia su un'opera di propaganda che mira a suscitare nelle masse un'adesione la più vasta ed immediata possibile alla pratica religiosa e la sottomissione ai dettami ecclesiastici. L'oratoria sacra ricorre alle tecniche collaudate dalla prosa barocca particolarmente efficaci nella situazione spettacolare in cui opera il predicatore.
Galileo e la scienza nuova
Mentre la scienza ufficiale continua ad affidare l'esposizione dei suoi contenuti alle forme tradizionali del trattato, Galileo Galilei, con il Dialogo sopra i due massimi estremi del mondo, propone una radicale innovazione delle forme della trattazione scientifica. Poiché l'affermazione della Scienza Nuova comporta un radicale cambiamento di mentalità e per raggiungere questa meta occorre "cambiare il cervello", lo scienziato è obbligato a fare appello a tutte le sue conoscenze e alle sue abilità di uomo per persuadere e convincere gli altri uomini con la forza del ragionamento. La scelta del volgare è coerente con le finalità e le premesse di base della ricerca galileiana aperta al contributo di tutti purché qualificati e disposti a investigare nella nuova realtà che si apre ai loro sensi.
All'esempio di Galilei si rifarà nel corso del secolo una serie di autori (come padre Benedetto Castelli, Lorenzo Magalotti e Francesco Redi) che coltivarono efficacemente sia gli studi letterari sia la ricerca scientifica, prudentemente mantenuta in ambito specialistico. L'abitudine all'investigazione comporta nelle loro opere un'attenzione particolare alla concretezza dei fenomeni e uno scrupolo di chiarezza espositiva che soddisfano quelle esigenze di ordine, razionalità e obiettività che il 1700 farà prevalere anche in campo letterario.
La novella e il teatro barocco
La novella non conosce nel 1600 novità di rilievo che le permettano di uscire dalla situazione di stallo in cui è entrata a metà del 1500. Alla ripetizione del modulo boccaccesco non corrisponde più la capacità o la volontà di raggiungere quell'equilibrio tra cornice e sequenze narrative che aveva caratterizzato il modello. Né la novella conosce quel processo di eversione e rifondazione che il Barocco imprime ad altri generi.
Commedia dell'Arte e melodramma
La teatralità è forse la dimensione che meglio collega tra loro le forme artistiche, le espressioni della comunicazione culturale e del comportamento sociale del secolo barocco in Italia. La metafora del teatro del mondo, luogo comune dei moralisti del secolo, allude alla precarietà della vita di ognuno. La straordinaria fioritura di capolavori teatrali nella letteratura inglese, spagnola e francese non trova che un pallido corrispettivo nella nostra produzione letteraria. Grandi esponenti del teatro barocco furono William Shakespeare, Calderòn de la Barca, Moliere,. La letteratura italiana contribuisce, nel secolo barocco italiano, alla nascita della Commedia dell'Arte e del melodramma.
La tematica della tragedia vede la prevalenza dei contrasti tra sentimento e onore, tra amore e ambizione, tra affetti personali e ragion di Stato che sono tipici del Barocco in Italia. Letterariamente dignitose sono le opere che nascono all'interno dei collegi gesuitici a scopo educativo ed edificante. Incentrate intorno a una storia esemplare di vita religiosa, hanno una diffusione europea.
La fondazione della prima compagnia di attori professionisti abili avvenne nel 1545. L'abilità è assicurata da un tirocinio che impegna l'attore sin dalla tenera età e copre tutte le necessità organizzative e operative della compagnia. L'attore più abile è quello che con maggior prontezza sa adattare alla situazione il tassello mancante, sa improvvisare. I materiali provengono dalla tradizione della commedia rinascimentale, presentano l'intramontabile modello dello sviluppo, della complicazione progressiva delle peripezie dei personaggi che si concludono con un lieto fine. Le parti coincidono con gli eterni tipi del mondo teatrale, dal vecchio babbeo al giovane innamorato, dal servo astuto al giovane pedante, il finto tonto, il vecchio avaro, il soldato spaccone. Dal rimodernamento di questi tipi nascono le maschere della commedia dell'arte come il dottor Balanzone, Pantalon de' bisognosi, Capitan Spaventa, Arlecchino.
È destinato a una rapida evoluzione. In esso confluiscono elementi musicali, letterari e teatrali. La scelta che privilegia la voce umana si fonda sul desiderio di portare la loro arte al grado di pienezza espressiva raggiunto dalla poesia lirica di Tasso nella resa del sentimento. Parola e musica cooperano per raggiungere quella pienezza espressiva del sentimento che la parola poetica suggerisce e la suggestione della musica completa sul piano della sensazione. Nato per un pubblico di palazzo raffinato, il melodramma incontrò presto il favore di un largo pubblico. Gia a metà secolo il genere accoglie contenuti comici ed eroici e presenta la tendenza ad organizzarsi secondo intrecci complessi.
La questione della lingua nel 1600
La questione della lingua
Alla fine del nuovo secolo la situazione nazionale non risulta progredita per quanto riguarda l'uniformazione delle lingue. Una serie di fattori opera in senso contrario:
* il permanere di una divisione politica;
* la progressiva perdita di importanza e sul piano linguistico di Firenze;
* il rafforzamento del latino al quale la Chiesa controriformista affida la liturgia e l'insegnamento.
Ostacolando la lettura dei testi sacri in italiano, la Chiesa fa in modo che la discriminazione tra i ceti in grado di leggere il latino e il resto della popolazione fosse ancora più netta. Anche gli uomini di cultura usano i dialetti locali per necessità della vita e la lingua letteraria resta una lingua scritta, patrimonio di una piccola porzione di popolazione. Il 1600 reagisce in due modi:da un lato innesta sul tronco tradizionalista e conservatore il nuovo ramo del purismo e dall'altro da vita alle letterature dialettali.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del letterato rispetto al cortigiano nel 1600?
- Come la Chiesa controlla la cultura nel 1600?
- Qual è l'importanza delle accademie nel Barocco italiano?
- In che modo il Barocco italiano si differenzia dal Rinascimento nell'arte?
- Qual è l'approccio di Galileo Galilei alla scienza nel 1600?
Il letterato cerca di svincolarsi dalla protezione del principe, a differenza del cortigiano che diventa esecutore della volontà del principe. Solo pochi, come Marino, riescono a muoversi tra le corti grazie alla loro reputazione.
La Chiesa esercita un controllo rigoroso sulla cultura, imponendo restrizioni all'editoria e riservandosi il diritto di concedere l'imprimatur o proibire la stampa di opere, influenzando così la produzione culturale.
Le accademie fungono da piccoli gruppi di intellettuali che offrono un luogo neutrale per il confronto di idee, garantendo onore e reputazione ai letterati, spesso negati dalla realtà esterna.
Il Barocco italiano si concentra sull'anomalia e l'eccezione, preferendo la finzione alla riproduzione degli oggetti, con un uso simbolico e metaforico per spiegare fenomeni sfuggenti.
Galileo introduce una radicale innovazione nella trattazione scientifica, utilizzando il volgare per ampliare il pubblico e promuovendo un cambiamento di mentalità attraverso il ragionamento e la persuasione.






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo