Concetti Chiave
- L'omosessualità è presente in molte specie animali, ma solo negli umani e in alcune scimmie ha un'accezione erotica.
- Studi indicano che l'orientamento sessuale è influenzato da fattori genetici e ormonali, con possibili alterazioni durante lo sviluppo fetale.
- Il dibattito sull'omosessualità è stato controverso nel tempo, evolvendo da disturbo psichico a variante dell'orientamento sessuale.
- Condizioni fisiche come l'intersessualità possono influire sull'orientamento sessuale, con sindromi genetiche che alterano il fenotipo.
- L'accettazione sociale dell'omosessualità varia, ma la scienza sottolinea l'influenza di fattori endocrini e percezioni personali.
Indice
Definizione e origini dell'omosessualità
L'omosessualità si definisce come la tendenza di un individuo a provare attrazione per altri elementi del medesimo sesso e della medesima specie. L'inclinazione all'omosessualità presenta origini antropologiche, storiche e sociali. Non è raro trovare in natura specie che abitualmente consumino rapporti sessuali con soggetti del loro stesso sesso, per quanto in questi casi il fenomeno risulti privo di ogni accezione erotica, peculiare del solo genere umano e di alcune scimmie antropomorfe (come ad esempio lo scimpanzé nano Bonobo, nome scientifico "pan paniscus"). Al contrario, tutte le altre specie animali che saltuariamente praticano rapporti omosessuali condividono il medesimo scopo, ovvero l'emancipazione dal punto di vista sociale in situazioni in cui se ne presenti il bisogno, o comunque la prevaricazione dell'individuo su un altro al fine di dimostrare la propria superiorità (chiaramente, si sta parlando di rapporti tra individui di sesso maschile).
Proseguendo nell'analizzare le situazioni in cui risulta più frequente l'inclinazione omosessuale, non risultano particolarmente isolate fasi storiche in cui l'omosessualità fosse diffusa, basti pensare ai periodi delle rivoluzioni sociali e culturali quali ad esempio il Rinascimento o il Risorgimento, o la stessa rivoluzione culturale che prese piede a partire dagli anni sessanta, in cui quasi il fenomeno suddetto si individuò come tendenza.
Prospettive teoriche sull'omosessualità
Citando testualmente la voce "Omosessualità" dall'Enciclopedia Treccani online, sessuologia moderna nell’interpretazione dell’o.: la prospettiva essenzialista e la prospettiva costruttivista. La prima individua alla base dell’o. fattori biologici o filogenetici, ossia elementi oggettivi e costituzionali dell’orientamento sessuale. La seconda, invece, considera l’o. – e la sessualità in genere – come un prodotto di categorie storiche e culturali, espressione dei costumi sessuali più o meno diffusi in una popolazione in un dato momento storico. Tale approccio relativistico nega che vi possa essere un orientamento sessuale di genere – intrinseco alla persona sessuata, uomo e donna – e considera quest’ultimo piuttosto come il frutto dell’educazione o di fattori socioculturali.>>
Aspetti medico-scientifici dell'omosessualità
Tuttavia, è importante analizzare l'omosessualità dal punto di vista medico-scientifico oltre che da quello sociale. La scienza si è occupata di studiare le cause dell'orientamento sessuale nella razza umana, definendo in maniera più o meno precisa le possibili cause di tale particolare condizione: secondo quanto riportato da alcuni medici dell'Accademia Americana di Pediatria, l'omosessualità dipende non tanto da un fattore, quanto da una combinazione di molte situazioni che vanno a definire l'indirizzo sessuale di un individuo; questo insieme di fattori sembra formarsi durante lo sviluppo del feto e, successivamente, in seguito a motivi circostanziali potenzialmente rilevanti nella crescita del soggetto.
Studiando appunto un articolo del 2004 della rivista "Pediatrics", si può leggere: > (>).
Attorno ai primi decenni del secolo scorso, la questione omosessualità era ancora più controversa e dibattuta di quanto non lo sia ancora oggi. In particolare, un'analisi avanzata dalla Associazione Americana di Psichiatria -pubblicata nel Manuale di Diagnostica e Statistica dei Disturbi Mentali- catalogava l'omosessualità appunto come disturbo della psiche, teoria che venne immediatamente riconsiderata per motivi etici.
Effettivamente, essa non è catalogabile come patologia, ma limitarsi a definirla "variante dell'orientamento sessuale" sarebbe in ogni modo un atteggiamento superficiale.
Come per la condizione fisica di intersessualità -ed è importante precisare che non obbligatoriamente essa è legata alla precedente argomentazione sull'orientamento di un individuo, come spesso invece si tende a dare per scontato- l'omosessualità può essere dovuta a particolari condizioni ormonali, comunque legate maggiormente al sistema endocrino piuttosto che a quello nervoso, che possono causare nel soggetto alcune anomalie certamente non gravi come, in primis, un potenziale ritardo dello sviluppo sessuale o l'alterazione in forma lieve dei quantitativi standard di testosterone nel maschio o di progesterone ed estrogeni nella femmina, che in questo caso verrebbero prodotti in quantità minori. È probabile inoltre che queste leggere anomalie dipendano da un diverso comportamento di due ormoni, quello "follicolostimolante" (FSH) e quello "luteinizzante" (LH): lo scarso funzionamento dell'LH nell'individuo maschile durante la pubertà può far avvertire la presenza di atteggiamenti più "femminili"nello stesso, viceversa il suo eccesso nelle ragazze può causare atteggiamenti che risultano essere più mascolini (è da precisare che tali episodi sono più comuni e rilevanti nei maschi piuttosto che nelle femmine).
Studi genetici e ormonali
L'alterazione di questi ormoni dipende dal funzionamento più o meno regolare di una ghiandola fondamentale, detta "ghiandola pituaria" o "ipofisi", che si trova nella zona centro-meridionale del nostro cranio e che determina appunto effetti di grande portata sul nostro apparato riproduttore, oltre a regolare la produzione degli ormoni. Ricordiamo che tale ghiandola è a sua volta controllata dall'ipotalamo, una sezione del cervello, ciò significa che ad ogni modo, essendoci un forte collegamento tra i due, la eventuale condizione di omosessualità dipende anche, come già citato, da fattori esterni e circostanziali avvertiti ed analizzati dal nostro sistema nervoso. Sembra inoltre scaturire da recenti studi, intrapresi dallo psicologo e antropologo americano Michael Bailey, che l'omosessualità dipenda effettivamente da un particolare gene, precisamente del cromosoma Xq28 tramandato all'individuo dalla propria madre, che in questo modo ne va condizionando l'inclinazione, e i risultati dell'esperimento sarebbero da considerarsi verosimili, poiché la percentuale in cui questo cromosoma è stato rilevato, sui 400 campioni presi, è risultata piuttosto alta,
Intersessualità e sindromi correlate
È importante precisare che, per quanto non sempre questo avvenga, le condizioni fisiche dell'individuo, affrontando più precisamente l'argomento intersessualità, portino ad una variazione dell'inclinazione sessuale dello stesso. Parlando di intersessualità si sottintende che tutte le cellule del corpo abbiano il corredo cromosomico di un sesso, che però durante lo sviluppo presentano un’inversione per cui l’individuo, che aveva incominciato a svilupparsi come maschio, continua il suo sviluppo formandosi con le caratteristiche del sesso opposto e viceversa. L’intersessualità è determinata da cause genetiche, nel dettaglio che agiscono sul fenotipo. Tali cause sono dovute a squilibrio fra i geni determinatori dei sessi, che appunto danno luogo ad anomalie fenotipiche e che presentano peraltro una sintomatologia piuttosto ampia, alla cui base vi è una differente conformazione delle gonadi; le alterazioni più frequenti sono la sindrome di Turner, molto più frequente nei neonati che nascono di sesso femminile piuttosto che nei maschi (nel caso in cui per questi venga a verificarsi, il nome nello specifico è "sindrome di Noonan") e che presenta come sintomi la piccola statura e la mancanza di mestruazioni, determinata da un cariotipo 45XX (quindi con un cromosoma in meno), e la sindrome di Klinefelter, che agisce sul fenotipo maschile dotando i soggetti di testicoli più piccoli della norma e di eccessiva concentrazione di gonadotropine (la famiglia di ormoni contenente i succitati FSH ed LH) e che è determinata dal cariotipo 47XXY, con un cromosoma sessuale in più.
Altri sintomi di intersessualità possono essere l'assenza totale dei testicoli in un individuo presentante sesso maschile (nel caso di assenza di ovaie nella femmina non si parla propriamente di intersessualità quanto piuttosto di "deformazione" del fenotipo), o la contemporanea presenza delle gonadi di entrambi i sessi, in tal caso si parla propriamente di "ermafroditismo", o ancora la sindrome di Morris, altresì conosciuta come "sindrome da insensibilità agli androgeni", per la quale, pur essendo il corpo inizialmente maschile, questi va definendosi non reagendo agli ormoni appunto maschili a cui è del tutto insensibile, continuando il proprio sviluppo come femmina. Un' altra forma di intersessualità è lo pseudoermafroditismo maschile. Un esempio è la sindrome parziale di insensibilità agli androgeni, anche conosciuta come "sindrome di Reifenstein" o "sindrome di Lubs" in cui lo sviluppo degli organi genitali esterni è intermedio fra maschio e femmina.
Conclusioni e dibattito etico-sociale
Dunque, per quanto il dibattito sia tutt'ora piuttosto controverso, anche per ragioni di natura etico-morali e di natura sociale legata ai tempi che viviamo, che fortunatamente (o sfortunatamente, per alcuni) permettono maggiore libertà di costumi a chiunque senta il bisogno di sperimentare e di mostrare la propria sessualità senza vergogna alcuna, piuttosto con grande orgoglio, la scienza testimonia che la tendenza di un individuo all'omosessualità sia dovuta ad una alterazione del funzionamento del sistema endocrino e ad una differente percezione di se stessi e del mondo, dovuta a fattori esterni che ne hanno causato il condizionamento oppure a caratteristiche fisiche che agevolano soltanto -certo nei casi in cui la situazione venga benevolmente accettata- una scelta di vita che tutt'ora sembra comunque essere così diversa agli occhi di molti.
Domande da interrogazione
- Quali sono le origini dell'omosessualità secondo il testo?
- Come viene vista l'omosessualità dal punto di vista medico-scientifico?
- Quali sono le implicazioni ormonali legate all'omosessualità?
- Qual è il ruolo del cromosoma Xq28 nell'omosessualità?
- Come si collega l'intersessualità all'omosessualità nel testo?
L'omosessualità ha origini antropologiche, storiche e sociali, ed è presente anche in natura tra alcune specie animali.
La scienza suggerisce che l'omosessualità derivi da una combinazione di fattori genetici, ormonali e circostanziali che si formano durante lo sviluppo del feto e la crescita dell'individuo.
Alterazioni ormonali, come quelle del testosterone, progesterone, estrogeni, FSH e LH, possono influenzare l'orientamento sessuale, con la ghiandola pituitaria e l'ipotalamo giocando un ruolo chiave.
Studi suggeriscono che un gene sul cromosoma Xq28, ereditato dalla madre, possa influenzare l'inclinazione omosessuale, come indicato da ricerche di Michael Bailey.
L'intersessualità, causata da squilibri genetici e ormonali, può influenzare l'orientamento sessuale, ma non è necessariamente legata all'omosessualità, essendo una condizione distinta.

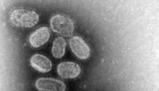






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo