
20 giugno 2007, le ore 7.30 di un mattino abbastanza normale, direbbero in molti, a meno di non avere 18-19 anni e avere l’obbligo di recarsi nella propria scuola. “Ma la scuola non è finita da un pezzo?”, potreste chiedere. “Certo”, vi rispondiamo, tranne per chi, anche quest'anno, dovrà affrontare l’ultimo dei compiti scolastici, l’Esame di Maturità.
Ci sono eventi che nascono sotto una buona stella, altri i cui pessimi auspici sono nell’aria da giorni, settimane, mesi prima che inizino. La maturità dell’anno scolastico 2006/07 appartiene a questa seconda categoria: per mesi abbiamo ascoltato i continui comunicati del ministro Fioroni, le sue idee innovative, la promulgazione di nuove leggi, nuovi contratti, nuovi ordini per la scuola e ciò che ci stava intorno… e probabilmente ad un certo punto chi doveva impegnarsi a lavorare seriamente sulla stesura dei temi che migliaia di ragazzi avrebbero dovuto affrontare, forse preso dalla stanchezza, forse trascinato da questa ondata di “fare tanto, fare troppo”, o forse solo perché il contatto con la realtà della scuola il nostro ministero lo ha perso da tempo, ha creato dei temi, delle prove che per mancanza di rigore logico non hanno nulla da invidiare al comportamento di un bambino capriccioso che la vuole sempre vinta lui!
Ma andiamo con ordine (cerchiamo di mantenerlo almeno noi, visto che le tracce di matematica non ci sono riuscite!).

Le tracce della Prova di Italiano, quella mattina, presentavano una certa accozzaglia di elementi da far impallidire un robivecchi: decine di brani per ogni singolo saggio breve (a volte slegati tra loro), errori nell’attribuzione del contenuto dei testi saggistici, e altro hanno causato non pochi problemi.
L’analisi del testo (la tipologia A) richiedeva di analizzare “una parte” del Canto XI del Paradiso, in cui San Tommaso parlando con Dante elogia la figura di San Francesco. Tralasciando la parafrasi (ovviamente presente e da fare per poter seguire il discorso di Tommaso), la parte relativa al commento risultava eccessivamente schematica e preordinata: la possibilità di movimento e di aggiungere propri elementi critici si perdeva in richieste a cui si sarebbe potuto benissimo rispondere con una serie di dati statistici, uccidendo così qualsiasi tentativo di analisi personale da parte del maturando. Ma il colpo di genio sta nel citare anche il personaggio di Domenico di Guzman e tirarlo in ballo in un paragone con San Francesco nell’ultimo punto di questa analisi critica: è vero che Tommaso, dopo l’elogio di Francesco, critica Domenico; ma è anche vero che il brano fornito dal ministero non accenna neanche minimamente a questo fatto (che per la cronaca prende atto nei versi 118-139 dello stesso canto).
Delle due l’una: o hanno preso la più grossa cantonata della storia, scordandosi di aggiungere il restante brano, oppure confidavano nella conoscenza della vita e delle opere di San Domenico da parte degli studenti, vita e opere che, semmai si studino nella scuola superiore, si attuano durante lo studio della Storia (non letteratura) del ‘200 -‘300, ben lontano dall’ultimo anno, in cui di solito si comincia con l’800. Fate un po’ voi.
Per la tipologia B del saggio breve, invece, abbiamo di fronte il caos primigenio, quello successivo al Big Bang: il saggio artistico-letterario, titolo “I luoghi dell’anima”, presenta ben 10 brani e 1 dipinto che sì, fanno riferimento all’anima, ma ognuno in maniera diversa: dallo spirito immortale che ascende al cielo, al pensiero come essenza dell’uomo fino alla più prosaica delle esclamazioni che lega luoghi ed anime (spero mi passiate il romanesco) “lì c’ho lasciato er core!”.
Forse l’ambito socio-economico era quello più coerente, con tema di giustizia, diritto e legalità, presentando 7 brani che, centravano più che bene le tematiche richieste (ma comunque troppa roba!), poi la traccia tecnico-scientifica ripresenta la stessa accozzaglia del primo: il tema è “sensate esperienze” e “dimostrazioni certe”, e punta alla nascita della scienza moderna (e già qui si potrebbe ridire, visto che non solo il metodo scientifico Galileiano ha contribuito a tale nascita, ma lasciamo perdere) attraverso l’analisi di ben 7 testi i quali parlano sì del metodo, ma ognuno con riferimento o al suo uso, o alla bellezza della scienza, oppure ai contrasti che questo ha dato nel corso del tempo, ma si perde in questa marea di brani il senso fondamentale del tema, e cioè quello del linguaggio della natura!
La traccia storico-politica merita un discorso a parte: non tanto ci ha stupito ancora la sovrabbondanza di testi (alcuni dei quali anche molto verbosi e ripetitivi), quanto il fatto che quasi tutti i brani, per legarsi al tema della nascita della Repubblica e dell’abbandono della dittatura, abbiano dato addosso in maniera del tutto acritica a Mussolini, alla destra Italiana del dopoguerra e alla monarchia (e non mi sembra che, nell’attuale momento politico in cui i vari rappresentanti si insultano per una pisciatina nel bagno sbagliato, abbia molto senso esporre un manifesto durante gli esami dei futuri elettori...). Ora, “La luna e i falò” è stato scritto nel 1950, e bisognerebbe capire se dai maturandi si vuole un po' di maturità (appunto) e di spirito critico, sennò si potrebbero sostituire le pagine e pagine che costituiscono la traccia con un semplice modulo “Barrare la casella 'sì' se si è d'accordo”, con gran risparmio di fotocopie, inchiostro e tempo.
La prova, comunque, si è conclusa nel migliore (o peggiore dei modi): studenti delusi dalle tracce, spiazzati dalle richieste e anche un po’ preoccupati per come 'sta storia sarebbe andata avanti… e non avevano tutti i torti.
La mattina del 20 giugno ha portato una nuova ondata di smarrimento nell’animo di questi teneri fanciulli, soprattutto per i liceali che staranno ancora chiedendosi dove stavano nascoste le telecamere per le candid camera!
I latinisti, con loro somma sorpresa, si sono trovati ad affrontare un brano del tutto inaspettato. Tratto dal De Beneficiis, che non è certo l’opera più bella e più famosa di Seneca, il testo comincia ex abrupto con un aneddoto privo di qualsiasi contestualizzazione, un’esclamazione di Marco Antonio ad un verso del poeta Rabirio, collocato per giunta all’interno del periodo più complesso e accidentato di tutta la versione, la mancata comprensione del quale poteva pregiudicare quella dell’intero brano. Continua per alcune righe con affermazioni che costituiscono un saggio della migliore sintassi paratattica, involuta, spigolosa e spezzata del latino d’età argentea - quando tanto nei nostri licei si insiste sulla prosa classica ciceroniana -, si distende nella parte centrale con un lungo periodo in cui il soggetto e il predicato della proposizione principale sono separati da almeno otto proposizioni dipendenti, e si placa infine con un periodare ed un filosofare più semplice e fluido. Sarebbe stato forse più opportuno l’inverso: un attacco più alla portata degli studenti, una conclusione più complessa, alla cui soluzione i candidati potessero giungere al termine di una traduzione di cui conoscevano ormai i dati e i contenuti. Un brano dunque impegnativo, che richiedeva notevoli competenze linguistiche e cognizioni storico-letterarie, un brano che - azzarderemmo - sarebbe stato degno, più che di una versione di maturità, di una prova di concorso di dottorato. Un ultimo appunto: se la scelta doveva cadere su Seneca, con questo passo si è forse persa l’occasione di proporre ai maturandi una delle pagine più belle della letteratura latina, quale poteva essere tratta dai Dialoghi, dalle Lettere a Lucilio, o dalle tragedie di questo autore.

I matematici, invece, si sono trovati di fronte un tema non tanto difficile, ma totalmente privo di logica: il programma di quinto liceo prevede lo studio dell’analisi matematica, che era presente sì e no in un paio di domande all’interno dei problemi e in 4 o 5 domande del questionario, mentre il resto del compito spaziava sulle conoscenze più totali della matematica. In primis, il problema comune allo scientifico tradizionale e al PNI presentava una laboriosità di calcoli e un richiamo a molte formule trigonometriche: si passava da una prima richiesta trigonometrica, ad una analitica, ad una terza in cui ci si scordava momentaneamente di tutto ciò che si era fatto fino ad allora per procedere con nuove tecniche, ad una quarta in cui si doveva recuperare la prima pagina di calcoli e portarli a termine! Si richiedeva la conoscenza delle funzioni goniometriche legate alla sezione aurea, che di norma ingialliscono in una tabella appena vista all'inizio del libro di quarto, dimenticate dagli uomini e da Dio, ma evidentemente non dai tecnici del ministero. Ma niente in confronto ai quesiti: alcuni di carattere storico, altri completamente fuori della grazia di Dio. Un nostro esperto matematico, ricercatore da circa un anno e studioso di Geometria differenziale da ormai 8 anni ha commentato il quesito sulle geometrie non euclidee affermando che egli stesso, pur essendo esperto di questi argomenti, non sarebbe stato in grado di enunciare i teoremi richiesti nella domanda!
In fin della fiera, i temi di quest'anno rasentavano l’assurdo e hanno provocato non pochi problemi: agli studenti, messi di fronte a richieste incredibili; ai commissari (di nuovo esterni) che adesso avranno una bella gatta da pelare a valutare la migliore resa del bianco dei fogli intonsi che gli studenti stessi hanno consegnato alla fine della prova; a chi ha cercato in qualche modo di mettere una pezza a questa bizzarra situazione, e magari si trova preso tra i due fuochi del dare ragione al mondo scolastico e torto al ministero, o viceversa.
Vogliamo concludere con una citazione (molto poco dotta, forse) alla luce anche dell’incresciosa situazione in cui si sono trovati gli studenti privatisti a cui è stato negato il diritto di prendere parte agli esami. Non ci saremmo stupiti, visti gli assurdi creati con questa maturità 2007, che il mattino del 20, appena entrati nei rispettivi istituti, gli studenti non fossero stati redarguiti da una voce, bassa, profonda e d’effetto, proveniente da microfoni ed altoparlanti, con le seguenti parole:
"C'è una quinta dimensione, oltre a quelle che l'uomo già conosce. È senza limiti come l'infinito, e senza tempo come l'eternità. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione, una regione che si trova... AI CONFINI DELLA REALTÀ."
P.S. Abbiamo preferito dare risalto a questo editoriale a qualche giorno di distanza dalla fine delle prove scritte proprio per lasciarvi tranquilli e non acuire eventuali stati di...arrabbiatura!
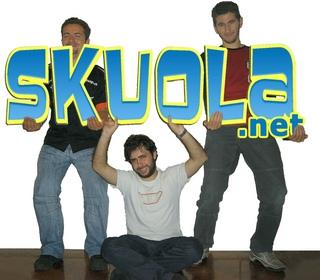






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo