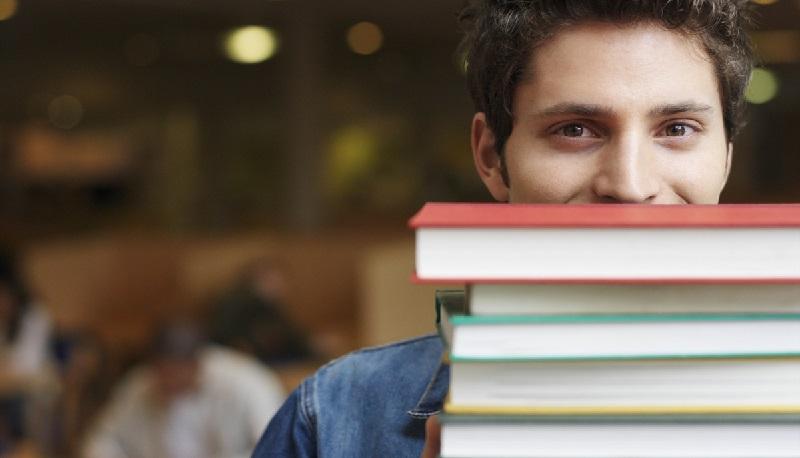

Ecco le principali differenze:
• Le conoscenze sono informazioni e/o procedure apprese attraverso il processo di insegnamento/apprendimento. Possono essere teoriche (la conoscenza dell’ordine delle operazioni in un’espressione coi numeri relativi) e procedurali (prendendo spunto dall’esempio precedente, una conoscenza pratica può essere la risoluzione della stessa);
• Le abilità sono il coronamento delle conoscenze, da esse, infatti, si passa dal sapere al saper fare. In matematica, un’abilità di cui si era tanto parlato nel mondo scolastico era quella del problem solving, ossia utilizzare le conoscenze (in questo caso matematiche e/o logiche) per svolgere compiti (problemi algebrici, in questo contesto) oppure problemi;
• Le attitudini rappresentano gli atteggiamenti che si attuano nel corso della vita che derivano dalle conoscenze e dalle abilità acquisite nel percorso formativo (per fare un esempio: se mi trovassi nel mezzo di una situazione pericolosa, utilizzando la logica, potrei scegliere la soluzione più razionale e adatta a superarla con successo).
Riassumendo, alla domanda “che cosa mi serve studiare la storia!” oppure “a cosa mi serve apprendere il latino” non bisogna rispondere (in maniera rispettiva): “a conoscere il passato per comprendere il presente”; “ad aprire la mente” ma –al contrario – “a fornire mezzi interpretativi di grandi periodi storici, spendibili nella vita quotidiana” e “non solo ad allargare i tuoi confini culturali ma, anche, ad esercitare la mente con attività che richiedono la logica matematica, spendibile in situazioni quotidiane seppur in diversa forma (oggettivamente, non abbiamo più a che fare con versioni di latino da tradurre: escludiamo, i filologi e studiosi).
L’UE nel 2006 ha definito, nell’ambito del processo di Lisbona, quali siano le competenze chiave per la cittadinanza europea:
1. comunicazione nella madrelingua;
2. comunicazione nelle lingue straniere;
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4. competenza digitale;
5. imparare a imparare;
6. competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica;
7. imprenditorialità;
8. espressione culturale.

Tutti i docenti sono coinvolti in questo stravolgimento (ai posteri il giudizio, se positivo o negativo) della didattica tradizionale la quale non vanterà più solo le lezioni esercitative distanti dalla realtà, ma anche lezioni che aprano una finestra (un piccolo squarcio, ad esser precisi) nel mondo. In poche parole, una lezione di geometria può diventare un’immersione nel mondo: attraverso gli occhi rigorosi della matematica si può osservare la natura che ci circonda (palazzi, stazioni, metropolitane) e ‘trasportare’ le proprie abilità nella vita, oppure un’ora di geografia può mutare in una palestra interculturale del mondo che ci circonda e la lezione di greco concorre alla formazione del'laboratorio' di interpretazione logico - matematica.
“La didattica per competenze non può diventare l’ultima moda didattica. La posta in gioco è troppo alta: si tratta di riconquistare all’apprendimento e di fornire gli strumenti di cittadinanza alle generazioni più giovani, che rischiano di essere lasciate in balia di strumenti di informazione e intrattenimento dalle potenzialità positive innegabili, ma anche virtualmente distruttivi, se avvicinati senza le adeguate capacità di lettura e di analisi critica” scrive Franca Da Re, nel libro Didattica per Competenze edito da Pearson. In poche parole, essere in possesso di miliardi di informazioni non significa aver cultura; la scuola è chiamata alle armi, sviluppando il senso critico in ogni alunno (ciascuna unità dev'essere valorizzata nella sua unicità, in un'ottica pedagogica moderna). Le carte sono scoperte: annegare le materie nel nozionismo, crea gravi lacune nel corso dell'esistenza dell'individuo.
La necessità di cambiare è qualcosa di concreto poiché riflette un’evoluzione della società che ha a disposizione numerosi mezzi per apprendere. La figura dell’insegnante, nel mondo 2.0, è quella non solo di fonte del sapere ma di educatore ai valori comuni e fornitore di strumenti idonei per continuare a imparare lungo l’arco di tutta una vita.
Articolo scritto da Alessio Cozzolino. Ringrazio N. , M. e tutti coloro che mi hanno fornito suggerimenti e/o consigli.






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo