
ROMA - Il dizionario della lingua italiana è sempre stato l'àncora di salvezza degli studenti. Viene consultato specialmente durante i compiti in classe per evitare strafalcioni ortografici o reggenze sbagliate.
Ma siamo sicuri che questo 'talismano dei giovani' debba essere solamente considerato uno strumento cui aggrapparsi esclusivamente nei momenti di difficoltà linguistica? Che situazione sta attraversando la nostra lingua? Sono solo alcune delle domande poste a Luca Serianni, docente all'Università La Sapienza di Roma, considerato uno dei più grandi esperti della lingua nazionale, curatore del dizionario Devoto-Oli, edito dai tipi Le Monnier, insieme a Maurizio Trifone.
In questo articolo, breve e carico di emozioni profonde, è delineato il profilo dell'italiano che cambia e quello di un Uomo, Luca Serianni, che dimostra - oltre a una grandissima conoscenza della materia - un amore senza confini verso la comunicazione. Nella società Dante Alighieri fondata da Giosue Carducci, per la diffusione dell'italiano nel mondo, occupa la posizione di vicepresidente proprio a causa della sua bravura e forte competenza.
LUCA SERIANNI
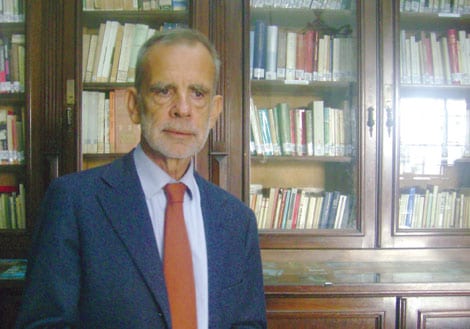
1. Professor Serianni, che rapporto hanno i giovani col dizionario?
È un rapporto alquanto occasionale: perlopiù il dizionario viene portato a scuola quando c'è un compito in classe, quasi come una specie di talismano, e poi non ci si pensa più. In realtà un dizionario può essere sfogliato quasi come un libro di lettura: oltre al significato di una parola che non conosciamo, vi troviamo le collocazioni, cioè le combinazioni tipiche all'interno di una frase (posso dare un ordine o un consiglio, ma solo impartire un ordine), la reggenza (una dieta può essere carente di proteine, ma un alunno sarà carente in una certa materia), la fraseologia (che cosa vuol dire lavare la testa all'asino?), l'etimologia e altro ancora.
2. Friendzone e selfie stick sono solo alcuni dei termini recentemente entrati nel Devoto- Oli. L’intensificarsi dei prestiti linguistici è un arricchimento o un impoverimento per l’italiano?
In generale è del tutto fisiologico che una lingua accetti parole provenienti da altre lingue. Indubbiamente, però, il recente afflusso di anglicismi non adattati in italiano è una tendenza che andrebbe regolata: non certo da qualche autorità, ma dall'autodisciplina degli stessi parlanti, che molte volte non farebbero nessuna fatica a usare termini italiani. Nulla di male se diciamo cancellare un volo sul modello dell'inglese to cancel, invece di annullare; l'italianissimo verbo cancellare si è arricchito di un'accezione in più. Ma le parole non assimilate alla struttura dell'italiano perché terminanti in consonante o contenenti gruppi fonici o grafici estranei alla nostra lingua, rischiano di essere come altrettanti granellini di sabbia che alla lunga possono danneggiarne il funzionamento.
3. Qual è la conoscenza della lingua italiana che hanno i ragazzi in età scolare, in media? In confronto al passato, i dati sono migliorati o peggiorati?
Ancora cinquant'anni fa un certo numero di ragazzi, abituati a usare soltanto il dialetto, avevano difficoltà con la lingua nazionale. Oggi questo non avviene più; tuttavia si è perso, o si è allentato, il contatto con la lingua scritta: non solo quella dei grandi classici (I Promessi Sposi risultano non di rado un testo linguisticamente difficile, e questo un tempo non sarebbe avvenuto), ma anche quella di un editoriale giornalistico. Se un adolescente non capisce parole come irretire, precario, discettare, dimestichezza rischia di diventare un cittadino di serie B, che non sarà in grado di leggere e di giudicare criticamente ciò che è scritto nella sua stessa lingua, ma che esula dal linguaggio più quotidiano e familiare.
4. In che modo dei vocaboli entrano nel dizionario? Come funziona la lessicografia, spiegato in maniera semplice?
Ogni dizionario si inserisce in una tradizione: gran parte delle parole si trovano in tutti i dizionari, magari presentate in modo differente. I neologismi sono in genere accolti con prudenza: diversamente un dizionario rischia di apparire invecchiato appena pubblicato, perché gran parte delle parole che si affacciano sul nostro orizzonte linguistico (televisione, social network ecc.) ha vita brevissima e non attecchisce. Oltre alle singole parole, poi, bisogna prestare molto attenzione alle nuove accezioni e a quelle che tendono a regredire. Due esempi. Per indicare chi ha una relazione affettiva anche stabile con un'altra persona senza il vincolo del matrimonio è oggi usuale compagno, compagna, mentre un tempo c'erano solo i compagni di scuola o quelli di partito; signorina si usa ancora in riferimento a una ragazza, ma è una parola ormai quasi in disuso per indicare una settantenne nubile. Quale che sia il suo stato civile, ci viene spontaneo di chiamarla signora, non signorina.
5. Petaloso= italiano consegnato al banale?
La creazione estemporanea di petaloso da parte di un bambino ha avuto una pubblicità esagerata (anche se la maestra ha fatto bene a dare soddisfazione al suo alunno, interpellando persino l'Accademia della Crusca). I bambini, in quanto parlanti ancora acerbi, inventano parole ben formate, cioè rispettose dei meccanismi formativi dell'italiano (petalo → petaloso come fumo → fumoso), ma inesistenti. Tutte le parole nuove che riescono ad affermarsi hanno un inventore, che in genere resta sconosciuto; ma è ben difficile che tra un anno qualcuno si ricordi ancora di petaloso, una creazione destinata a tornare nel nulla come gran parte dei neologismi occasionali.
6. Qual è il futuro dell’italiano? Lo intravede prospero o declinante?
Difficile fare profezie in questo campo (e fare profezie in genere). Due variabili da tener d'occhio per misurare la salute dell'italiano, e quindi i suoi assetti futuri, sono il possesso della lingua intellettuale da parte delle nuove generazioni, a cui già accennavo, e la fortuna dell'italiano all'estero. Qualche anno fa c'era una grande richiesta di italiano nel mondo: secondo alcuni calcoli, l'italiano era addirittura la quarta lingua più studiata nel mondo; oggi la situazione è meno rosea, anche perché nel borsino delle lingue si sono fatti spazio altri idiomi, a partire dal cinese. Sostenere lo studio dell'italiano all'estero dovrebbe essere una priorità del governo, anche per le ricadute economiche, come ben sanno paesi a noi vicini come Francia, Germania, Spagna e anche Portogallo.
7. Ci sono tecniche per sollecitare i giovani ad utilizzare aggettivi e verbi che non siano sempre gli stessi?
Sono utili degli esercizi presentati in forma di gioco, concepiti per stimolare queste competenze, che potrebbero essere proposti a scuola, accanto a quelli più tradizionali. Ne ho parlato in un mio volume di qualche anno fa, Leggere, scrivere, argomentare, Laterza.
8. Come può essere intesa la scelta degli italiani di usare sempre più anglicismi per esprimere emozioni, fatti, eventi e prodotti?
C'è sicuramente una buona dose di provincialismo ("l'erba del vicino è sempre più verde" è un tipico proverbio nostrano). In realtà coloro che davvero padroneggiano una lingua straniera, poniamo l'inglese, non fanno nessuno sfoggio di anglicismi inutili; direi che non hanno nessun complesso di inferiorità nei confronti di quella che è oggi la lingua veicolare mondiale: la usano quando serve, senza rinunciare alla madrelingua. È anche un fatto di attaccamento alla propria identità, di amore per le proprie radici.
9. Uno dei casi rari – fortemente marcato nell’introduzione del dizionario da lei curato – in cui l’italiano si impone su un termine tecnologico inglese è nuvola digitale. Cosa si prova quando gli italiani decidono di italianizzare un vocabolo inglese?
Ovviamente mi fa molto piacere. È una conferma che non esistono parole o espressioni intraducibili in un'altra lingua.
10. Quanto tempo ci vuole per redigere un dizionario? È un'impresa ardua o ci sono particolari tecniche?
Il tempo varia a seconda dei traguardi che ci si prefigge e delle risorse finanziarie che l'editore decide di investire nell'impresa. Oggi la disponibilità di grandi archivi digitali permetterebbe di verificare l'uso delle singole parole (le loro accezioni, le collocazioni più frequenti ecc.). Ma naturalmente una ricognizione così ampia (anche se ridotta alle parole più frequenti, che sono pur sempre alcune migliaia) richiede tempi lunghi e un rischio d'impresa non trascurabile. Tutti fattori con cui fare i conti. Del resto mi pare che anche all'estero non abbiano messo mano a un'impresa così ambiziosa.
11. Quali letture si sente di consigliare a ragazzi appassionati della storia dell’italiano e della letteratura?
Il piacere della lettura non dovrebbe essere imposto: da piacere diventerebbe dovere, se non addirittura noia. Diciamo che, se un adolescente mi chiedesse un consiglio, gli suggerirei da un lato i grandi classici della letteratura europea in traduzione, da Tolstoj a Mann (che, oltretutto, essendo tradotti in italiano moderno, non presenterebbero difficoltà linguistiche), dall'altro i saggi di alta divulgazione sui grandi temi della civiltà contemporanea: dalla geopolitica al rapporto tra le religioni alle trasformazioni della scienza. Naturalmente c'è anche la letteratura nazionale che non c'è modo di studiare a scuola; e allora suggerirei alcuni significativi titoli del Novecento, dal Deserto dei Tartari di Dino Buzzati, al Gattopardo di Tomasi di Lampedusa all'Isola di Arturo di Elsa Morante, solo per citare qualche titolo.
12. In che modo voi linguisti inserite nuove voci in un dizionario? Ci sono determinati standard?
La redazione di un dizionario mantiene un irriducibile margine di artigianato. È solo l'esperienza dei redattori, il loro "senso della lingua", che suggerisce di fare spazio a una parola che mostra di avere le gambe per farsi strada nella lingua comune. Tenendo conto di una variabile puramente esterna: un dizionario non può dilatarsi perché perderebbe la necessaria maneggevolezza e costerebbe troppo: di massima, le nuove accessioni devono essere controbilanciate da un certo numero di lemmi da cancellare, e non è mai facile escludere parole, anche rare e specialistiche, che appartengono comunque all'italiano, a una sua fase storica o a un suo particolare ambito d'uso.
Alessio Cozzolino e Luca Serianni ( per aver fornito le risposte)
UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE
Voglio ringraziare naturalmente il prof. Serianni per aver risposto alle mie domande allegando consigli e segnalazioni. Ripeto nuovamente: - Grazie di cuore.
Hai perso l'intervista a Federico Roncoroni? CLICCA QUI: https://www.skuola.net/news/blog/federico-roncoroni-l-amore-per-i-libri-e-la-cultura.html






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo