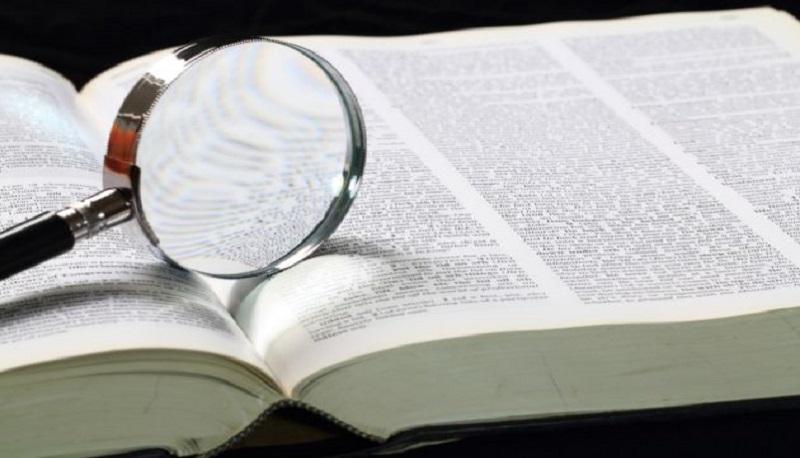
1. ‘Mestiere lessicografo’ era il titolo del libro scritto dal suo collega e collaboratore prof. Mario Cannella. Ebbene, lei come giudica il lavoro che svolge?
Ho sempre desiderato lavorare con le parole e, non avendo abbastanza fantasia per scrivere romanzi, ho trovato un’ottima opportunità nella lessicografia dove la creatività deve essere guidata da precisione e rigore scientifico.
2. Lei ha sempre lavorato nel campo lessicografico. Qual è la maggiore soddisfazione che le dà questo mestiere?
Un aspetto del mio lavoro che mi affascina è la varietà di argomenti attraverso i quali si spazia, dal daspo alla monetica, dalla prova regina al digitale terrestre, dall'Antropocene all'acquaponica; è stata una bella sfida per me, digiuna di fisica, riuscire a capire le onde gravitazionali e qui mi riallaccio alla seconda parte della domanda per dire che una cosa che mi dà grande soddisfazione è trovare la formula giusta per scrivere una definizione in modo che risulti esauriente e chiara per il lettore.
3. Ci sono dei parametri che vi consentono di ritenere una voce degna di far parte del vocabolario della lingua italiana?
Sostanzialmente una parola per ambire a essere accolta nel dizionario deve avere uno o più di questi tre requisiti: 1) provenire da una fonte autorevole o essere molto diffusa: 3 o 4 mila occorrenze nelle principali fonti lessicografiche ne fanno una candidata con alte probabilità di successo (calendarizzare, enoturismo, apericena, leopardato, refertare, kebab); 2) essere argomento di un provvedimento legislativo o essere legata a un'innovazione tecnologica o scientifica (riccometro, bigenitoriale, cogenitore, videoguida, rigassificatore, ogm, biomarcatore, epigenetica); 3) essere espressione di un momento sociale o culturale significativo (bioparco, ecodiesel, vegano, bipartisan, mobbing, enoturismo).
4. Questa è una delle domande ‘classiche’ che solitamente vengono poste ai lessicografi. Chi scrive le voci? Vengono arricchite annualmente?
Le persone che intervengono nella lavorazione dello Zingarelli sono elencate nella pagina dei crediti o colophon. Ma immagino che lo scopo della domanda sia sapere come questa lavorazione avviene. Nel corso dell'anno raccogliamo segnalazioni da lettori, da colleghi che si occupano dei testi scolastici o ne facciamo noi stessi a partire dallo spoglio di pubblicazioni, giornali o corpora testuali. Quindi ci incontriamo per scegliere quali inserire nel dizionario, perché in possesso dei requisiti elencati sopra, quali bocciare e quali sospendere in attesa di vedere se il loro uso si affermerà o se è solo legato a un fenomeno temporaneo. Quasi mai si è capitato di togliere una parola perché entrata in base a una valutazione non sufficientemente ponderata.
Le parole scelte vengono divise fra specialistiche e di lingua comune. Le parole di lingua comune vengono definite da Mario Cannella, le altre dai vari specialisti in base alla loro competenza. Dopo la prima fase di scrittura si avvia un paziente lavoro di lettura, riscrittura e limatura, soprattutto delle definizioni dei termini scientifici, il cui linguaggio è in genere più complesso. Vengono infine aggiunti etimologia e pronuncia.
Parallelamente viene svolto un lavoro di rilettura e di aggiornamento non solo per aggiungere nuovi significati ma anche per migliorare la leggibilità di alcune definizioni o per adattarle al cambiamento dei costumi e alla diversa sensibilità nei confronti di alcuni fenomeni. Con un certo puntiglio abbiamo cercato di eliminare l’immagine stereotipata presentata nei dizionari delle donne, tradizionalmente protagoniste privilegiate di esempi di voci quali capriccioso, incostante, frivolo, tradimento, delusione. Dare alla voce 'accendere' come esempio 'un videoregistratore' è anacronistico così come esemplificare dei costi in lire. Questo oscuro (perché per lo più passato sotto silenzio) lavoro di migliorie è il vero principio vitale del dizionario che, più dei neologismi, lo tiene al passo con i tempi e ancorato alla realtà. In concreto, nell'edizione 2017 sono stati fatti più di 7000 interventi su quasi 6000 voci, vale a dire più di 3 interventi a pagina, senza contare i neologismi.
5. Come si può risalire alla data d’origine di un lemma?
La data di nascita di una parola viene in genere fissata nella sua prima attestazione scritta. Le prime datazioni sono state attribuite spogliando manualmente i volumi cartacei. In tempi più recenti un grosso aiuto ci è venuto dalla tecnologia perché buona parte dei testi sono stati digitalizzati ed è stato possibile costruire dei corpora all’interno dei quali la ricerca, attraverso indicizzazioni e ricerche mirate, è molto più facile. Inoltre questi corpora vengono continuamente arricchiti con nuove opere: solo nello scorso anno siamo stati in gradi di retrodatare 4000 parole. Quest'anno abbiamo in programma un lavoro analogo con l’obiettivo di retrodatarne almeno un altro migliaio.
6. Nel campo dell’editoria dei dizionari, qual è l’elemento vincente per affermarsi?
Se ne fossimo in possesso, non sarebbe un segreto da divulgare. A parte le battute credo che il successo di un dizionario, ma lo stesso si può dire di molti altri prodotti, dipenda un mix di abilità editoriale e forza commerciale. Perché il successo sia duraturo deve essere ancorato a solide fondamenta costituite da qualità. La qualità è data dal rigore delle definizioni e dalla loro completezza; importanti sono anche gli apparati didattici e la loro leggibilità.
Sicuramente una tradizione lessicografica, che significa anche esperienza, quale quella della Zanichelli, gioca un ruolo non indifferente. Questa ci ha messi in grado di presentare, in anticipo sui tempi, le nostre opere in versione digitale, prima per computer fissi e portatili, oggi per smartphone e tablet. In questa operazione, fondamentale ovviamente è stato l’investimento economico.
7. Sfumature di significato: può spiegare cosa sono in maniera esauriente?
Tutti i linguisti sono d'accordo nell'affermare che, salvo pochissime eccezioni, non esistono parole così somiglianti da poter essere usate indifferentemente in tutte le occasioni. È però altrettanto vero che esistono parole i cui significati sono in buona parte sovrapponibili e si discostano per leggere differenze di significato, sfumature, appunto. La differenza può essere dovuta al registro, cioè il contesto in cui avviene la comunicazione (formale, burocratico, familiare), per esempio i risultati di un concorso si comunicano non si dicono; i diritti di un minore si tutelano non si proteggono, anche se l'operazione è la stessa; per intensità: spaccarsi una gamba sembra più doloroso che rompersela; per un retroscena affettivo o emotivo, dire che adoro leggere implica un trasporto maggiore che dire mi piace leggere; o semplicemente per scelte stilistiche, per esempio dire, descrivendo un compagno, che ha i capelli corvini invece di neri, si fa una scelta stilistica. Le sfumature di significato, cioè le brevi trattazione inserite tra le voci dello Zingarelli indagano quell'area semantica, cioè quella parte di significato specifica, non condivisa dei termini, e guida a scegliere fra le tante opzioni quella più appropriata al contesto comunicativo e al concetto che si vuole trasmettere.
Una domanda sorta spontanea nel momento in cui stendevo i quesiti era quella riguardante la salute dell’italiano. I sostantivi della lingua in cui ‘viviamo’ – riferimento al titolo del libro del prof. Giuseppe Antonelli – costituiscono un sistema a rapida obsolescenza. Chi, meglio di un’esperta a contatto quotidianamente con le parole, può soddisfare tale curiosità?
8. La lingua è lo specchio del popolo che la parla. L’italiano come si sta evolvendo? Positivamente o negativamente?
La lingua è un organismo vivo e come tale cambia e si evolve. Come si evolve dipende da molte circostanze. È difficile dare un giudizio su un fenomeno mentre lo si sta vivendo, per essere obiettivi bisognerebbe poterlo guardare da una certa distanza. ‘Ai posteri l’ardua sentenza’ dice uno dei padri della lingua italiana.
9. Doodle e trollare sono esempi di prestiti linguistici che arricchiscono positivamente l’italiano o negativamente? I prestiti linguistici fanno ‘bene’ alla salute dell’italiano?
A differenza del linguista che studia le strutture e i meccanismi interni alla lingua, il lessicografo ha un atteggiamento paragonabile a quello di un documentarista. Ciò non toglie che abbia delle opinioni e operi delle scelte, che si traducono nella selezione delle parole da 'documentare' o meno. I prestiti linguistici sono inevitabili e ci sono sempre stati. Parole come garage, freezer, abat-jour, jeans sono considerate italiane a pieno titolo, tanto che hanno generato alterati e derivati (garagetto, freezerino, jeanseria); in altri casi le parole straniere sono entrate nella nostra lingua con una grafia adattata (beefsteak > bistecca). A loro volta, molte parole italiane sono state accolte in altre lingue, specialmente quelle provenienti dal mondo dell'arte, come la musica e la pittura (tenore, soprano, allegro, sonata, fresco, amorino), e dalla cucina (e qui non c’è bisogno di esempi). Quindi uno scambio con altre lingue è fisiologico.
Indubbiamente il fatto che il mondo scientifico si esprima prevalentemente in inglese e che questa sia anche la lingua principale della tecnologia, unito all'idea dell'inglese come lingua di prestigio, fa sì che l'inglese prevalga sulle altre lingue e alimenti un uso di forestierismi, spesso ingiustificato. Non aiutano i politici che per designare provvedimenti ricorrono a termini stranieri come jobs act, spread. spending review, welfare, foreign fighters, deregulation. A proposito della scelta di un termine inglese al posto dell'equivalente italiano, in politica, dice Michele A. Cortelazzo: "Alla base sta un mix micidiale di esibizionismo e provincialismo, ma anche l'idea che un provvedimento designato da un nome inglese appaia più attraente, moderno ed efficiente di un provvedimento dal nome italiano".
In favore dei forestierismi esiste anche una questione di economia nella comunicazione. La parola inglese ‘file’ nella sua lingua d'origine ha una decina di significati, in italiano ne ha solo uno; l’equivalente italiano ‘archivio’ di primo acchito proietta l’immagine di una stanza ingombra di faldoni polverosi e solo il contesto ci porterebbe verso il termine informatico, superandone l’ambiguità. Quindi l’uso dell’inglese ‘file’ al posto di ‘archivio’ comporta una comunicazione immediata e precisa, quindi un vantaggio. La parola ‘privacy’ per esempio non vuol dire soltanto 'intimità' o 'privato' ma introduce un concetto relativamente nuovo ed indica la 'sfera della vita personale e privata'. Quindi è un termine che è associato a un nuovo concetto e non ha usurpato nessun posto.
Noi, come tentativo di resistenza, in presenza di un termine straniero, equivalente semanticamente a un termine italiano, scegliamo di spiegare quest'ultimo definendo l'altro come sinonimo. È il caso di digital divide, hard disk, head-hunter, park and ride; però, per i motivi accennati sopra, sappiamo che nella lotta selfie vs. autoscatto quest'ultimo non ha speranze.
Difendere la propria lingua fa parte della difesa della propria identità quindi ben vengano le parole straniere, ben venga la contaminazione, che vuol dire arricchimento, ma con buonsenso e moderazione limitandosi a importare le parole intraducibili o quelle che richiedono una lunga perifrasi per essere tradotte.
10. Quale consiglio dà a coloro che ambiscono a diventare come lei?
Come per altri lavori, fondamentale è una buona preparazione basata su conoscenze grammaticali e linguistiche nonché una formazione culturale ad ampio raggio. In questo mestiere specifico doti determinanti sono la curiosità, la pazienza e il buon senso. Non a caso ho usato il termine mestiere perché non sono tanto gli studi e la preparazione a fare di un lavoratore un lessicografo quanto ‘l’esperienza e la pratica’, come si legge nella definizione di mestiere nello Zingarelli, maturate a fianco di persone già esperte, come ho avuto la fortuna io di avere accanto, dalle quali apprendere con pazienza il buon senso da applicare a parole o fenomeni linguistici a prima vista sconcertanti.
Se Luca Serianni ha affermato che il dizionario secondo gli studenti “è un talismano” l’opinione di Beata Lazzarini è simile.
11. I giovani, secondo lei, considerano il vocabolario come l’amico ‘occasionale’ pesante da portare a scuola oppure come un fedele compagno di vita?
Da indagini che anche noi abbiamo svolto, è per lo più vera la tua supposizione, ahimè, che il vocabolario sia considerato più come un potenziale salvagente in occasione di prove scolastiche importanti, come le verifiche, che una miniera di informazioni a cui attingere in ogni occasione, quale in effetti è. Di solito si consulta il vocabolario per sapere il significato di una parola, o come si scrive, o come fa al plurale, o qual è il condizionale di un verbo, sfruttando solo una minima parte del suo contenuto. Per esempio, la definizione può sorprenderci perché focalizza degli aspetti che non avevamo considerato; la fraseologia ci illustra il contesto d'uso, ci suggerisce scenari inediti e quindi amplia la nostra idea iniziale; i sinonimi, i contrari e le parole analoghe creano una rete concettuale che ci aiuta a sviluppare il nostro pensiero. Basterebbe leggersi la guida grafica alla consultazione, due pagine con indicazioni estremamente sintetiche, per avere una panoramica delle potenzialità dell'opera. Perché, per trarre profitto da questo monolito pesante e costoso, bisogna imparare a conoscerlo e, se non si ha la pazienza di leggere le istruzioni, bisogna provare a prenderci confidenza con la pratica, come si fa con un nuovo telefono o un nuovo gioco: sfogliandolo, provandolo, sperimentando in modo che nel momento in cui ne abbiamo bisogno, quando il tempo a disposizione è generalmente poco, riusciamo velocemente a trarne le informazioni che ci servono.
Diffuso è il pregiudizio secondo cui il vocabolario è difficile ma, nel corso degli ultimi anni, anche grazie alle edizioni annuali, è stato fatto un grosso lavoro di “avvicinamento” al lettore. Sono state apportate modifiche grafiche, con l'introduzione del secondo colore, di fondini colorati o parti della voce in grassetto per migliorarne la leggibilità; stilistiche, adottando un linguaggio più scorrevole ed eliminando quei formalismi tipici dei vocabolari; nello Zingarelli non trovi nessuna definizione che inizia con "Dicesi di una sostanza …".
Alcuni insegnanti organizzano esercitazioni in classe perché si rendono conto del vantaggio che possono trarne gli studenti, ma spesso il programma da svolgere ha la meglio. Mi sento di affermare che imparare a usare bene un dizionario è un investimento per la vita come imparare ad andare in bicicletta o a nuotare.
12. In conclusione, qual è il giusto rapporto che dobbiamo instaurare col nostro amico cartaceo?
Per conservare un'amicizia bisogna frequentarsi; quindi, per tenere in buona salute il rapporto con il nostro amico cartaceo, l'ideale è stare in contatto, se non quotidianamente con molta frequenza: così, come ogni buona amicizia, ci aiuterà ad ampliare la nostra apertura mentale, a sviluppare nuove conoscenze e si ci sarà di sostegno nei momenti critici.
Nota
Grazie di cuore alla cordialissima signora Lazzarini, nonché a Laura Lisci, dell’ufficio stampa Zanichelli, la quale con molta professionalità è riuscita a creare tutto ciò. È per questo motivo che dedico loro questo testo.
ALESSIO COZZOLINO (CON LE RISPOSTE DI BEATA LAZZARINI).






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo