Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Introduzione Il sonno della ragione genera mostri, tesina
Questa tesina di maturità tratta i seguenti argomenti: superomismo di D'annunzio e Nietzsche, nazismo, stalinismo, Hannah Arendt, la scoperta del DNA come distruzione della "razza pura" di Hitler, Freud e la psicanalisi, genio e follia, Orwell e Apuleio.
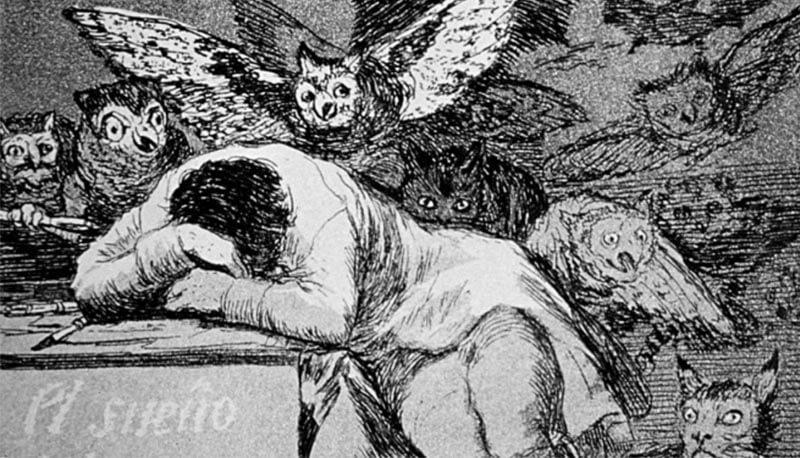
Il Decadentismo
Con il termine Decadentismo si definiscono tutti quei movimenti artistici e letterari
sviluppatisi in Europa a partire dalla seconda metà dell'Ottocento fino agli inizi del XX
secolo che si contrappongono dialetticamente alla razionalità del positivismo scientifico.
L'origine del termine
Il termine Decadentismo deriva dalla parola francese décadent, che significa appunto
decadente, e si riferisce al sonetto "Languore", pubblicato il 26 maggio 1883 su un
periodico francese intitolato "Il gatto nero" (Le Chat Noir) dal poeta francese Verlaine.
Questo tema della "decadenza sociale" fu ripreso da un gruppo di scrittori, che intitolarono
una rivista con il nome di "Le Decadent", che trattava proprio i vari aspetti della crisi. Nello
stesso anno, Verlaine pubblica "Poètes maudits".
Il termine originariamente indicava un determinato movimento letterario nato nella Parigi di
fine Ottocento. Siccome all’interno di questo movimento vi erano altre correnti che poi si
sarebbero sviluppate autonomamente, la storiografia letteraria italiana, nel Novecento, ha
assunto il termine a designare un intero movimento letterario di portata europea. L’uso del
termine con questo suo secondo significato è prevalentemente diffuso in Italia mentre in
altri paesi sono preferite diverse denominazioni, quali ad esempio il "simbolismo".
La critica ufficiale usò il termine decadentismo proprio per sottolineare la sensazione di
crollo di una civiltà. La critica usò questo termine con una accezione negativa ma gli
intellettuali che facevano parte di quel gruppo, definito come “decadente”, ribaltarono il
significato, arrivando ad indicare un privilegio spirituale e ne fecero una sorta di bandiera
da esibire con orgoglio e dedizione.
Il crollo del positivismo
Il positivismo, movimento dedito al progresso e alla ricerca scientifica, non fu più capace di
dare risposte all'uomo, e le scoperte scientifiche vennero "sentite" quasi come un senso
del limite, perché incapaci di spiegare gli interrogativi umani. Infatti, tutte le risposte (tra cui
esistenziali) che l'uomo cercava attraverso la scienza non furono trovate. La scienza
dovette ammettere i suoi limiti, come per i fenomeni naturali, che non era propriamente in
grado di spiegare, ma solamente di classificare e categorizzare.
Le basi filosofiche e scientifiche
La nascita di nuove correnti spiritualistiche e irrazionalistiche, così come nuove filosofie,
aiutarono a screditare ulteriormente il positivismo e la scienza in generale, favorendo la
ricerca spirituale e interiore.
Infine, la nascita della psicoanalisi di Sigmund Freud fu interpretata come una base
scientifica del Decadentismo, in quanto riusciva a spiegare i vari istinti e riflessi inconsci
che erano alla base della creazione poetica e letteraria di ogni artista decadente. L'eroe
decadente si chiude infatti sempre più in se stesso, cercando di ascoltare quelle voci
interiori e quelle folgorazione che lo portavano a trovare le famose "correspondances",
cioè le corrispondenze che collegano in modo misterioso tutte le cose.
Il precursore è Charles Baudelaire che sottolinea i due aspetti entro cui si dibatte la crisi
dell'intellettuale: lo Spleen (noia e disgusto della vita) e l'Ideal (ricerca di un ideale, come
fuga verso mondi lontani, esotici, dalla natura incontaminata o verso paradisi artificiali).
Il decadentismo in Italia
In Italia si è soliti individuare due periodi distinti di decadentismo: il primo, di cui facevano
parte D'Annunzio e Pascoli, è ancora caratterizzato dalla necessità di costruire miti
decadenti. Al contrario nel secondo, di cui occorre ricordare in particolare Pirandello e
Svevo, la coscienza della crisi è ormai acquisita e la realtà viene sottoposta ad una critica
molto lucida e distruttiva. Il termine "Decadente" fu, in origine usato in senso dispregiativo,
per indicare giovani poeti che vivevano fuori dalle norme comuni. Più tardi passò a
designare la dilagante "decadenza" della società materialista di fine secolo, orientata
verso l'esaltazione delle conquiste tecnologiche e dalla quale gli intellettuali si sentivano
estranei. Essi, infatti, si considerano decadenti, con un atteggiamento di superiorità
spirituale, in quanto inclini a cogliere i segni della raffinatezza e dell'eleganza intellettuale
delle epoche di "decadenza".
Gli aspetti del Decadentismo
Il poeta veggente
Il Decadentismo è caratterizzato da una nuova tipologia di poeta che diventa veggente,
cioè colui che vede e sente mondi arcani ed invisibili in cui si chiude.
Il poeta è così un artista solitario, capace di scavare nell'interiorità umana e nel mistero
dell'ignoto. Anche la parola poetica cambia: non si usa più per descrivere sentimenti ma,
soprattutto, per decifrare sensazioni e per illuminare l'oscuro che è in noi. Da qui la grande
importanza della poesia come mezzo per esprimere il proprio intimo. Caratteristica
generale è quindi un forte senso d'individualismo e soggettivismo.
Le poetiche
Grazie alla natura intrinseca del decadentismo questo movimento diede origine a diverse
correnti o poetiche particolari. Fra le tante sono presenti il simbolismo, l'estetismo,
l'impressionismo, il surrealismo, il dadaismo, e nell'ambito italiano il panismo, l'ermetismo,
il futurismo e il crepuscolarismo.
Simbolismo
Il simbolismo infatti tende ad una descrizione soggettiva piuttosto che ad una oggettiva,
come accadeva nel realismo. Questa sua natura la porta ad avere un grande sviluppo con
la nascita del decadentismo, che predilige il lato misterioso e onirico piuttosto che quello
scientifico e reale. In contrasto con la simbologia tipicamente medievale il simbolismo
decadente viene definito istintivo, e predilige le sensazioni e le corrispondenze segrete tra
tutte le cose, così come figure retoriche come l'analogia, la metafora o la sinestesia,
scovate tramite folgorazioni ed intuizioni dal poeta veggente.
Estetismo
L'estetismo afferma che l'arte deve ispirare le vita, perché tutta la cattiva arte trae origine
dal ritorno alla vita e alla natura. Viene spesso considerata la più frivola delle correnti affini
al decadentismo, in quanto il solo scopo è quello di esaltare il gusto del bello e dell’arte,
tanto da mettere i valori sociali e familiari in secondo piano. Tra gli esponenti di questa
corrente ricordiamo Oscar Wilde con "Il ritratto di Dorian Gray" e Gabriele D'Annunzio con
"Il piacere".
Panismo
Il panismo deriva dal greco, significa tutto, e si riferisce alla tendenza del confondersi e
mescolarsi con il Tutto e con l'assoluto, due concetti chiave del decadentismo. In
D'Annunzio il tutto prende la forma della natura, riferimento al dio greco Pan, divinità dei
boschi.
Superomismo
Altra corrente legata al decadentismo è il "superomismo", teorizzato in chiave filosofica da
Nietzsche. Il superomismo è alimentato dalla filosofia di Nietzsche e dalla sua esaltazione
del vitalismo, della volontà di potenza propria dell’uomo superiore, trasforma l’esteta in
qualcosa di diverso: in superuomo, esteta armato. L’esteta abbandona la sua clausura, la
passività, il ripiegamento su sé stesso, ed esce allo scoperto cercando l’azione. E’ proprio
nell’azione che questo nuovo tipo di esteta- superuomo troverà il senso della propria
esistenza, la propria affermazione, che rappresenta l’unico valore nel tempo della morte di
Dio, cioè alla fine di tutti i valori della civiltà europea improntata sul cristianesimo.
Anche il concetto di azione è inteso dal punto di vista etico: da qui l’esaltazione del “bel
gesto”, del gesto memorabile, dell’azione rischiosa e spericolata, dell’azzardo in cui in un
attimo ci si gioca tutto; ed ecco il culto per la “bella morte”, nella sua prefazione
assimilabile a un’opera d’arte tramite la quale attingere una sorta di immortalità.
GABRIELE D’ANNUNZIO:
Si colloca ne contesto del Decadentismo in ragione di una vita vissuta all’insegna del
“vivere inimitabile”, all’insegna del gusto estetico della vita che deve essere vissuta come
un’opera d’arte.
Fu culture dell’estetismo cioè la tendenza a esaltare l’arte e la bellezza come valori di vita
che sostituiscono quelli tradizionali della morale borghese,ragione per cui D’Annunzio
conduce una vita anti-conformista al pari degli intellettuali decadenti infatti incarna il
DANDY’. Possiamo considerare l’estetismo la parola chiave della poetica dannunziana e
lo è in particolare nella prima fase che arriva fino al 1889, anno in cui viene pubblicato il
piacere che segna la crisi dell’estetismo. D’annunzio vive una vita in cui i criteri di
ispirazione non erano i principi del bene e del male ma erano quelli del lusso, della moda,
della bellezza e del gusto raffinato per l’arte. D’annunzio è un intellettuale che lotta contro
la borghesia ma che tuttavia e vittima di questo sistema e questo rappresenta il conflitto
che non saprà mai sanare. il poeta era consapevole che l’artista aveva perso l’aureola, la
posizione di privilegio all’interno della società, perciò sceglie di vivere la vita a suo modo,
attirando l’attenzione del pubblico.
Gabriele D’annunzio nasce a Pescara nel1863 da una famiglia aristocratica. Compie gli
studi liceali a Prato in Toscana,poi si trasferisce a Roma, dove si iscrive alla facoltà di
lettere senza conseguire la laurea. A Roma conduce l’attività di giornalismo vivendo una
vita all’insegna dello scandalo. Nel 1879, a sedici anni pubblica la prima raccolta di liriche
“PRIMO-VERE”.
Sono questi gli anni in cui si costruisce la maschera dell’Esteta cioè dell’individuo
superiore che si rifugia in un mondo fatto di arte; di fatto rifiuta la morale borghese e
accetta come regola il bello; non si rifà agli ideali del bene e del male. Negli anni 90
abbiamo poi una crisi : a cui trova la soluzione dopo la fare della Bontà le sue scelte
contenutistiche mirano ora a tematiche morali. La soluzione la trova in una concezione di
vita attivistica ed eroica: è questa la fase del SUPERONISMO: che segna il superamento
dell’estetismo ma non l’abbandono.
L’adesione totale gli sarà poi offerta dalla storia,nel periodo della prima guerra mondiale
(1915) quando egli si schiera a favore degli interventisti dopo aver militato prima nella
destra e poi nella sinistra. L’adesione al superomismo si ha con la prima guerra mondiale
quando D’Annunzio si fa interprete dell’insoddisfazione degli italiani per il mito della vittoria
mutilata, con una frase storica “VADO VERSO LA VITA”1897.
Egli stesso a 52 anni si arruola , ma non combatté una guerra di trincea ma una guerra di
clamore e campeggia una marcia sulla città di fiume dove istaura una REPUBLICA
INDIPENDENTE PERSONALE, sfidando lo stato italiano nel 1920. Il fascismo che si
alimenta di questo esalta D’Annunzio come padre della patria. Trascorre gli ultimi anni
della sua vita presso la sua casa museo (il Vittoriale degli italiani) sul lago di Garda, qui si
dedica alla cura dell’edizione delle sue opere, fino alla morte, avvenuta nel 1938.
La figura di D’Annunzio incide profondamente sulla cultura, sulla mentalità e il suo modello
di vita sarà chiamato d’dannunzianesimo. Incide anche sulla politica tant’è che egli
elaborerà slogan che saranno fatti propri dal fascismo.
Troviamo tre fasi in D’Annunzio:
1: Fase dell’estetismo
bontà
2: Fase della come soluzione intermedia alla crisi dell’estetismo e dedita allo
sperimentalismo. D’Annunzio subisce il fascino dei romanzo russo che si riscontra nel
“GIOVANNI EPISCOPO” e ne’ ”INNOCENTE” .In questa fase sono trattati i valori morali
ed essa comprende anke la raccolta “POEMA PARADISIACO” (1893) in cui è evidente il
desiderio di recuperare l’innocenza dell’infanzia, di ritornare alle cose semplici agli affetti
familiari. In realtà però vi sono anche temi più ambigui provenienti dal decadentismo
bontà
francese come atmosfere sfatte, paesaggi percossi da un senso di morte. La è solo
una soluzione provvisoria, uno sbocco alternativo alla crisi dell’estetismo scaturirà dalla








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









