
Se c’è un argomento che può facilmente emergere durante il colloquio orale della Maturità 2025, è la Seconda guerra mondiale. Perché il conflitto del 1939-1945 non è solo un tema storico, ma un crocevia di linguaggi, saperi e memorie che attraversano trasversalmente quasi tutte le discipline scolastiche.
Dalla letteratura alla filosofia, dalla fisica all’arte, fino a toccare i principi fondamentali dell’educazione civica, il conflitto mondiale continua a produrre domande, interpretazioni, ferite aperte e riflessioni necessarie.
E se tra i materiali scelti dalla commissione dovesse comparire una fotografia di un bombardamento, un estratto da un diario, un trattato postbellico o un’opera d’arte carica di dolore e denuncia, saper leggere quella traccia in chiave interdisciplinare può fare la differenza.
Ecco allora alcuni spunti per collegare la Seconda guerra mondiale alle principali materie oggetto di valutazione durante il colloquio orale.
Indice
- Collegamenti Maturità 2025, Italiano: la guerra raccontata da chi l’ha vissuta
- Inglese: totalitarismi, memoria e resistenza
- Filosofia: l’etica dopo la catastrofe
- Storia dell’arte: tra denuncia e memoria
- Fisica: Hiroshima e l’ambivalenza del sapere
- Educazione civica: i diritti ricostruiti dopo la distruzione
Collegamenti Maturità 2025, Italiano: la guerra raccontata da chi l’ha vissuta
La letteratura italiana Novecento, specie se prodotta in quel periodo storico, è pervasa dalla guerra. Non come sfondo, ma come materia viva, dolorosa. Primo Levi, con Se questo è un uomo, è forse il riferimento più immediato: una scrittura limpida, documentaria, che diventa memoria collettiva e atto di denuncia. Ma accanto a lui ci sono Elio Vittorini (Uomini e no), che racconta l’esperienza partigiana urbana, e Beppe Fenoglio, con Il partigiano Johnny, dove la Resistenza si fa dramma interiore, dubbio, tensione morale.
Anche Italo Calvino, ne Il sentiero dei nidi di ragno, racconta la guerra ma dalla prospettiva di un bambino, aprendo un varco tra realtà e immaginazione. Senza dimenticare la poesia: Giuseppe Ungaretti, pur legato più specificamente alla Prima guerra mondiale, getta le basi per un linguaggio essenziale che influenzerà anche il modo di raccontare i conflitti successivi.
Inglese: totalitarismi, memoria e resistenza
Anche in ambito anglosassone la guerra ha lasciato un’impronta forte. George Orwell – con 1984 – descrive un futuro distopico che riprende molte dinamiche proprie del nazifascismo: la sorveglianza costante, la manipolazione del linguaggio, il culto del capo.
Un altro punto di partenza potrebbe essere il celebre discorso di Winston Churchill – “We shall fight on the beaches” – esempio perfetto di retorica bellica e coesione nazionale. Anche Wilfred Owen e i poeti di guerra inglesi, seppur anche loro legati alla Prima guerra mondiale, forniscono un precedente poetico alla rappresentazione dell’orrore e dell’assurdità del conflitto.
Filosofia: l’etica dopo la catastrofe
La Seconda guerra mondiale cambia anche la filosofia. Hannah Arendt, con La banalità del male, analizza il processo Eichmann e riflette sulla responsabilità individuale nei regimi totalitari. Theodor Adorno e Max Horkheimer, teorici della Scuola di Francoforte, si interrogano sulle condizioni che hanno reso possibile Auschwitz e criticano duramente la razionalità strumentale della modernità.
Nel contesto esistenzialista, Jean-Paul Sartre elabora una filosofia della libertà e dell’impegno, influenzato dalla Resistenza francese. La guerra diventa così anche un’occasione per riflettere sull’autenticità dell’agire umano, sulla responsabilità e sull’autodeterminazione morale in contesti estremi.
Storia dell’arte: tra denuncia e memoria
La guerra spezza, ma l’arte elabora. In Italia, Renato Guttuso – con La Crocifissione – rappresenta il dolore universale e denuncia la violenza dei regimi, fondendo iconografia religiosa e attualità. In Germania, l’esperienza di Otto Dix (più legata alla Prima guerra mondiale ma ancora incisiva nel raccontare le conseguenze dei conflitti) offre immagini disturbanti, feroci.
Negli Stati Uniti, l’Espressionismo astratto di Jackson Pollock segna una svolta: è una risposta simbolica al trauma europeo e al crollo di fiducia nella figurazione. Si possono, poi, citare anche le opere clandestine prodotte nei campi di concentramento, forme di resistenza artistica che trasformano l’arte in testimonianza e memoria.
Fisica: Hiroshima e l’ambivalenza del sapere
La guerra è anche una storia di scienza. Il Progetto Manhattan e la costruzione della bomba atomica rappresentano uno dei momenti più controversi della fisica moderna. Enrico Fermi, Robert Oppenheimer, Lise Meitner: dietro al progresso scientifico si cela una riflessione etica profonda.
Il collegamento con la Seconda guerra mondiale permette quindi di parlare di energia nucleare, reazioni a catena, ma anche di come il sapere possa essere utilizzato in funzione distruttiva. L’esplosione di Hiroshima diventa così un punto di svolta non solo storico, ma epistemologico: può la scienza essere neutrale?
Educazione civica: i diritti ricostruiti dopo la distruzione
Il dopoguerra, infine, non è solo ricostruzione materiale, ma anche giuridica e morale. Dopo la fine del conflitto nascono le Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), il Consiglio d’Europa, e prende forma l’embrione dell’attuale Unione Europea.
Il processo di Norimberga, da par suo, segna una frattura: per la prima volta si parla di crimini contro l’umanità e si afferma il principio che “obbedire agli ordini” non è un alibi. La Seconda guerra mondiale diventa quindi il fondamento per riflettere su legalità internazionale, memoria storica, cittadinanza attiva e valori costituzionali.




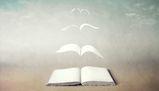
.jpg)

 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo