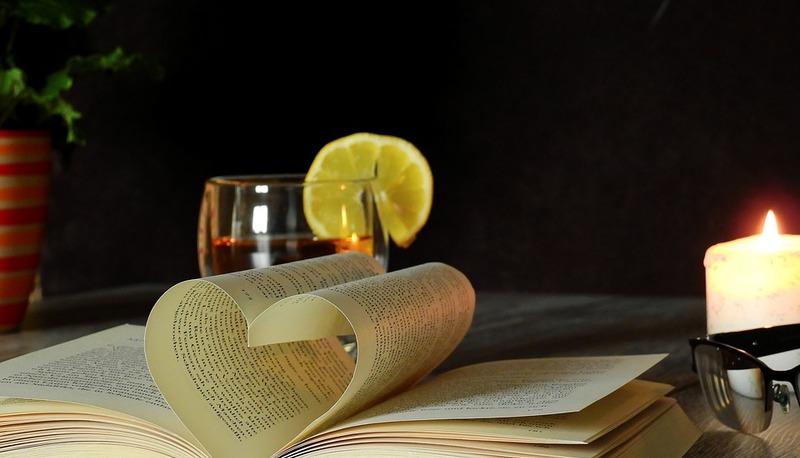
IL CULTO E L'ESALTAZIONE DELL'INFINITO IN ETA' ROMANTICA
La scelta di questo argomento è motivata da interessi personali, in merito alle manifestazioni sia filosofiche sia letterarie, della cultura romantica europea, sostanziati da letture purtroppo esigue (Novalis, Hoffman, alcune poesie dei Romantici inglesi); il Romanticismo "storico", di cui in origine intendevo parlare, mi è parso tuttavia un fenomeno culturale troppo complesso e ricco di sfumature e particolarismi per prestarsi a sintesi e generalizzazioni, che risulterebbero inevitabilmente mistificanti.
Di conseguenza, ho preferito selezionare una tematica che caratterizza la sensibilità romantica e che si concretizza in una serie di atteggiamenti filosofici, artistici ed esistenziali, il tema più tipico, che costituisce al tempo stesso l'inizio storico e il nucleo ideale del fenomeno romantico: l'insofferenza dei limiti del finito e l'aspirazione all'Assoluto.
E' infatti la "brama dell'infinito" a determinare e a rendere comprensibile la polemica contro la ragione illuministica, l'importanza attribuita al sentimento e all'arte, l'esaltazione della fede o della ragione dialettica, il predominio di stati d'animo e modi d'essere quali la Sensucht, lo Streben, il titanismo, la ricerca di una nuova armonia uomo-mondo, la dottrina idealistica dello Spirito come attività creatrice; è proprio l'infinito desiderio d' infinito che spinge i Romantici a caricare il finito di significati infiniti e a fare dell'uomo il portatore dell'Infinito, assolutizzandone e "ontologizzandone" il pensiero in quanto attività creatrice.
Il Romanticismo è stato certamente un fenomeno di portata europea, ma non ha trovato, al di fuori della Germania, dove è nato, manifestazioni paragonabili: in particolare, proprio nella filosofia tedesca d'età romantica, l'Idealismo, l'atteggiamento sopra descritto si è concretizzato nella costruzione di sistemi filosofici incentrati su un principio primo metafisico che è appunto l'Assoluto.
La filosofia idealista è filosofia dell'Assoluto, che pretende di cogliere la totalità del reale tramite la ragione, in contrapposizione alla filosofia illuminista in quanto filosofia del limite, il cui organo è l'intelletto.
Da un lato Kant ha negato ogni condizione di possibilità della metafisica in quanto scienza, dall'altro Fichte, Schelling e Hegel ricreano delle metafisiche, che tuttavia si configurano come totalmente differenti dalle prekantiane "metafisiche dell'Essere" e che sono incentrate sul Pensiero -quindi niente affatto irrazionalistiche- e sulle sue infinite capacità creative.
Oltre che dal punto di vista ontologico, l'Infinito è centrale dal punto di vista estetico, data l'importanza attribuita nel pensiero romantico all'arte, intesa come intuizione metafilosofica in grado di possedere l'Assoluto. In molti autori romantici il modello estetico diviene il modello ermeneutico per eccellenza, la principale chiave di lettura della realtà (es. per il giovane Schelling), interpretata alla luce delle note qualificanti dell'esperienza artistica: creatività e libertà.
Coerentemente, le estetiche romantiche ripudiano il principio d'imitazione e le regole classiciste dell'arte intesa come mimesis; l'estetica romantica è un'estetica della creazione, della poiesis, dell'arte in perenne divenire, conformemente alla libertà sconfinata che è attribuita all'artista. Elemento portante di queste estetiche è il concetto di sublime, in tutta la sua valenza psicologica ed esistenziale, mutuato dalle opere di alcuni autori, che si collocano in posizione intermedia fra la temperie illuminista e quella romantica: il Kant della Critica del Giudizio e Schiller.
A questo proposito, ho tentato da un lato di evidenziare le realizzazioni artistiche di questa poetica del sublime nella pittura d'età romantica (Blake, Fuessli), dall'altro di istituire un raffronto fra il tema del sublime kantiano e la più significativa teorizzazione sul sublime di epoca precedente, il Perì physeos dell'Anonimo, evidenziando parallelismi e divergenze fra due opere, così lontane fra loro nel tempo, e collocando il discorso dell'Anonimo nel contesto storico e culturale che gli è proprio.
Da ultimo, ho ritenuto opportuno soffermarmi sulla reazione che il tema dell'Infinito ha nel contesto del tutto peculiare del Romanticismo italiano, in particolare nell'opera di Giacomo Leopardi, forse l'autore più vicino a questo aspetto della sensibilità romantica, in cui però tale tematica si scontra con la formazione prettamente illuminista, nazionalista e sensista, dando origine a un Infinito che è uno stato mentale più che un'entità trascendente.
Sono consapevole del fatto che il tema dell'Infinito si presti a innumerevoli altre considerazioni, di natura filosofica (da Zenone di Elea ad Aristotele, a Lucrezio e fino ai giorni nostri), matematica, fisica, cosmologica. Tuttavia ho preferito non trattare dell'argomento in maniera diacronica, ma limitarmi ad analizzare come questo tema sia stato recepito in un preciso, determinato momento storico, ritenendo impossibile e anche presuntuoso il tentativo di discutere dell'evoluzione della categoria dell'Infinito nella storia del pensiero umano.







 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









