 La scienza è una sola. Il diviso lavoro è in economia ciò che in meccanica è il braccio di leva o la macchina a vapore; e chi lo annuncia a tutte le nazioni come verità, non è che si divaghi in prematura contemplazione dei secoli futuri, ma addita una condizione suprema della vita dei popoli presenti... Solo in seno alla libera concorrenza crediamo potersi pareggiare le sorti delle minori nazioni e delle maggiori; e raccomandarsi a imperiosa necessità d'interessi la perpetua emulazione dell'industria e dell'ingegno." Carlo Cattaneo (1801,1869) giurista, filosofo e storico.
La scienza è una sola. Il diviso lavoro è in economia ciò che in meccanica è il braccio di leva o la macchina a vapore; e chi lo annuncia a tutte le nazioni come verità, non è che si divaghi in prematura contemplazione dei secoli futuri, ma addita una condizione suprema della vita dei popoli presenti... Solo in seno alla libera concorrenza crediamo potersi pareggiare le sorti delle minori nazioni e delle maggiori; e raccomandarsi a imperiosa necessità d'interessi la perpetua emulazione dell'industria e dell'ingegno." Carlo Cattaneo (1801,1869) giurista, filosofo e storico. Il primo pensiero riportato rammenta che spesso l'innovazione (ed in particolare quella tecnologica) nasce dall'incontro/scontro di più menti diversamente da quello che, secondo Freud, accade per la creatività. Il secondo mostra come Cattaneo, uomo di profonda cultura umanistica, avesse ben compreso l'importanza della scienza, della tecnologia e dell'efficienza. In Italia, a partire dal secondo dopo guerra, pochi lo seguirono in queste sue convinzioni.
Croce (1866-1952) scriveva: "Le scienze naturali e le discipline matematiche, di buona grazia hanno ceduto alla filosofia il privilegio della verità ed esse rassegnatamente o addirittura sorridendo, confessano che i loro concetti sono solo di comodo e di pratica utilità, che non hanno niente da vedere con la meditazione del vero".
Negli anni sessanta dello scorso secolo alcuni scienziati e manager della ricerca tra cui G. Bernardini, E. Amaldi, D. Marotta, A. Buzzati-Traverso e F. Ippolito tentarono di introdurre in Italia criteri più liberali nel governo politico della scienza, basati su autonomia e valutazione di merito delle capacità e dei risultati. Si trattava di concorrere alla realizzazione di politiche in grado di governare le scelte concrete, in modo di arrivare ad efficaci soluzioni dei problemi. In pratica, prendendo ad esempio le esperienze in corso nel mondo anglosassone e sopratutto negli Stati Uniti, cercarono di creare le condizioni per sottrarre il sistema della ricerca, della scienza e della tecnologia alle logiche clientelari della politica. La loro azione venne repressa, anche attraverso un uso politico della giustizia, che portò in carcere Ippolito e Marotta con accuse strumentali.
Il risultato è stato un'asfissiante politicizzazione della scienza italiana di cui tutt'ora son ben presenti i segni:
* No alle centrali nucleari: sull'ondata emotiva del disastro di Cernobyl è passato un referendum che rendeva impossibile il finanziamento a queste centrali. Si è fatto credere che le energie rinnovabili potessero da sole sostituirsi ai combustibili fossili che generano CO2.
* No ai campi elettromagnetici: si è fatto credere che un'antenna o un ripetitore installato sul tetto di casa potesse generare il cancro ed altre terribili malattie senza neanche considerare che gli effetti dei campi elettromagnetici diminuiscono con il quadrato della distanza.
* No ai rigassificatori: si è dimenticato che questi impianti consentono di rendere gassoso il prodotto liquido di qualunque nave metaniera indipendentemente dal paese di provenienza. Grazie ad essi si può ridurre la dipendenza dai singoli paesi collegati con pipeline (in Italia prevalentemente Russia e Algeria).
* No ai temovalorizzatori: questi impianti inquinano meno di 2 autocarri, e sono il miglior completamento della strategia di riduzione dei rifiuti (meno imballaggi ecc.) e della raccolta differenziata. Essi inoltre consentono di fornire elettricità e teleriscaldamento evitando di bruciare inutilmente ulteriori quantità di gas, petrolio o carbone (in Europa vedi gli esempi virtuosi di Brescia, Parigi, Londra, Vienna, Copenaghen, Losanna, ecc.).
* No agli OGM: questi prodotti possono alleviare e forse risolvere il problema della fame nel mondo, possono ridurre i consumi di acqua e la diffusione di malattie come la malaria. Non sono rischiosi per la salute, non sono pericolosi per le colture tradizionali, non rendono onnipotenti le multinazionali e spesso sono più sicuri delle colture biologiche.
* No alla Tav: per un pendolare risparmiare 30 minuti di sonno non è indifferente. Queste nuove linee ad alta capacità permettono di far viaggiare i Tir la notte su ferro invece che su strada, di ridurre le emissioni di CO2, di decongestionare le autostrade e le linee ferroviarie normali. Si integrano bene con le autostrade del mare realizzando quel trasporto intermodale (treno, mare, gomma) naturale per la struttura geografica dell'Italia. Consentono l'integrazione con la rete A.V. europea funzionante da diversi anni in Spagna, Francia e Germania.
* No alla ricerca scientifica: le cellule staminali embrionali e adulte possono aiutare a capire e forse curare malattie degenerative come l' Alzheimer e il Parkinson. La fecondazione assistita può risolvere i drammi di molte coppie. Le cure palliative possono alleviare il dolore dei malati più gravi. Idratazione e nutrizione artificiale, come qualunque cura, non dovrebbero essere imposte per legge.
* No all'onestà intellettuale: i profilattici, oltre che efficaci contraccettivi, sono uno strumento potente per combattere la diffusione del virus HIV e di altre malattie. La pillola RU486 non rende l'aborto facile, semmai lo rende meno invasivo. La teoria dell' intelligent design non è sino ad oggi scientificamente accreditata come si voleva far credere, da parte di alcuni, nella scuola.
Nel 1998 la Commissione Europea ha dato la seguente definizione: "Il Principio di precauzione (Pdp) è un approccio alla gestione del rischio che si applica in circostanze d'incertezza scientifica e che riflette l'esigenza d'intraprendere delle azioni a fronte di un rischio potenzialmente serio senza attendere i risultati della ricerca scientifica". Come è noto però la certezza scientifica non è mai ottenibile al 100%. La scienza, a differenza delle parascienze, della cartomanzia, dell'astrologia, non offre certezze. Un uso incauto del Pdp può portare a riempire lo spazio di dubbio lasciato dalla scienza con affermazioni arbitrarie, dando voce solo alle emozioni della gente o comunque a persone non competenti che, consapevolmente o no, finiscono con lo sfruttare questi sentimenti generando una strumentalizzazione in aperto contrasto con gli interessi della collettività e con l'analisi critica delle acquisizioni scientifiche.
Se viene interpretato e utilizzato come strumento ideologico il Pdp determina la messa in atto di modalità perverse e irrazionali di affrontare i problemi connessi con il governo delle innovazioni tecnologiche, generando gli alti costi economici, sociali e ambientali della non scienza ("I Costi della non-scienza: il principio di precauzione", a cura di Battaglia e Rosati, Editrice 21mo Secolo, Milano 2004).

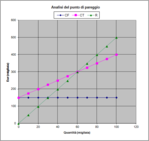
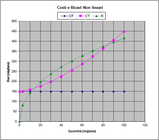






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo