Concetti Chiave
- Seneca, originario della Spagna, ebbe una formazione retorica e filosofica e una carriera politica, passando da oratore a educatore di Nerone.
- Durante il suo esilio in Corsica, Seneca scrisse le "Consolazioni" e, ritornato a Roma, produsse opere influenti come "De clementia" per Nerone.
- I "Dialogi" di Seneca affrontano temi stoici, come la gestione delle passioni e la ricerca della felicità, mostrando una complessità filosofica e morale.
- Seneca intreccia filosofia e potere, partecipando alla vita politica e riflettendo su benefici, clemenza e il ruolo del filosofo nello stato.
- Le tragedie di Seneca, ispirate alla mitologia greca, esplorano il tema del potere e dei conflitti morali, spesso in opposizione alla tirannia.
Il luogo d’origine della famiglia degli Annei era in Spagna. Appartenevano alla ricca aristocrazia, di rango equestre. Il giovane Lucio, nato forse nel 4ac, ebbe anche buona educazione retorica e filosofica in vista della carriera politica. Attorno al 2 si recò in Egitto, al seguito di uno zio prefetto. Tornato a Roma, iniziò la carriera di oratore e avvocato nel Foro. A questo periodo potrebbero appartenere alcune delle nove tragedie di argomento greco, tra cui la Medea. Accusato di coinvolgimento in uno scandalo di corte, nel 41 venne condannato alla relegazione dall’imperatore Claudio: destinazione scelta per l’esilio, la Corsica, che Seneca descrive un posto selvaggio e inospitale. In Corsica compone due Consolazioni, opere dove con varie argomentazioni si cercava di confortare una persona colpita da un dolore: Ad Helviam matrem, per consolarla del suo esilio, e Ad Polybium, indirizzata a un potente liberto di Claudio che aveva perduto un fratello.
Nel 49 viene richiamato a Roma, per intervento dell’imperatrice Agrippina, nel ruolo di educatore del figlio, Nerone. Dal 54 regge per alcuni anni la guida dello stato. Di questo periodo sono i tre libri del de clementia, una specie di guida per il regnante, indirizzata a Nerone. Quando Agrippina viene assassinata dal figlio, Seneca è già stato costretto a gravi compromessi, e gradualmente si ritira dalla scena, per dedicarsi agli studi. Risalgono a questi anni i lavori di maggior impegno: i sette libri del De beneficiis, dedicato al problema dei benefici, i sette libri delle Naturales quaestiones, i venti delle Epistulae morales ad Lucilium, il De otio e il De providentia. Controversa è la datazione di altri scritti filosofici di Seneca, tutti raccolti nei dodici libri dei Dialogi, titolo che non implica in realtà una vera forma dialogica, essendo i diversi trattati singole dissertazioni su specifici temi morali.
Seneca viene coinvolto nella repressione della “congiura di Pisone”, della quale forse era solo al corrente senza esserne partecipe: accusato da Nerone, è costretto al suicidio.
Dialogi
Le singole opere dei Dialogi costituiscono trattazioni autonome di aspetti o problemi particolari dell’epoca stoica.
• De ira sorta di fenomenologia delle passioni umane, ne analizzano i meccanismi di origine e i modi per inibirle e dominarle. L’opera è indirizzata al fratello.
• De vita beata affronta il problema della felicità e nel ruolo che nel perseguimento di essa possono svolgere le comodità e le ricchezze. In realtà dietro al problema generale, Seneca sembra volere fronteggiare le accuse di incoerenza fra i principi professati e la concreta condotta di vita che lo aveva portato ad accumulare un vasto patrimonio (anche mediante la pratica dell’usura). Posto che l’essenza della felicità è nella virtù , non nella ricchezza e nei piaceri, Seneca legittima tuttavia l’uso della ricchezza se questa si rivela funzionale alla ricerca della virtù.
• De constantia sapientis esalta l’imperturbabilità del saggio stoico, forte nella sua interiore fermezza, di fronte alle ingiurie e alle avversità.
• De tranquillitate animi affronta un problema fondamentale nella riflessione filosofica senecana, la partecipazione del saggio alla vita politica. Seneca cerca una mediazione fra i due estremi dell’otium contemplativo e dell’impegno proprio del civis romano, suggerendo un comportamento flessibile, rapportato alle condizioni politiche.
• De otio il saggio è impossibilitato a giovare agli altri, alternativa diversa del rifugio nella solitudine contemplativa, di cui si esaltano i pregi.
• De brevitate vitae tratta il problema del tempo, della sua fugacità e dell’apparente brevità di una vita che tale ci sembra perché non ne sappiamo afferrare l’essenza, disperdendola in tante occupazioni futili senza averne piena consapevolezza.
• De providentia apre la raccolta dei “dialoghi” e affronta il problema della contraddizione fra il progetto provvidenziale che secondo la dottrina stoica presiede alle vicende umane e la sconcertante constatazione di una sorte che sembra spesso premiare i malvagi e punire gli onesti. La risposta di Seneca è che le avversità che colpiscono chi non le merita non contraddicono tale disegno provvidenziale, ma attestano la volontà divina di mettere alla prova i buoni ed esercitarne la virtù.
• Consolationes repertorio di temi morali (la fugacità del tempo, la precarietà della vita, la morte come destino ineluttabile dell’uomo) attorno ai quali ruota gran parte della riflessione filosofica di Seneca.
Filosofia e potere
Seneca è uno dei pochi, nella storia della filosofia che realizza l’utopia platonica dei filosofi al potere. influente ministro di Nerone nei primi cinque anni, Seneca dedica gran parte della sua riflessione a temi pubblici: se il sapiente debba partecipare alla vita dello stato, quale sia il comportamento del buon principe, fino a che punto il possesso e la ricchezza sono conciliabili con l’ideale astinenza del filosofo. La filosofia stoica non vuole il sapiente lontano dagli affari dello stato, a condizione che la partecipazione non turbi la serenità interiore. Oil sapiente potrà lavorare per il benessere della sua comunità, almeno finché i contrasti non diventino troppo tumultuosi e rischino di provocare un turbamento.
• De beneficiis tratta degli atti di beneficenza e di filantropia, e del legame di riconoscenza che questi atti istituiscono tra benefattore e beneficato, dei doveri della gratitudine, delle conseguenze che colpiscono gli ingrati. I ricchi devono aiutare chi è di condizione più modesta (ma Seneca non parla delle plebi urbane, dei nostri “proletari”: il suo interesse si limita ai ceti relativamente benestanti, che invita a un mutuo soccorso in modo da creare uno scambio tra ricchissimi, i ricchi e la classe di mezzo, diffondendo ordine, controllo e stabilità sociale).
• De clementia rivolto a Nerone. Seneca on mette in discussione la legittimità costituzionale del principato, né le forme monarchiche che esso ha ormai assunto. Il problema è quello di avere un buon sovrano; e in un regime di potere assoluto, privo di forme di controllo esterno, l’unico freno sul sovrano sarà la sua stessa coscienza, che lo dovrà trattenere dal governare in modo tirannico. Con la clemenza egli potrà ottenere da loro consenso e dedizione da parte del popolo, che sono la più sicura garanzia della sicurezza di un sovrano e della stabilità di uno stato.
Il ritiro dalla vita pubblica è per Seneca l’occasione per studi approfonditi sulle scienze naturali:
• Naturales quaestiones dedicati a Lucilio. L’opera in cui sono trattai i fenomeni naturali e celesti, dai temporali ai terremoti alle comete, è il frutto di un vasto lavoro di compilazione, durato probabilmente parecchi anni, da svariate fonti, soprattutto stoiche (Posidonio).
Abbandonate le scienza naturali, le Epistulae ad Lucilium, ‘ultima opera, a noi giunta incompleta, saranno ormai totalmente dedicate alla coltivazione dell’Io, alla riflessione sull’interiorità.
Epistolae
Lucilio si occupò di filosofia e di poesia; ma la fama maggiore gli sarebbe venuta dall’essere messo a nudo nei suoi dubbi, nelle sue debolezze, nei suoi incerti progressi di filosofo, dalle Lettere che Seneca gli indirizzò. Lucilio, nelle Lettere, è lontano da Seneca, è in Sicilia, dove è stato mandato come funzionario imperiale. Però il posto vero che ha nelle Lettere è quello del giovane ancora incerto, dell’amico che vorrebbe imparare, ma ha spesso dubbi, e non sa come arrivare alla sapienza e alla perfetta tranquillità interiore. Seneca è un maestro che non si rappresenta perfetto, e si dice ancora pieno di colpe da sanare, ma è più avanti dell’amico sulla strada verso la saggezza. Le Lettere sono come il controllo che il maestro esercita sul proprio giovane discepolo; Lucilio comunica a Seneca le proprie difficoltà, e chiede consiglio su come comportarsi, ottenendo risposta ai suoi dubbi. La raccolta delle Epistulae riporta solo le lettere inviate da Seneca in risposta a Lucilio: quella epistolare è infatti soprattutto una finzione, un pretesto per rendere più gradevole la dottrina senecana. Ma Seneca riesce sempre a comunicare l’impressione di un dialogo vivace. Di rado le lettere assumono la forma di lunghi trattati.
Il modello di Seneca è Epicuro. Le lettere erano per Epicuro l’unico modo di continuare a seguire e consigliare amici e discepoli spesso lontani. Esistono dubbi sulla reale esistenza di un carteggio continuato e di tale estensione tra Seneca e Lucilio. Le Lettere sono totalmente depurate da ogni dettaglio accidentale, come saluti, consigli pratici, richieste; manca ogni segno della vera e propria corrispondenza epistolare. Questo non significa che singole lettere non possano anche essere state mostrate o inviate a Lucilio prima della pubblicazione: si suppone però che queste Lettere siano state scritte già in vista della loro raccolta in libro effettiva.
Compaiono invece una serie di “occasioni”, piccoli fatti scelti perché hanno suggerito a Seneca una qualche riflessione sulle cose, o sull’anima degli uomini. Così le Lettere raccontano spesso aneddoti, incontri, momenti di vita che il filosofo commenta per trarne un insegnamento, un incentivo a migliorarsi; quei fatti reali sono occasione di riflessioni che spaziano verso l’universale, le grandi questioni della vita e della morte. Ogni evento è buono perché Seneca vi scorga simboli di una condizione umana, e voglia comunicare la sua intuizione a Lucilio .
È così che le Lettere portano di nuovo la discussione su alcuni dei temi importanti di tutta l’opera senecana, il filosofo torna a considerare il problema della libertà, della natura di Dio, ella sua giustizia, del tempo. Seneca propone l’ideale di una vita indirizzata al raccoglimento e alla meditazione, al perfezionamento interiore mediante un’attenta riflessione sulle debolezze e i vizi propri e altrui.
Stile
Quintiliano si lamentava che l’ammirazione di tanti giovani per Seneca filosofo avesse provocato una degenerazione nella maniera di scrivere. Quintiliano si lamentava specialmente dello spezzettamento dei periodi in frasi brevi di gusto epigrammatico.
Seneca rifiuta la compatta struttura classica del periodo ciceroniano, che nella disposizione delle frasi voleva rendere chiara una gerarchia logica, e quasi rappresentare la verità dell’argomentazione (frasi “incastrate” una nell’altra). Lo stile di Cicerone era caratterizzato soprattutto da un periodare articolato e fluente, dove ogni pensiero doveva necessariamente ricondurre al successivo. Nelle pagine di Seneca domina invece la paratassi: le frasi non dipendono l’una dall’altra, i collegamenti sono nei concetti espressi dal discorso, che viene svolto per movimenti di antitesi e ripetizioni. Intento di Seneca è quello di riprodurre uno stile colloquiale, un parlato che imita la conversazione.
Se il discorso di Seneca procede per frasi brevi, nervose e staccate, spesso lapidarie, è anche perché esse vogliono essere memorizzate con facilità, e perché gli insegnamenti che esprimono rimangono fissati nella memoria di chi legge.
Tragedie
Un posto importante nella produzione letteraria di Seneca è occupato dalle tragedie. Sono nove quelle ritenute autentiche, tutte di soggetto mitologico greco (“coturnate”). Non abbiamo nessuna informazione circa una loro eventuale rappresentazione e molti indizi ci inducono a pensare che le tragedie fossero scritte per la declamazione e la lettura pubblica.
• Hercules furens tema della follia di Ercole, provocata da Giunone, induce l’eroe a uccidere moglie e figli: una volta rinsavito, e determinato a suicidarsi, egli si lascia distogliere dal suo proposito e si reca infine ad Atene a purificarsi.
• Troades rappresentano la sorte delle donne troiane prigioniere e impotenti di fronte al sacrificio di Polissena, figlia di Priamo.
• Phoenissae unica tragedia incompleta, ruota attorno al tragico destino di Edipo e all’odio che divide i suoi figli.
• Medea rappresenta la cupa vicenda della principessa della Colchide abbandonata da Giasone e perciò assassina, per vendetta dei figli avuti da lui.
• Phaedra tratta dell’incestuoso amore di Fedra per il figliastro Ippolito e del drammatico destino del giovane, restio alle seduzioni della matrigna, la quale si vendica denunciandolo al marito Teseo, padre di Ippolito, e provocandone la morte.
• Oedipus narra il mito di Edipo, inconsapevole uccisore del padre e sposo della madre: alla scoperta della tremenda verità, egli reagisce accecandosi.
• Agamemnon rappresenta l’assassinio del re, al ritorno da Troia, per mano della moglie Clitemnestra e dell’amante di lei Egisto.
• Thyestes rappresenta invece il cupo mito dei Pelopidi: animato da odio mortale per il fratello Tieste, che gli ha sedotto la sposa, Atreo si vendica con un finto banchetto in cui imbandisce al fratello ignaro le carni dei figli.
• Hercules Oetaeus è trattato il mito della gelosia di Deianira, che per riconquistare l’amore di Ercole gli invia una tunica intrisa del sangue del centauro Nesso, creduto un filtro d’amore e in realtà dotato di potere mortale: fra atroci dolori Ercole si fa innalzare un rogo e vi si getta per darsi la morte, cui farà seguito la sua assunzione fra gli dei.
I modelli di Seneca sono le tragedie greche del periodo classico, per lo più Sofocle e Euripide. La tecnica dell’azione scenica è assai lontana dalle convenzioni del teatro classico greco, e fa pensare piuttosto alle regole del dramma ellenistico.
Lo stile delle tragedie di Seneca risente fortemente di influssi che provengono dai modelli latini ormai consacrati, come Virgilio, Orazio e Ovidio. Seneca mutua anche le raffinate forme metriche, come è il caso dei metri dei cori, imitati da Orazio. Le tracce della tragedia latina arcaica si avvertono soprattutto nel gusto del pathos esasperato, nella tendenza al cumulo espressivo e alla frase sentenziosa, isolata e in netto rilievo.
Quelle di Seneca sono le sole tragedie latine a noi pervenute in forma non frammentaria, la tragedia appare ora la forma letteraria più idonea per esprimere l’opposizione al regime, giacché le trame mitologiche contengono quasi sempre il tema dell’esecrazione della tirannide. Il tema del potere e del tiranno sembra occupare un posto centrale anche nelle tragedie di Seneca. Le varie vicende si configurano come conflitti di forze contrastanti, come opposizione tra ragione e passione. Nell’universo tragico il logos si rivela incapace di frenare le passioni e di arginare il diffondersi del male.
• Octavia sorte di Ottavia, prima moglie di Nerone, da lui ripudiata, una volta innamorato di Poppea, e fatta uccidere. Si tratta di una tragedia di argomento romano.
Un’opera davvero singolare è il Ludus de morte Claudii, o Divi Claudii apotheosis per saturam. Il titolo con cui l’opera è più comunemente conosciuta è Apokolokyntosis, cioè “inzuccamento”, “trasformazione in zucca” del Divo Claudio. L’operetta contiene infatti la parodia della divinizzazione di Claudio, decretata subito dopo la morte. Dopo morto, Claudio pretenderebbe di essere assunto in cielo e si presenta al’Olimpo, davanti al concilio degli dei. Ma questi, dopo un lungo dibattito, lo condannarono a discendere agli inferi, dove Claudio finisce schiavo del nipote Caligola e del proprio liberto Menandro, che lo impiega a lanciare i dadi da un barattolo sfondato. L’ Apokolokyntosis rientra nel genere della satira menippea, e alterna perciò prosa e versi di vario tipo, in un singolare impasto linguistico che accosta i toni piani delle parti prosastiche a quelli spesso parodicamente solenni delle parti metriche, con sapide coloriture colloquiali.
Domande da interrogazione
- Qual è l'origine della famiglia di Seneca e quale fu la sua educazione iniziale?
- Quali furono le conseguenze dell'accusa di coinvolgimento in uno scandalo di corte per Seneca?
- Quali sono i temi principali trattati nei Dialogi di Seneca?
- Come si caratterizza lo stile di scrittura di Seneca rispetto a quello di Cicerone?
- Qual è il significato dell'opera "Apokolokyntosis" di Seneca?
La famiglia degli Annei, a cui apparteneva Seneca, era originaria della Spagna e faceva parte della ricca aristocrazia di rango equestre. Seneca ricevette una buona educazione retorica e filosofica in preparazione alla carriera politica.
Seneca fu condannato all'esilio in Corsica dall'imperatore Claudio nel 41, dove descrisse il luogo come selvaggio e inospitale. Durante l'esilio, scrisse due Consolazioni per confortare persone colpite da dolore.
I Dialogi di Seneca trattano vari aspetti della filosofia stoica, come la gestione delle passioni umane, la felicità, l'imperturbabilità del saggio, la partecipazione alla vita politica, la fugacità del tempo e la provvidenza.
Seneca adotta uno stile paratattico, con frasi brevi e staccate, in contrasto con la struttura articolata e fluente di Cicerone. Questo stile mira a essere memorizzato facilmente e a imitare la conversazione colloquiale.
"Apokolokyntosis" è una satira menippea che parodizza la divinizzazione di Claudio, rappresentando la sua trasformazione in zucca. L'opera alterna prosa e versi, mescolando toni colloquiali e solenni.

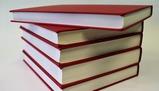





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo