Concetti Chiave
- Virgilio visse durante il regime augusteo, recuperando le terre della sua famiglia grazie alla vicinanza con Ottaviano e divenne parte del circolo di Mecenate, dedicandosi a opere che celebravano la politica culturale di Augusto.
- Le Bucoliche sono poesie pastorali ispirate a Teocrito, caratterizzate da un paesaggio idealizzato e da una struttura simmetrica, con elementi meta-poetici e riferimenti a personaggi fittizi con eccezioni come Cornelio Gallo.
- Le Georgiche, un poema didascalico sull'agricoltura, riflettono la scelta politica di Virgilio di sostenere i valori antichi di Ottaviano e combinano lo stile lucreziano con quello alessandrino.
- L'Eneide, iniziando in medias res, narra il viaggio di Enea, ostacolato dalla dea Giunone, e culmina nella legittimazione del potere di Ottaviano Augusto, con un forte elemento di celebrazione del regime augusteo.
- Virgilio adotta uno stile epico influenzato da Omero e la tragedia greca, ponendo attenzione al tema amoroso e alla pietas di Enea, usando simbolismo e anticipazioni nella narrazione.
Publio Virgilio Marone
Publio Virgilio Marone nasce a Mantova negli ultimi anni del dominio Giulio Cesare, vivendo poi sotto il regime augusteo. Egli apparteneva ad una famiglia di proprietari terrieri; la proprietà era stata danneggiata dalle elargizioni di terreno agricolo (con conseguente espropriazione) che lo Stato romano concedeva ai veterani e i reduci delle guerre. Virgilio recuperò queste terre grazie alla vicinanza di Ottaviano, a cui era perciò legato da un vincolo di riconoscenza, ed entrò nel gruppo di Mecenate. Negli anni successivi, Virgilio si dedica alla redazione delle Georgiche che, parlando apparentemente di terre e agricoltura, tessono in realtà le lodi della politica culturale di Augusto, che sosteneva la necessità di un ritorno ai valori antichi (tra i quali, il possesso della terra come forma di potere). Ottaviano rimane colpito da quest’opera, portando Virgilio, negli anni venti, alla redazione dell’Eneide che, parlando della guerra di Troia, celebra la nascita di Roma e lo stesso Augusto; l’opera rimarrà incompleta (contando 50 versi tibicines, provvisori), ma Augusto, contravvenendo alle intenzioni dell’autore (che voleva una pubblicazione perfetta), ne impedì la distruzione, visto il contenuto celebrativo dell’opera. Virgilio muore nel 19 a.c.
Le Bucoliche
Il termine bucoliche trae origine da “Boukolos”, ovvero pastore. L’opera contiene poesie con alcuni pastori come protagonisti, trattandosi dunque di poesia pastorale. I singoli componimenti delle bucoliche possono essere chiamati “Egloghe” ossia “poesie selezionate”.L’autore si ispira ad un autore del III secolo a.C., Teocrito (iniziatore della poesia pastorale), che aveva pubblicato una raccolta di poesie, che contenevano un elemento di novità: i protagonisti erano i pastori che raccontavano la loro vita in campagna, fornendo descrizioni ambientali del paesaggio agricolo. Teocrito si era trasferito nella fiorente Alessandria dalla sua terra natia, Siracusa, trasmettendo dunque nelle sue opere un senso di nostalgia per l’agreste terra natale. Altri modelli, di origine latina, si possono identificare in Catullo (per il tema amoroso) e Lucrezio.
Le Bucoliche presentano spesso tratti “meta-poetici”, ossia la poesia che fa riferimenti a se stessa. Un’altra caratteristica delle Bucoliche consiste nella struttura e contenuto: si distinguono quelle narrative (pari) e drammatiche-dialogiche (dispari).
I nomi dei personaggi (inventati) hanno etimologia greca, al fine di non identificarli in reali personaggi storici; fa eccezione il “caso” di Cornelio Gallo, rappresentato nell’ultima ecloga come errante e triste per amore (elemento meta-poetico => Gallo era infatti un poeta elegiaco, e con questa rappresentazione Virgilio vuole affermare la sua supremazia sul genere di poesia di Gallo)
Il paesaggio rappresentato è idealizzato, non reale ed identificabile ma stilizzato ed ideale (Teocrito, invece, era più realista) => locus amoenus (luogo bello) => richiamo all’Arcadia (regione della Grecia montuosa ed aspra ma rappresentata idealmente)
Le 10 Bucoliche sono strutturate in modo simmetrico, ovvero creando delle corrispondenze:
- I confische
- II lamento amoroso
- III tenzone poetica
- IV paulo maiora…
- V per la morte di Dafni
- VI Sileno e Gallo
- VII tenzone poetica
- VIII lamento amoroso
- IX confische
- X Gallo
Nella IV ecloga, introdotta da paulo maiora canamus…myricae (parliamo di cose più importanti, non a tutti piacciono le tamerici), egli predice la nascita di un puer che porterà la pace nel mondo, portando i pensatori cristiani medievali (primo tra tutti, Dante) a credere che Virgilio avesse predetto la nascita di Cristo, mentre questi si riferiva in realtà al figlio di Marco Antonio e di Ottavia, sorella di Ottaviano, la cui nascita avrebbe potuto porre fine alle guerre civili a Roma, o alla nascita del figlio del console Pollione, grande amico di Virgilio.
Lo stile delle Ecloghe, a differenza di quello di Sallustio (che andava di pari passo con il contenuto), è vicino al Neoterismo ed è caratterizzato da armonia ed eleganze.
Le Georgiche
Il nome dell’opera deriva da “Georgos”, contadino. Virgilio inizia a lavorare all’opera dopo aver ultimato le Bucoliche, continuando per tutti gli anni ‘30.Si tratta un poema didascalico (che ha funzioni didattiche) sull’agricoltura: è chiaro tuttavia che un contadino non ha possibilità di apprendere leggendo; in realtà, il vero contenuto è quello contenuto nel prologo e nelle digressioni dei vari libri. L’opera esprime la scelta politica di Virgilio, legato al circolo augusteo e al sistema, caro ad Ottaviano, di valori antichi, tra cui il valore della terra.
In quest’opera, Virgilio concilia, nell’ambito del poema didascalico, lo stile lucreziano (a vantaggio del contenuto) e alessandrino (a vantaggio della forma dolce)
I libri sono ordinati secondo la difficoltà del lavoro indicato nel titolo.
- I: il lavoro dei campi (Prologo = il lavoro è necessario/Digressione: prodigi infausti)
- II: la vite (Prologo = Laudes Italiae/Digressione: la vita in campagna)
- III: il bestiame (Prologo = l’amore/Digressione: la peste del Norico)
- IV: le api (Prologo = il vecchio di Corico/Digressione: Aristeo e Orfeo)
Virgilio rimarca l’importanza di interpretare i segni divini e del lavoro della terra, capace di nobilitare l’uomo (come nell’episodio del vecchio di Corico che, acquistando un terreno in Puglia, diviene ricco)
I destinatari fittizi sono gli agricoltori (agricola italicus), mentre il destinatario reale è il pubblico urbano (per motivazioni propagandistiche). I dedicatari dell’opera sono Ottaviano e Mecenate
Secondo lo studioso Servio, il finale inizialmente era dedicato a Cornelio Gallo, poi rimosso per aver preso le distanze dalla politica augustea e sostituito con Orfeo ed Euridice, anche se è più probabile che ci dovesse essere solo un piccolo riferimento a Gallo.
L’Eneide
L’Eneide (poema di Enea) comincia in medias res, nel mezzo della fuga del troiano Enea, uno sconfitto, che, secondo il mito, prova a tornare (con il padre e il figlio) nella terra dei suoi avi, l’Italia, in cui i Dardanidi, antenati dei troiani, avevano avuto origine (l’opera assume allora un aspetto, celebrativo del regime augusteo). Il viaggio di Enea è ostacolato dalla dea Giunone, che odia l’eroe per tre ragioni: l’essere troiano (come Paride, giudice della gara di bellezza, che aveva escluso Giunone), l’essere figlio di Venere (che aveva battuto Giunone nella stessa gara di bellezza), l’essere il prossimo fondatore di Roma che, in futuro, avrebbe distrutto Cartagine (città protetta da Giunone). Una tempesta provocata dalla dea fa dunque naufragare Enea in Nordafrica, dove egli incontra un popolo locale, retto dalla regina Didone (anche lei profuga, originaria della Fenicia che, dopo la morte del marito Sicheo per mano del fratello Pigmalione, fugge dalla terra natale). Giunone propone dunque a Venere un accordo per far innamorare Didone ed Enea, al fine di lasciare quest’ultimo lontano dal suo destino nella fondazione di Roma. Le dee si accordano, (IV libro) facendo innamorare Didone ed Enea (dandosi la mano destra, che, per Didone, è quasi come un matrimonio). Zeus, che aveva comandato ad Enea di recarsi in Italia, incarica Mercurio, titubante, di ordinare ad Enea di ripartire, lasciando Didone, che aveva persino rifiutato altre proposte di matrimonio, disperata fino al punto di uccidersi trafiggendosi.Enea arriva prima in Sicilia (V libro) dove celebra i giochi funebri in onore del padre, morto nel viaggio, e successivamente in Campania, dove scende nell’Oltretomba, incontrando una serie di anime defunte (tra cui Didone). Enea incontra poi il padre Anchise nei Campi Elisi (equivalente del paradiso), che lo conduce su una collina dove si svolge una processione di anime, mitologiche ma anche realmente esistite (e che un giorno sarebbero nate e avrebbero reso grande Roma). La processione si concludeva con Ottaviano Augusto (legittimando il potere dell’imperatore, tra l’altro appartenente alla stessa stirpe di Enea). L’episodio della processione prende il nome di “Heroscopia”, che significa “Visione degli eroi”. Nel settimo libro inizia la parte militare, narrando di un accordo con alcuni popoli locali sabotato dagli dèi avversi a Enea (come Giunone), provocando una lunga guerra, al termine della quale Enea sconfisse uno dei più grandi eroi avversari, Turno, conquistando successivamente il Lazio.
Lo stile
Chiaramente, dovendo scrivere un’opera epica, Virgilio deve rifarsi, anche esplicitamente, al modello di Omero, caposaldo del genere (scegliendo, per esempio, di dividere l’opera in 12 libri, sottomultiplo di 24, numero dei libri di Iliade e Odissea, rendendola a sua volta più breve in linea con la cultura alessandrina), chiaramente tramite un processo di rielaborazione.Un elemento di novità è la centralità del tema amoroso, lontano dalla poetica romana.
I primi sei libri si collegano all’Odissea (tema del viaggio), mentre i successivi all’Iliade (tema della guerra). Si verificano i fenomeni di continuazione (mito di Enea continuazione della guerra di Troia), ripetizione (si combatte nuovamente una guerra) e superamento (la guerra stavolta è vinta).
Nelle opere omeriche, Achille viene rappresentato come sanguinoso combattente attaccato all’onore, mentre Enea è l’eroe della pietas (rispetto per gli dèi).
Un altro modello ispiratore per Virgilio è quello della tragedia greca, specialmente quella di Euripide; questo genere induce a porsi degli interrogativi, ad analizzare le sfumature dei personaggi e delle situazioni (come parlando della guerra e della regina Didone), degli sconfitti che, però, non hanno sempre torto.
Virgilio adotta uno stile soggettivo, nella scrittura, e simbolista: a volte, anticipa ciò che avverrà nel testo tramite simboli e aggettivi (la freccia dell’amore di Didone per Enea è freccia mortale, perché successivamente la condurrà alla morte).
Virgilio si rifà allo Stoicismo: mentre gli epicurei sostenevano l’assenza di ordine dato da un’entità superiore, gli Stoici riconoscono l’autorità degi d+i e sostengono la necessità, da parte degli uomini, di rispettare il volere divino (come fa Enea nell’opera).
Dal punto di vista contenutistico, si rifà uso dell’espressionismo (descrizione dettagliata ed emozionante di ambienti ed eventi), portando ad una narrazione drammatica (costruita quasi come una scena teatrale).
Dal punto di vista più strettamente stilistico, rileviamo un livello sintattico elevato, che farà quasi da modello per i poemi epici del futuro, e l’utilizzo della formularità (ripetizioni continue di singoli aggettivi riferiti agli eroi o di interi versi per richiamare l’attenzione). Il tipo di verso utilizzato, l’esametro (già adottato da Ennio, Lucrezio e Catullo), assume qui una forma più raffinata e musicale che in precedenza.
I personaggi
Didone, al contrario di Enea, eroe difficile e determinato a seguire la volontà degli dèi, si abbandona in pieno e drammaticamente alle sue emozioni. Lo stesso Virgilio simpatizza con la regina, e in generale con chi è ingiustamente privato delle proprie origini e del proprio amato.Turno, il re dei Rutuli (popolazione italica), era destinato a sposare Lavinia, la figlia del re dei latini, è definito un “vinto con onore”, perché non ha causato lui la guerra in cui viene coinvolto da Enea.
Domande da interrogazione
- Chi era Publio Virgilio Marone e quale fu il suo legame con Ottaviano?
- Qual è il tema principale delle Bucoliche e quale autore ha ispirato Virgilio?
- Qual è il significato nascosto delle Georgiche e a chi sono dedicate?
- Come viene rappresentato Enea nell'Eneide e quale ruolo ha Giunone nella sua storia?
- Quali sono le caratteristiche stilistiche dell'Eneide e quali modelli ispirano Virgilio?
Publio Virgilio Marone era un poeta romano nato a Mantova, noto per le sue opere come le Bucoliche, le Georgiche e l'Eneide. Era legato a Ottaviano grazie al recupero delle sue terre espropriate, entrando nel circolo di Mecenate e celebrando la politica augustea nelle sue opere.
Le Bucoliche sono un'opera di poesia pastorale che si ispira a Teocrito, un autore del III secolo a.C. Virgilio utilizza pastori come protagonisti per raccontare la vita in campagna, con un paesaggio idealizzato e temi meta-poetici.
Le Georgiche, pur essendo un poema didascalico sull'agricoltura, esprimono la scelta politica di Virgilio a favore dei valori antichi sostenuti da Ottaviano. L'opera è dedicata a Ottaviano e Mecenate, con destinatari reali che sono il pubblico urbano.
Enea è rappresentato come un eroe della pietas, rispettoso degli dèi, il cui viaggio è ostacolato da Giunone per motivi personali e mitologici. Giunone provoca una tempesta che lo fa naufragare in Nordafrica, dove incontra Didone.
L'Eneide si ispira a Omero e alla tragedia greca, con uno stile soggettivo e simbolista. Virgilio utilizza l'esametro in modo raffinato e musicale, adottando elementi dello Stoicismo e dell'espressionismo per una narrazione drammatica e dettagliata.

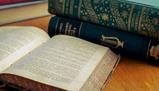





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo