In questo appunto di letteratura greca viene descritta la tragedia del V secolo, con particolare attenzione alla figura del tragediografo greco Euripide, la sua vita e le sue opere letterarie, alcuni suoi drammi, la sua drammaturgia, il suo stile, il suo mondo concettuale.

Indice
La tragedia del V secolo: Euripide
Euripide è l'unico degli altri tragediografi del periodo (Eschilo e Sofocle) a rendersi conto di dover adattare la sua tragedia alla crisi della cultura di quel periodo. Ma il suo tentativo di evolvere la tragedia è mal inteso: molti infatti sono coloro che pensano che egli sia un eversore della tragedia. Questa nuova situazione problematica, comunque, non dà più spazio all'indagine sulla razionalità umana, ma è ora il momento di affrontare problematiche quali la condizione della donna, dello straniero, la parola come strumento di potere... Quindi elemento principale delle tragedie di Euripide saranno i drammi quotidiani e i rapporti tra gli uomini, e la problematica maggiore sarà non più il confronto con il volere della divinità, ma con le scelte degli altri uomini. La figura degli dei non viene eliminata, ma diviene metafora delle istituzioni e delle convenzioni sociali.Euripide elabora numerose innovazioni: introduzione di lunghi prologhi che anticipano la conclusione, ampio spazio ai discorsi, il frequente tema del riconoscimento tra persone che ignoravano la loro identità, che esprime la fiducia nella possibilità di scoprire la realtà dei rapporti umani.
La tragedia di Euripide oppone dunque da un lato la considerazione depressa della miseria dell'uomo e dall'altro la convinzione ottimistica che valga la pena lottare per annientare tutti i pregiudizi.
La vita e le opere
Euripide nasce intorno al 485 a.C. Fu sempre preso di mira dai commediografi, che trasformavano suo padre (proprietario terriero) in un bottegaio e sua madre (nobile) in erbivendola, e parlavano delle sue disavventure coniugali.La sua famiglia era molto ricca e per questo Euripide fu educato dai migliori maestri. Non fu mai molto amato dai suoi concittadini che lo fecero attendere molto prima di concedergli i dovuti onori, forse perché senza tanti giri di parole Euripide criticava i comportamenti di molti di loro. Comunque in vita Euripide non fu una persona socievole: è ricordato come un intellettuale solitario che componeva in una grotta in riva al mare, non prendeva parte alla vita pubblica.
Morì presso la reggia di Archelao (a cui dedicò una tragedia), re di Macedonia. Su di lui erano narrate leggende sulla sua misoginia (avversione pregiudiziale per le donne) e sul suo ateismo (si diceva infatti che il suo cenotafio era stato distrutto da un fulmine).
Fu tanto poco amato nella vita quanto fu onorato dopo la morte, tramite la rilettura delle opere che soppiantarono la fama di altri tragici. Di lui ci restano 10 drammi e 10 tragedie (in tutto 19 perché Ecuba compare due volte).
Alcuni drammi di Euripide
Ecco i principali drammi di Euripide:- Alcesti: Admeto può sfuggire alla morte, grazie ad una concessione di Apollo, solo se qualcuno accetterà di morire al suo posto: questo qualcuno è sua moglie Alcesti. Dopo una tragica scena di addio, arrivano Eracle e poi il padre di Admeto, che questi attacca per non aver voluto morire al suo posto. Eracle, che se ne era andato, torna del tutto ubriaco e scopre che Alcesti è morta. Riesce a rapirla dall'aldilà e a riportarla a Admeto.
- Medea: Medea ha seguito io marito Giasone a Corinto con i figli, e qui viene a sapere che Giasone vuole cacciare lei stessa dalla città e sposare la figlia del re Creonte. Si vuole vendicare: ottiene che la sua partenza sia rimandata di un giorno e di essere ospitata in Atene dal re Egeo. A questo punto finge di riconciliarsi con Giasone e manda alla sposa dei regali portati dai figli: dei vestiti bellissimi, imbevuti di veleno. Dopo la morte di re Creonte e di sua figlia, Medea uccide i suoi stessi figli e fugge.
- Baccanti: a Tebe è giunto Dioniso con le sue seguaci, le Baccanti, che formano il coro. Le donne della famiglia reale e soprattutto la regina Agave dubitano della sua divinità. Il re Penteo vuole impedire la diffusione del suo culto, nonostante gli avvertimenti del nonno Cadmo e dell'indovino Tiresia. Dioniso, sotto aspetto umano, si lascia catturare e portare davanti al re, dove viene sottoposto ad un interrogatorio durante il quale si libera agilmente dalle catene con gioia delle sue devote. Intanto un messaggero racconta al re le gesta straordinarie delle Baccanti sul monte di Tebe. Viene convinto da Dioniso a spiarle travestito da menade. Ma Penteo è scoperto dalle Baccanti, scambiato per un leone e fatto a pezzi: fra di esse sono anche la madre e la zia di Penteo. Agave porta, credendolo un trofeo di caccia, la testa del figlio fra le mani, ma quando si accorge della triste realtà si dispera. A questo punto Dioniso caccia Agave e le sorelle per aver dubitato della sua divinità e conforta Cadmo che sarà accolto nel paese dei beati con la moglie.
La drammaturgia di Euripide
La prima fase della sua carriera è caratterizzata dai drammi ad azione unica, svolta attraverso un'evoluzione del comportamento dei personaggi e delle situazioni. Quindi è la volta dei drammi a doppia azione, consistente da scene concluse in se stesse riunite tramite il protagonista attorno ad un unico nucleo tematico, e poi dell'intreccio vero e proprio.Questi diversi modi di presentare la tragedia mostrano una forte tendenza alla sperimentazione, sia per l'irrequietezza spirituale del poeta, sia per il cambiamento dei tempi (riguardo a quest'ultimo punto si è già parlato: Euripide tenta non di dissolvere la tragedia, ma di salvarla).
Per quanto riguarda la struttura interna del dramma, questa non si regge più sulla figura dell'eroe, ma sul rispondersi delle azioni degli uomini. Il dialogo è l'espressione dominante, per cui il ruolo del coro è messo in secondo piano. Le trame di Euripide derivano esclusivamente dalla sua fantasia, e ciò grazie all'interesse per gli aspetti spettacolari del dramma e per l'accentuazione degli aspetti umani. Per questo Euripide non usa il patrimonio mitico, per la prevedibilità delle conclusioni e per l'irrealtà delle situazioni. Il mito è usato solo come spunto tematico.
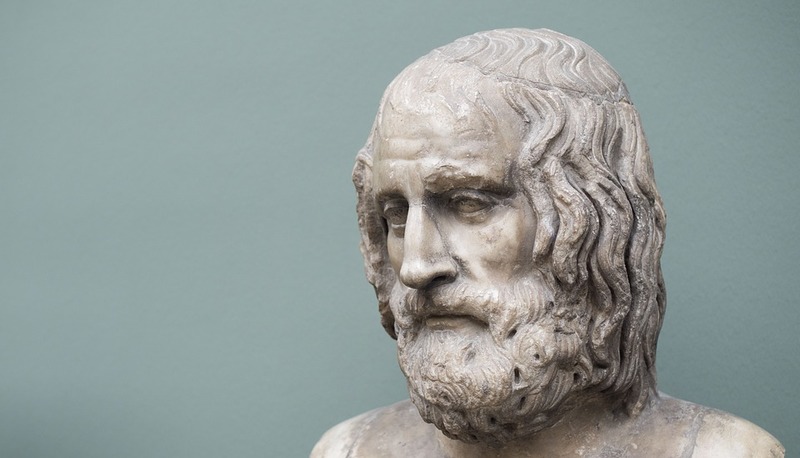
Lo stile di Euripide
Il linguaggio di Euripide è ispirato al quotidiano, chiaro e concreto, secondo lo schema geometrico della linea retta. Il frutto della riflessione del personaggio è riassunto in sentenze definitive, le gnomai, di cui si sono fatte varie raccolte autonome. Anche se la funzione del coro è molto meno essenziale rispetto agli altri tragici, il coro di Euripide è ben curato e diviene un momento di evasione malinconica (tema ricorrente è il volare lontano).
Il mondo concettuale di Euripide
Il pensiero di Euripide non può essere circoscritto né alla sola corrente illuministica (mette in dubbio la presenza degli dei), né alla corrente irrazionale (esistenza di forze mistiche). Il segno del suo pensiero è il dubbio, in un oscillare tra posizioni diverse e contrastanti, di fraintendimenti. Per questo, accade che proprio lui che conosce profondamente la psicologia femminile e inquadra le donne come le vittime di una società profondamente maschilista, è accusato di misoginia; lui che era capace di addentrarsi nelle più remote profondità del sentimento umano fosse accusato di essere un gelido retore.Euripide è soprattutto uno scrittore di teatro, sede della sua sperimentazione e della ricerca del vero, in cui i personaggi sono metafora dello scontro di due pensieri. È un disperato ottimista: crede che all'individuo debba essere concesso di scoprire la propria dignità nella realizzazione del proprio destino; ma contemporaneamente conosce la debolezza e precarietà dell'uomo: per questo i suoi drammi sono impregnati da un'infinita compassione e partecipazione al dolore di vivere.







 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo