Callimaco (310 – 240 a.C.) rappresenta la svolta epocale impressa alla civiltà greca dalla conquista di Alessandria. Infatti la sua poetica è una sostanziale rottura nei confronti della tradizione precedente: vengono messi in discussione i canoni dei generi letterari codificati nella poetica di Aristotele per far posto ad un sistema aperto e flessibile. Comunque c'è da dire che la posizione di Callimaco non è una polemica contro l'epos antico ma sottolinea semplicemente la sua inattualità. Così Callimaco per essere in armonia con l'Ellenismo propone piccole e raffinate composizioni che riprendono le saghe eroiche e che prendono il nome di epilli (piccoli Epi).
Gli Aitia (Origini)
Costituiti da 4 libri, composti in metro elegiaco spiegano attraverso la rievocazione di un mito le origini di un'usanza o di una cerimonia (anche nomi e cavoli vari). In questo modo Callimaco congiunge i suoi interessi storici antiquari con quelli poetici.
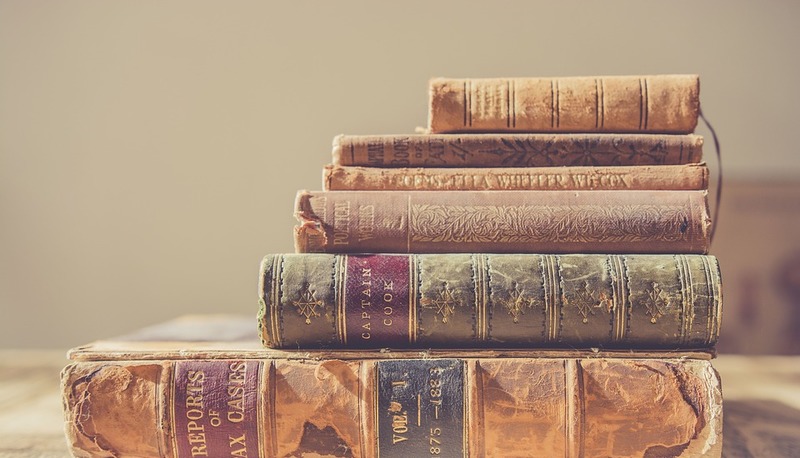
Comunque questo connubio fra erudizione e poesia non è frutto di una creazione ex novo, ma di fatti non canta nulla che non sia attestato.
I Giambi
Costituiti da 13 componimenti in metro giambico, trattano una grande varietà di temi. Infatti con questa opera, Callimaco risponde all'accusa di oligostikìa (per gli amici "troppi pochi versi") con l'applicazione provocatoria della polyèideia (ovvero la varietà di temi). Questo aspetto viene ancora rafforzato dal fatto che il poeta rimarca il suo distacco dalla tradizione adoperando la forma giambica per rivestirne tematiche che ad essa erano tradizionalmente estranee.
I carmi melici e l'Ecàle
Dei carmi melici non si sa bene se facessero parte dei giambi o no, comunque sono 4 opere che trattano argomenti vari. L'Ecàle è invece un epillio che spiega l'origine del toponimo Ecàle che indica il demo attico. La relativa brevità, la raffinatezza dello stile, l'erudizione antiquaria che caratterizzano l'opera la rendono un modello per scrittori successivi.
Gli Inni
Gli inni sono 6 componimenti dedicati ad altrettante divinità. Sono un'opera interessante per il fatto che all'interno di essa si ha un oscillare fra l'accettazione della tradizione omerica e l'intenzione di violarla: infatti agli stilemi formulari del genere innografico si oppongono continue innovazioni e reinterpretazioni, cosa che crea nei lettori certe aspettative che poi vengono puntualmente disattese.
Gli dei celebrati negli inni hanno tratti altrettanto umanizzati quanto quelli cantati dagli antichi aedi. Comunque i referenti terreni degli dèi non sono più dei guerrieri "pastori di popoli" ma potenti sovrani ellenistici.
Gli Epigrammi (da epigrafein, "scrivere sopra")
I temi trattati e la lunghezza di questi componimenti sono i più svariati. Inoltre è molto problematico tracciare una cronologia all'interno di essi. Inoltre sono caratterizzati da un uso di metri lirici e di formi dialettali doriche che rimarcano la varietà.
Poetica di Callimaco
L'affermazione mega bibliòn mega kakòn non è soltanto una polemica ai caratteri quantitativi della tradizione ma fa intravedere anche una presa di posizione anti – aristotelica. Come avevamo già detto all'inizio il rifiuto dell'imitazione non implica la necessità della pura invenzione: infatti Callimaco si richiama di continuo al dato erudito che costituisce un grande supporto alla sua poetica. Quindi si può dire che, in senso generale, Callimaco si pone come oggetto la verità. Inoltre come gia detto all'inizio il poeta decide di tagliare le connessioni con l'epica tradizionale per non dover rielaborare materiali già consunti da una tradizione plurisecolare.
Contro i Telchini (prologo dell'Aìtia)
Questa parte contiene per la prima volta nella storia letteraria un'enunciazione di poetica, nella quale Callimaco rappresenta i suoi avversari come Telchini (mitici demoni esperti di magie e capaci di gettare il malocchio sui loro avversari). La principale accusa contro il poeta era quella di oligostikos, cioè i troppi pochi versi per la difficoltà personale del poeta di impegnarsi a lungo nel compiere un opera. Si difende da questa accusa innalzando la leptotes, ovvero la leggerezza della sua breve poesia: per fare questo il poeta ricorre ad una serie di immagini che contrappongono il suo modo di far poesia a quello dei tradizionalisti (melodioso usignolo/cicala canora ecc.).
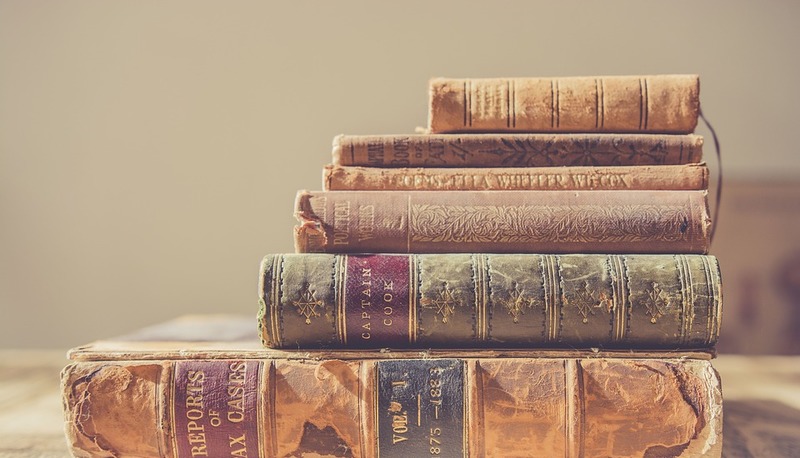 Comunque questo connubio fra erudizione e poesia non è frutto di una creazione ex novo, ma di fatti non canta nulla che non sia attestato.
Comunque questo connubio fra erudizione e poesia non è frutto di una creazione ex novo, ma di fatti non canta nulla che non sia attestato. 






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo