Concetti Chiave
- Nietzsche, nato nel 1844, è noto come critico della società moderna e "filosofo del sospetto", mettendo in dubbio le certezze condivise e affrontando la crisi del positivismo.
- La sua opera "La nascita della tragedia" esplora lo Spirito Apollineo (ordine e razionalità) e lo Spirito Dionisiaco (irrazionalità e vitalità) della cultura greca, criticando la negazione dello Spirito Dionisiaco nel pensiero occidentale.
- Nietzsche critica la morale occidentale e religiosa, considerandola una maschera per i pregiudizi morali, e propone la figura del superuomo come simbolo di un nuovo inizio e di fedeltà alla terra.
- Il concetto di "eterno ritorno" suggerisce una visione ciclica del tempo, abbandonando la linearità e trovando significato nel presente, mentre l'opera "La volontà di potenza" esplora il desiderio innato di crescita e creatività.
- Sebbene alcuni abbiano associato Nietzsche al nazionalsocialismo, il filosofo non ha legami con l'ideologia razzista, e si distacca sia dal positivismo che dal marxismo per la sua critica alla società di massa.
È nato nel 1844, ha vissuto per soli 56 anni e nel pieno della sua maturità vive il primo boom della seconda rivoluzione industriale, l’inizio dell’affermarsi del marxismo e comincia ad intravedere la crisi della filosofia positivista. È presentato come il critico della società moderna, è anche detto “filosofo del sospetto” intento ad insinuare il dubbio sulle certezze condivise dalla maggior parte delle persone, anche se inizialmente è un professore di filologia classica (scienza che studia le ricostruzioni dei testi antichi) in un’università svizzera.
Indice
- La nascita della tragedia e la cultura greca
- Spirito Apollineo e Dionisiaco
- Influenze di Schopenhauer e Wagner
- Critica alla morale occidentale
- La morte di Dio e l'oltreuomo
- Zaratustra e l'eterno ritorno
- La volontà di potenza e l'arte
- Nietzsche e il nazionalsocialismo
- Distacco da positivismo e marxismo
La nascita della tragedia e la cultura greca
Nel 1872 pubblica un’opera intitolata “La nascita della tragedia dallo spirito della musica”. La Grecia, dove nasce la tragedia, è l’inizio del pensiero occidentale ed era descritta in modo solenne dai Tedeschi, ma Nietzsche pensa che in questa cultura c’è si una forte armonia tra uomo e natura ma la visione che veniva propagandata era sbagliata.
La tragedia classica indica una rappresentazione letteraria in cui l’eroe deve fronteggiare una situazione che gli pone due alternative ma in ogni caso sarà colpevole e destinato alla sconfitta. Questa forma di arte, che è giunta al suo apice con Sofocle, è composta da due aspetti diversi della cultura greca: lo Spirito Apollineo e lo Spirito Dionisiaco.
Spirito Apollineo e Dionisiaco
Il primo si rifà ad Apollo, è uno spirito legato all’ordine, alla razionalità, è lo spirito della chiarezza, che ognuno di noi utilizza quando cerca di rendersi conto di qualcosa.
Il secondo si rifà a Dioniso che non è propriamente di origine greca, ma caucasica. È il Dio che è legato all’ebrezza (Bacco per i Latini). Questo esprimeva nella Grecia arcaica l’intuizione delle forze irrazionali presenti nel mondo, è il Dio al tempo stesso della razionalità e dell’arazionalità (uno dei riti di adorazione a Dioniso era l’orgia, un momento in cui lo spirito si scatena unicamente perché vuole, stesso motivo dell’ebrezza).
Nella visione greca del mondo queste due prospettive si fronteggiano, una tenta di riportare tutto all’ordine, l’altro scatena le forze vitali senza ordine e senza scopo.
Influenze di Schopenhauer e Wagner
Alla radice dello spirito dionisiaco sta la lettura che Nietzsche fa di Schopenhauer e cioè la convinzione che la nostra civiltà è una civiltà razionale e bisogna quindi prendere entrambi gli spiriti, ma Apollo non è altro che un modo di accettare Dioniso nella vita ed è quindi lo Spirito Dionisiaco più importante ed originario.
Compaiono però nella cultura greca alcuni personaggi che distruggono questo equilibrio: Euripide, Socrate e Platone.
Socrate è il primo che immette nella cultura greca l’idea che la vera esistenza era un’esistenza razionale, Euripide nella tragedia greca ha sviluppato il ruolo del coro a discapito del ruolo del protagonista, infine Platone ha inventato un mondo perfetto, quello delle idee, e l’idea del corpo che trattiene l’anima. È proprio così che è nata la tragedia del mondo occidentale, dall’esistenza dei due mondi dove il peggiore è quello in cui viviamo. Tutta la storia del mondo occidentale non è altro che la negazione dello Spirito Dionisiaco.
I filologi criticano fortemente il testo di Nietzsche che viene visto come non appartenente alla vera filologia.
Accanto all’opera di Schopenhauer in questo periodo Nietzsche è influenzato dalla musica operistica di Richard Wagner, il compositore operistico più famoso nella Germania del tempo. Questo porta avanti un discorso culturale molto serio: le sue opere si rifanno tutte alla mitologia scandinava. Nietzsche ritrova in Wagner, ma soprattutto nella musica, la sua stessa idea e cioè l’importanza dello Spirito Dionisiaco finché non pubblica “Parsiafal”, la storia di un cavaliere cristiano alla ricerca del Sacro Grall.
Periodo illuministico (o filosofia del mattino: si propone di smascherare le credenze della cultura europea). Scrive “Umano troppo umano”, “L’aurora”, “La gaia scienza”. Nietzsche comincia a smascherare la menzogna portata avanti da Platone.
“La gaia scienza” è quella più importante. Scienza significa indagine critica, un atteggiamento che ti porta a criticare i difetti di quello che ti sta davanti, ma questa scienza è gaia cioè felice.
L’opera è costruita come una serie di pensieri separati l’uno dall’altro, in uno di questi Nietzsche racconta una storia: quella di un uomo folle che si reca a mezzogiorno sulla piazza del mercato con una lampada accesa dicendo “cerco Dio”. L’ambientazione è la piazza del mercato cioè il luogo più vivo della civiltà moderna, nel quale si costruiscono le linee fondamentali della società moderna, e qui ci sono gli atei che ascoltandolo cominciano a prenderlo in giro. Il pazzo allora li fulmina con lo sguardo, è così che si crea il silenzio: la società contemporanea pende dalle labbra del pazzo. Egli dice “Dio è morto e noi lo abbiamo ucciso” (Nichilismo). Gli atei non capiscono anche se dovrebbero essere d’accordo. “Noi siamo stati capaci di un crimine che non ha eguali nella storia ma non si è ancora compiuto del tutto, ma non vi sembra che il nostro universo sia stato completamente ribaltato, che noi ci troviamo in un buio che non si è mai visto”, gli atei continuano a non parlare perché infondo questi hanno un ateismo che si riduce a non praticare la religione, ma non prendono sul serio il fatto che se neghi Dio allora è necessario trovare un altro pilastro su cui costruire l’esperienza di singolo e di società.
Critica alla morale occidentale
“Umano troppo umano” insieme ad altri pone in discussione i criteri fondamentali della morale del mondo occidentale: la morale in quanto tale è degna della nostra reverenza?
La morale delle società occidentali è religiosa e nelle divinità Nietzsche non vede altro che invenzioni umane, quindi non è altro che una maschera dietro cui l’uomo europeo ha sempre nascosto la sua natura.
Mai nessuno si è posto il problema di capire da dove derivano i nostri pregiudizi morali e Nietzsche decide di indagare seguendo il metodo genealogico: la morale (e quindi la religione) serve a gli uomini per soggiogare gli altri, a quelli forti per sottomettere i deboli e viceversa. La morale cristiana è nata dall’istinto di vendetta degli uomini inferiori che creano una tavola di valori in cui prevalgono la passività e la rassegnazione.
La morte di Dio e l'oltreuomo
Per riprendersi la propria libertà accettandone il rischio è necessario trovare la forza per affrontare il niente dovuto dalla morte di Dio e ciò viene fatto attraverso la figura dell’oltreuomo che è proiettato nel futuro e capace di sostenere la visione di un mondo da cui tutti gli dei sono stati allontanati.
In “Aurora” (che significa alba) comincia l’idea di un mondo nuovo, Nietzsche comincia a pensare se stesso come l’annuncio di un’età nuova (è il primo a pensare una nuova società). Dobbiamo tornare ad essere fedeli alla terra.
Zaratustra e l'eterno ritorno
Il personaggio che annuncia l’avvento del superuomo è Zaratustra: un personaggio storico fondatore di una religione abbastanza diffusa, lo Zoroastrismo. Sceglie questo personaggio perché la sua religione si era posta in contrasto alle più grandi religioni e non rientra nella tradizione culturale, la fa perciò figura simbolo della sua filosofia. Egli rappresenta il fanciullo ridente che ha giurato fedeltà alla terra.
La morte di Dio da un lato svela l’architrave della menzogna, ma dall’altro apre moltissime nuove possibilità e implica anche il superamento dell’uomo nella cultura occidentale e della condizione lineare del tempo. Nietzsche racconta due storie:
Mentre stava facendo una passeggiata una voce gli dice “se questo momento dovesse ritornare ancora una volta e ancora una volta,..”. Dioniso ci dice che il tempo della natura e della vita è ciclico, non lineare, è un continuo ripetersi e per il superuomo diventa una condizione necessaria abbandonare la dimensione lineare del tempo e così abbandonarne anche il significato. Il senso della storia nella concezione lineare sta alla fine del percorso ed è proiettato nel futuro (per la religione sta nel giudizio di Dio alla fine dei tempi). L’eterno ritorno dell’uguale viene usato per indicare il superuomo che non avrà più bisogno di un significato che sta nel futuro perché sarà lui ad avere il significato pieno di ogni attimo che contiene in se il proprio valore e il proprio fine.
La visione e l’enigma: racconta la storia di un viandante che si trova ad un bivio e deve scegliere tra due vie, in una di queste trova un nano (nella mitologia germanico-scandinava ha a che fare con le profondità della terra, è opposto al cielo) a cui chiede consiglio su quale strada prendere. Il nano gli dice che le cose diritte mentono. La storia cambia di colpo, e si sposta su un uomo al quale, mentre dorme, un serpente (simbolo della terra) entra dentro la bocca. Lui si sveglia e uno che gli sta vicino dice di mordere per staccare la testa del serpente. L’uomo così fa e rinasce, come un bambino. È infatti necessario tornare alla terra come il bambino (che è in grado di dimenticare, non è quindi oppresso dalla storia ed è libero per il futuro).
Ma se togliamo Dio dobbiamo togliere l’uomo perché questi sono strettamente legati in quanto l’uomo è la copia di Dio e tolto l’originale è tolta anche la copia. Bisogna quindi modificare le strutture stesse della nostra esistenza.
La volontà di potenza e l'arte
Nietzsche sta dicendo che è necessario che noi siamo capaci di smascherare la menzogna che è Dio, ma è anche necessario sostituire questo con qualcos’altro ricostruendo da capo la nostra civiltà, essendo fedeli alla terra, cioè a Dioniso. Non esistono le consolazioni religiose che sono state soltanto una perversione delle società.
Nietzsche di li a poco diventa pazzo, è per questo che le sue opere sono incompiute e sono state pubblicate postume.
Come è possibile sostituire alla menzogna di Dio la religione di Dioniso?
Nietzsche vuole delineare una vera e propria pars costruens del suo pensiero; “La volontà di potenza” (ultima opera). Questo concetto è l’essenza della vita che si caratterizza come l’impulso a crescere e a volere sempre più. La volontà di potenza si identifica con l’arte che costituisce la forma suprema della vita e soprattutto con la musica ritenuta espressione dello spirito Dionisiaco. Sarà l’oltreuomo il creatore di questa nuova società assumendosi la responsabilità di offrire nuovi significati, nuove prospettive, e di liberare l’uomo dal peso del passato.
Nietzsche e il nazionalsocialismo
Rapporto tra Nietzsche e nazionalsocialismo: la sorella di Nietzsche verso la fine degli anni ‘20 presenta ad Hitler alcuni testi del fratello proponendolo come annunciatore del nazionalsocialismo. Nietzsche non ha nulla a che fare con il nazionalsocialismo in realtà, perché nel filosofo non c’è assolutamente l’idea del razzismo. La somiglianza dei due sta nella necessità di un rinnovamento antropologico.
Distacco da positivismo e marxismo
Rapporto con positivismo e marxismo: il positivismo aveva individuato nel sapere scientifico la risoluzione di tutti i mali e il marxismo ambiva ad una società di eguali costituita da esseri omologati e asserviti alla morale dominante, da entrambe si distacca soprattutto perché era insofferente per gli esisti banalizzanti della società di massa.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo dello Spirito Apollineo e Dionisiaco nella filosofia di Nietzsche?
- Come Nietzsche critica la morale occidentale e la religione?
- Cosa significa l'espressione "Dio è morto" secondo Nietzsche?
- Chi è l'oltreuomo e quale ruolo ha nella filosofia di Nietzsche?
- Qual è il rapporto tra Nietzsche e il nazionalsocialismo?
Lo Spirito Apollineo rappresenta l'ordine e la razionalità, mentre lo Spirito Dionisiaco incarna le forze irrazionali e vitali. Nietzsche vede questi due spiriti come elementi contrastanti ma complementari nella cultura greca, con Dioniso che rappresenta l'aspetto più originario e importante.
Nietzsche critica la morale occidentale come una costruzione umana che serve a soggiogare gli altri. Vede la religione come una maschera dietro cui l'uomo nasconde la sua vera natura, e propone di smascherare queste menzogne per costruire una nuova civiltà fedele alla terra.
"Dio è morto" rappresenta il nichilismo e la necessità di trovare nuovi pilastri su cui costruire l'esperienza umana e sociale, poiché la morte di Dio svela la menzogna su cui si fondava la civiltà occidentale e apre nuove possibilità.
L'oltreuomo è una figura proiettata nel futuro, capace di sostenere la visione di un mondo senza dei. È colui che deve creare nuovi significati e prospettive, liberando l'uomo dal peso del passato e costruendo una nuova società.
Nietzsche non ha nulla a che fare con il nazionalsocialismo, nonostante la sorella abbia presentato i suoi testi a Hitler. La somiglianza risiede solo nella necessità di un rinnovamento antropologico, ma Nietzsche non condivideva l'idea di razzismo.

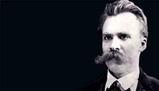





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo