Concetti Chiave
- Hobbes's philosophy is based on conventionalism and contractualism, where language, science, and political institutions result from agreements or contracts.
- There are two types of knowledge: common knowledge, rooted in sensory experience, and scientific knowledge, which refines common knowledge for practical and predictive purposes.
- Language, as a convention, serves mnemonic and communicative functions, transforming thoughts into verbal expressions without corresponding to any real entity.
- Hobbes's political philosophy revolves around the transition from a natural state to a civil state through a social contract, with the sovereign holding irrevocable and indivisible power.
- The Hobbesian state is independent from church influence, viewing religion as potentially harmful and advocating for state control over religious practices to ensure stability.
Indice
Filosofia di Hobbes
Tutta la filosofia di Hobbes presenta un’impostazione convenzionalistica e contrattualistica: il linguaggio la scienza e le istituzioni politiche sono risultato di accordi (contratti)
Conoscenza comune e scientifica
Esistono due forme di conoscenza:
- Conoscenza comune: si fonda sull’esperienza sensibile e svolge una funzione determinante nel linguaggio
Definita originaria perché è all’origine di tutte le conoscenze
fattuale perché attraverso l’esperienza noi conosciamo com’è di fatto
la realtà.
- Conoscenza scientifica: costituita dalla rielaborazione e rigorizzazione della conoscenza comune (per questo la scienza è detta conoscenza derivata).
A differenza della conoscenza comune non si limita a constatare come la realtà è di fatto ma permette di spiegarne le ragioni e le cause.
Immaginazione e memoria
La conoscenza comune è singolare infatti si fonda sulle immagini sensibili dei singoli corpi e dalla singole loro azioni.
Per opera dell’immaginazione le immagini sensibili si conservano sotto forma di idee che sono immagini sensibili sfuocate.
Nell’immaginazione opera la memoria.
Come le immagini sensibili anche le idee hanno un contenuto singolare (nell’idea di cane si conserva l’idea del singolo cane che abbiamo visto)
Le immagini sensibili inoltre appaiono costantemente associate (grazie alla ragione calcolatrice) e sulla base dell’abitudine elaboriamo previsioni che possono rivelarsi vantaggiose.
il pensiero è avere idee, ossia conservare immagini sensibili, e collegarle tra loro
Funzioni del linguaggio
Per Hobbes un’altra convenzione comune è il linguaggio, che ha una duplice funzione:
- Funzione mnemonica: i nomi fungono da contrassegni o note per la reminiscenza e suscitano nella mente un pensiero simile a uno passato.
- Funzione comunicativa: i nomi permettono di trasformare un pensiero in espressione verbale e quindi rendere il pensiero comunicabile agli altri, semplificando il collegamento tra immagine sensibile e idea
Per Hobbes al linguaggio non corrisponde nulla di reale infatti si tratta solo di una convenzione istituita arbitrariamente.
Anche l’associazione di più idee data dall’utilizzo di un nome è pura convenzione (il nome “cane” comprende il volpino e il san bernardo ma non la volpe dal punto di vista della morfologia animale è molto più simile al volpino che non il san bernardo)
Conoscenza derivata e scienza
La conoscenza derivata ha uno scopo prettamente pratico e operativo e permette quindi di effettuare previsioni e interventi sulla natura: la conoscenza scientifica è rigorosa mentre quella empirica non è sempre attendibile.
Secondo Hobbes la conoscenza scientifica è ciò che crea un maggior grado di benessere nelle popolazioni europee.
La filosofia è la conoscenza ottenuta mediante ragionamento rigoroso degli effetti in base alla conoscenza delle cause, e per converso quella delle cause in base alla conoscenza degli effetti.
Quindi secondo il filosofo osservando una figura che assomiglia a un cerchio, basandosi su delle immagini sensibili, non è possibile sapere con certezza se si tratta davvero di un cerchio; per non avere certi dubbi basterebbe essere alla conoscenza della causa generatrice, se questa per esempio è la rotazione di un compasso su uno dei due bracci allora non potrà che derivarne un cerchio.
Per Hobbes la causa degli errori dei filosofi è la mancanza di metodo: i filosofi dovrebbero definire più accuratamente i nomi che usano sul modello della geometria, evitare quindi il linguaggio metaforico che costituisce un ostacolo alla ricerca di verità.
Metodo scientifico e geometria
Anche la scienza è una convenzione infatti non potrebbe esistere un discorso scientifico senza definire i limiti entro cui esso devi restringersi, che devono essere comuni a tuta la comunità scientifica per essere universalmente validi.
Da questo punto di vista la geometria rappresenta un modello, a causa dell’elevato grado di formalizzazione e del suo rigore.
Conseguenza dell’ideale geometrico è il ragionamento inteso come calcolo: una volta stabiliti i significati dei termini da utilizzare in ambito matematico, la ragione procede ad applicare ai nomi stessi i concetti della matematica (addizione e sottrazione sono applicabili a tutti gli ambiti: in qualsiasi materia dove c’è posto per l’addizione e la sottrazione c’è posto per la ragione).
Oggetto della filosofia/scienza
Ma qual è l’oggetto della convenzione che fonda la filosofia/scienza?
Secondo Hobbes l’oggetto è il movimento dei corpi materiali : la convenzione che fonda la scienza deve perciò determinare delle definizioni per termini utilizzati dagli scienziati riguardo al movimento.
Queste definizioni fondamentali vanno a costituire quella che secondo Hobbes è la filosofia prima : definisce il significato di nomi in base a rapporti puramente quantitativi in modo che i filosofi possano pervenire a della conclusioni certe e universali.
Per questo Hobbes definisce il ragionamento come un calcolo: tutte le nozioni scientifiche possono essere trattate quantitativamente, misurate e quindi calcolate.
Meccanicismo in Hobbes : voler trattare in termini meccanici gli aspetti fisici, fisiologici, psicologici e politici.
non c’è quindi alcun bisogno di pensare che esista una sostanza immateriale come la res cogitans.
FILOSOFIA POLITICA :
Si fonda su una concezione pessimistica dell’uomo : ogni uomo è un meccanismo che per natura tende all’autoconservazione (egoismo)
L’uomo passa da uno stato di natura a uno stato civile
Stato di natura e contratto
Lo stato di natura :uguaglianza tra gli uomini, ciascuno sottomesso agli istinti, tutti hanno lo stesso diritto su tutto (ius omnium in omnia): non c’è piena sicurezza.
Dimensioni diverse dello stato di natura:
- Dimensione prestatale: tipica dei popoli primitivi
- Dimensione antistatale: anarchica
- Dimensione interstatale: rapporti internazionali.
L’uomo tende all’autoconservazione: per attuarla c’è bisogno di eliminare lo stato di natura perché crea una situazione di perenne instabilità.
Lo stato di natura viene superato attraverso un accordo (contratto): i cittadini rinunciano al proprio diritto su tutto, cedendolo a un terzo non contraente che sarà quindi l’unico a possederlo.
Il patto (“patto di unione”) comprende il “patto di società” (senza l’accordo non esisterebbe nessuna società) e il “patto di subordinazione” (il cittadino cede i propri diritti a un terzo, al quale sarà subordinato).
Sovranità e poteri del sovrano
I poteri del sovrano:
Il terzo, al quale il cittadino si affida, è il sovrano, l’unico a mantenere il diritto su tutto, che garantire a tutti la sicurezza e l’autoconservazione.
La sovranità secondo Hobbes è irrevocabile perché:
- La revoca richiederebbe l’unanimità di coloro che hanno istituito il potere
- Gli individui, avendo stipulato un contratto in favore di un terzo, non possono legittimamente destituire il sovrano senza il suo consenso.
- Senza l’accordo non esistono veri diritti, perciò, eliminandolo si tornerebbe allo stato di barbaria inciviltà.
La sovranità deve essere indivisibile :
- Una monarchia mista non alzerebbe il grado di libertà dei cittadini perché, se i poteri sono concordi il grado di soggezione sarebbe elevatissimo mentre se non fossero concordi si arriverebbe alla guerra civile.
- Se, come accade in Inghilterra, le leggi fiscali sono di competenza del parlamento, siccome il denaro è il nerbo sia della guerra che della pace si arriverebbe alla dissoluzione dello stato. Senza denaro non si può ne fare la guerra ne mantenere la pace.
I obblighi del sovrano nei confronti dei cittadini sono quello di garantire la conservazione della vita e la possibilità di essere felice.
I suoi doveri consistono nell’obbedire alla ragione, accrescere benessere e sicurezza: sono obblighi solo morali interiori, se il sovrano non li rispetta fa un torto a Dio non al cittadino, che quindi non ha motivo di ribellarsi.
Critica alla chiesa
Critica alla chiesa:
Lo stato hobbesiano è svincolato da ogni legame di subordinazione con la chiesa: la religione è considerata dannosa perché le diverse professioni portano allo scontro, alle cosiddette guerre di religione, che sono pericolose per la sicurezza dello stato. Per risolvere questa situazione (che si presenta tutt’oggi) è necessario inglobare la chiesa e le sue istituzioni nello stato assoluto.
Lo stato deve decidere la modalità di culto (eliminando pluralità).
Nonostante ciò il cittadino non ha modo di ribellarsi nemmeno per questioni religiose in quanto cambiano solo i modi attraverso cui si pratica la religione ma la fede in Dio non risulta intaccata.
Domande da interrogazione
- Qual è l'impostazione generale della filosofia di Hobbes?
- Quali sono le due forme di conoscenza secondo Hobbes?
- Come Hobbes definisce il linguaggio e la sua funzione?
- Qual è la visione di Hobbes sullo stato di natura e il passaggio allo stato civile?
- Qual è la posizione di Hobbes riguardo alla sovranità e ai suoi obblighi?
La filosofia di Hobbes ha un'impostazione convenzionalistica e contrattualistica, dove il linguaggio, la scienza e le istituzioni politiche sono visti come risultati di accordi o contratti.
Hobbes distingue tra conoscenza comune, basata sull'esperienza sensibile, e conoscenza scientifica, che è una rielaborazione rigorosa della conoscenza comune.
Hobbes vede il linguaggio come una convenzione con una funzione mnemonica e comunicativa, che non corrisponde a nulla di reale ma serve a semplificare il collegamento tra immagine sensibile e idea.
Hobbes descrive lo stato di natura come una condizione di uguaglianza e instabilità, superata attraverso un contratto sociale che porta alla formazione di uno stato civile con un sovrano.
La sovranità per Hobbes è irrevocabile e indivisibile, con obblighi morali verso i cittadini per garantire sicurezza e benessere, ma senza possibilità di ribellione da parte dei cittadini.

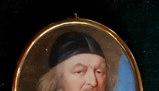





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo