Concetti Chiave
- Il XIV secolo non è un periodo di crisi della Scolastica, ma di innovazione dottrinale in filosofia e teologia.
- La condanna del 1277 valorizza la contingenza e sviluppa nuovi approcci all'aristotelismo, ampliando le possibilità divine.
- La scienza diventa ipotetico-congetturale, immaginando modelli esplicativi basati su ciò che è possibile oltre la realtà attuale.
- Il concetto di verità evolve, diventando una questione di coerenza logica piuttosto che di rispecchiamento della realtà.
- Il XIV secolo vede l'espansione delle Università in Europa, alimentando il progresso scientifico e accademico.
Indice
Crisi della scolastica nel XIV secolo
Il XIV secolo è stato a lungo rappresentato come un periodo di crisi della Scolastica, in cui si sarebbe consumato il crollo dell’equilibrio raggiunto nel secolo precedente tra fede e ragione, o tra filosofia e teologia.
Innovazioni dottrinali e contingenza
In realtà, è più che legittimo dubitare che tale equilibrio sia mai stato raggiunto nel XIII secolo. Soprattutto, sia per la filosofia che per la teologia, il Trecento è tutt’altro che un periodo di crisi: vengono avanzate soluzioni dottrinali profondamente innovative, e anche molto diversificate tra loro. Bisogna inoltre ricordare che nessun secolo si lascia ricondurre a un solo elemento di fondo, quando piuttosto diverse tendenze che si trovano a coesistere l’una accanto all’altra.
Potenza di Dio e scienza
La condanna del 1277 fa sentire i suoi effetti, soprattutto emerge l’importanza (in positivo) accordata alla contingenza, così come lo sviluppo di differenti approcci all’aristotelismo. La contingenza in questo caso è la convinzione che il nostro mondo non esaurisca tutte le possibilità della potenza divina, e che pertanto la sfera delle possibilità sia più ampia di quella dell’attualità. Quindi nasce anche la distinzione tra:
a. Potenza ordinata di Dio: Egli amministra il mondo secondo il corso regolare da Lui stesso istituito al momento della creazione
b. Potenza assoluta di Dio: la potenza non dispiegata, ciò che Egli avrebbe potuto fare in senso appunto assoluto, senza contraddizione.
Evoluzione del concetto di verità
La scienza assume così un carattere sempre più ipotetico-congetturale: non si tratta soltanto di descrivere la realtà così com’è, ma di immaginare differenti modelli esplicativi, che tengano conto di ciò che è possibile. Comincia a mutare anche il concetto di verità, non coincide più con il rispecchiamento fedele della realtà, ma con la coerenza logica. La verità non è una proprietà delle cose, ma delle proposizioni e va indagata e ricercata, come tale, a livello logico e linguistico. Si dà allora importanza alla logica, all’analisi del linguaggio, e alla definizione stessa degli oggetti di conoscenza: conosciamo le cose o le loro rappresentazioni? Quindi l’analisi delle modalità con cui la nostra mente si rapporta al reale.
Riflessione politica e università
Grande rilevanza ha anche la riflessione politica, fatto dettato dalle circostanze storiche, e in particolare dalla radicalizzazione delle tesi teocratiche portata avanti da Bonifacio VII. Il Trecento è anche il secolo in cui si consolida e si espande in tutta Europa la rete delle Università, come vero fattore del decollo scientifico dell’Occidente.
Domande da interrogazione
- Qual è la percezione comune del XIV secolo riguardo alla Scolastica, e come viene rivalutata nel testo?
- Quali sono le due distinzioni della potenza divina menzionate nel testo?
- Come cambia il concetto di verità nel XIV secolo secondo il testo?
Il XIV secolo è spesso visto come un periodo di crisi della Scolastica, con un presunto crollo dell'equilibrio tra fede e ragione. Tuttavia, il testo suggerisce che questo equilibrio potrebbe non essere mai stato raggiunto nel XIII secolo e che il Trecento è in realtà un periodo di innovazione dottrinale.
Il testo distingue tra la "potenza ordinata di Dio", che si riferisce all'amministrazione del mondo secondo un corso regolare, e la "potenza assoluta di Dio", che rappresenta ciò che Dio avrebbe potuto fare in senso assoluto, senza contraddizione.
Nel XIV secolo, il concetto di verità si trasforma: non è più visto come un rispecchiamento fedele della realtà, ma come coerenza logica. La verità diventa una proprietà delle proposizioni, da indagare a livello logico e linguistico.

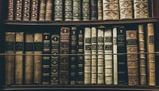






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo