Concetti Chiave
- Sordello è rappresentato da Dante come un'anima fiera e patriottica, legata alla sua città natale, Mantova, piuttosto che all'Italia come entità nazionale.
- Dante apprezza Sordello per aver superato le limitazioni linguistiche del suo dialetto mantovano, dimostrando grande eloquenza poetica.
- Il nome "Mantua" crea un legame simbolico tra Dante e Sordello, influenzando la rappresentazione del loro incontro nell'Antipurgatorio.
- Il contatto con Sordello permette a Dante di esprimere critiche ai principi del suo tempo, utilizzando Sordello come portavoce di un messaggio civico.
- La possibile coincidenza del "compianto" scritto da Sordello per ser Blacatz rafforza la scelta di Dante di usarlo come simbolo di denuncia politica.
Il personaggio di Sordello
Non sappiamo che cosa Dante conoscesse della vita e dell'opera poetica di Sordello: forse meno di quel che conosciamo noi, assai probabilmente non più. Comunque, nei versi nulla traspare della complessa vita di Sordello: amori, avventure, cortigiania, azione politica e guerriera. Nemmeno la poesia amorosa di lui sembra avervi lasciato traccia. Il personaggio non parla mai di sé. Che sia un poeta, desumiamo solo dalla sua riconoscenza a Virgilio; e del resto Dante nel De vulgari eloquentia lo considera appunto come poeta importante (VE I xv 2).Sordello è essenzialmente un'anima «altera e disdegnosa», attaccata alla sua città, e in particolare ai suoi concittadini. Tutti i commentatori dicono che egli impersona l'amor patrio, e solo discutono se si tratti di patriottismo italiano, in senso già moderno, o di amor cittadino: dilemma in verità mal posto, giacché nell'Italia del Due-Trecento l'amor patrio non poteva avere basi se non municipali: l'Italia è per Dante, sì, un'unità culturale (basti citare « per le parti... tutte a le quali questa lingua si stende», Cv I mI 4), ma nella quale vigono in pieno le singole unità comunali o signorili.
Comunque, nella vita e nella poesia di Sordello nulla testimonia un suo particolare attaccamento né all'Italia né a Mantova, e neppure a Mantova in quanto Italia. Ma forse è possibile dare del fatto una spiegazione molto semplice, in sede di tecnica, per così dire, del processo fantastico.
Comunque si debba intendere con precisione il passo citato del De vulgari eloquentia, di difficile e controversa interpretazione, certa è la lode per Sordello, «tantus eloquentiae vir», in particolare per aver egli superato dal punto di vista linguistico il suo linguaggio mantovano, cioè la municipalità: il che non diminuiva certo agli occhi di Dante l'attaccamento per la città natia, così come, precisando che solo i pazzi potessero ritenere il fiorentino, come gli altri linguaggi toscani, atto all'alta poesia (VE I XII 1), egli non riteneva di venir meno per questo all'amore che portava a Firenze.
Dunque, nel pensiero di lui, i meriti poetici di Sordello erano per così dire in funzione di Mantova: «ut Sordellus de Mantua sua ostendit», egli dice; «De Mantoana», o «de Sirier (quale che sia l'identificazione di questa località) de Mantoana» lo dicevano subito al principio le due vidas provenzali di lui. D'altra parte, lo stesso nome di «Mantua» agiva sulla fantasia di Dante attraverso l'epitafio virgiliano: «Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc / Parthenope: cecini pascua, rura, duces», che infatti il poeta mette testualmente in bocca a Virgilio: alla richiesta di Sordello, che vuol sapere chi siano i suoi interlocutori, il poeta latino comincia a pronunciare l'epitafio attribuitogli dalla tradizione, il quale avrebbe costituito una minima ma esauriente autobiografia.
Il legame tra Dante e Sordello
I due poeti mantovani erano dunque uniti tra loro da quel nome, «Mantua», che restava nella memoria letteraria di Dante saldamente unito a ciascun d'essi. Né si può trascurare l'importanza che alla città natale del suo maestro Dante dà in If XX 52-99. Assai probabile dunque che proprio la suggestione del nome abbia portato il poeta a immaginare l'incontro affettuoso tra i due nell'Antipurgatorio, donde sgorga naturalmente l'invettiva contro la discorde Italia attuale.Tale contatto con Sordello lo porta altresì in contatto ideale col 'compianto' che egli aveva scritto in morte del cavaliere provenzale ser Blacatz, nel quale rampognava fieramente i principi del suo tempo: il che non meno naturalmente lo rendeva suo portavoce in una consimile e diversa rampogna, come vedremo leggendo il canto seguente. Naturalmente può darsi benissimo che il processo genetico sia stato inverso, ed è l'opinione vulgata: che, cioè, sia stato il 'compianto' a far scegliere Sordello per la rampogna ai principi, e che poi la coincidenza («fortuita», dice il Parodi) della patria avrebbe, in linea secondaria, portato a immaginare l'incontro e quindi l'invettiva. Ma lo sviluppo dell'episodio nel suo insieme, persuade a ritener primario l'intento civico.

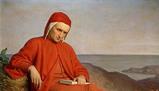





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo