Concetti Chiave
- Dante esprime nostalgia per il tempo antico, idealizzando la società feudale-cavalleresca rispetto alla moderna società comunale-mercantile.
- Il poeta utilizza la tecnica dell'enumeratio, elencando nomi di persone e famiglie per evocare la civiltà passata, piuttosto che un singolo evento o personaggio.
- La critica sulla mancanza di drammaticità nelle sue rassegne è ritenuta impropria, poiché l'intento è evocare una civiltà diffusa piuttosto che figure individuali.
- La cavalleria è descritta come un ideale di vita che unisce valore, cortesia, cultura e poesia, contrapposto ai principi attuali che si circondano di persone indegne.
- Il rimpianto di Dante si concentra particolarmente su Firenze, ma si estende anche a altre regioni d'Italia e all'Europa intera.
Introduzione
Noi sappiamo che uno dei motivi più costanti e importanti della Commedia è il rimpianto del buon tempo antico, a specchio del degenerato presente; in termini politico-sociali esso si traduce nel rimpianto della società feudale-cavalleresca a specchio della società comunale-mercantile, e dei signori nuovi, indegni dei loro predecessori. Di tale motivo abbiamo parlato più volte, e particolarmente nelle Introduzioni ai canti VII e VIII del Purgatorio; né occorre ripeterci.La lamentela, che Dante estende a tutta Europa, si particolareggia qui, prima nella Toscana, poi nella Romagna; si estenderà nel canto XVI 115-141 alla Lombardia, nel canto XX 61-96 ai Capetingi; con speciale intensità si concentra in Firenze (Pd XV 97-129, XVI 88-154). Il poeta si conforta solo al pensiero che la ragione del disordine dei suoi tempi non risiede nell'intrinseca natura umana, e neppure negli influssi degli astri, ma ha cause politico-religiose che sta agli uomini eliminare (vedi Intr. a Pg XVI).
Nostalgia del buon tempo antico
A esprimere in questo canto la sua nostalgia del buon tempo antico, il poeta ricorre, come frequenti volte in analoghe o diverse occasioni, all'elencazione di lunga serie di nomi, nudi o quasi, di persone e di famiglie (indifferentemente guelfi o ghibellini), cioè alla tecnica dell'enumeratio, tanto usata dai poeti classici e dalla Bibbia, ripresa dai sirventesi medievali; ritornerà nei poemi cavallereschi italiani del Rinascimento.Impropria, anche se diffusa, appare la lamentela dei critici circa la mancata figuratività o drammaticità di questa rassegna. A giustificare il poeta, che in verità non ne ha bisogno, si dice che questi nomi, muti per noi moderni, richiamavano invece negli immediati lettori di Dante folla d'immagini e di ricordi: il che è vero solo sino a un certo punto, perché molti di quei personaggi non erano neppure ai loro tempi di primo piano, e non è probabile che fossero familiari a lettori dell'età di Dante, di circa un secolo posteriori a essi.
Il fatto è, invece, che il poeta non ha concentrato la sua nostalgia su uno o più personaggi, su uno o più fatti memorabili, aventi quelli e questi un loro spessore psicologico o narrativo; i nomi gli si affollano sotto la penna, e ciascuno di essi non vale per sé, ma proprio in quanto elemento d'una folla. Il tema di Dante non è qui un singolo, ma una civiltà il cui pregio consiste nella sua diffusione.

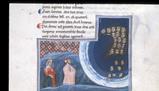





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo