Concetti Chiave
- Dante preferisce il volgare al latino per ragioni affettive, e ne delinea l'ideale nel De vulgari eloquentia, scritto in latino per un pubblico competente.
- Il volgare illustre, secondo Dante, non è legato a nessuna città specifica e serve da modello ideale per i vari linguaggi locali inadeguati come lingua nazionale.
- Dante descrive il volgare illustre come "illustre, cardinale, regale e curiale", attribuendogli qualità di diffusione di luce, guida, regalità e capacità di giudizio.
- Nel paragrafo XVIII, il volgare illustre è paragonato a un capofamiglia che guida gli altri volgari municipali, rappresentando un modello linguistico e culturale.
- La lingua delineata da Dante è un mezzo di espressione artistica e culturale, non di uso quotidiano, che potrebbe unire la nazione diffondendo luce e cultura.
Introduzione
Per tutta una serie di ragioni, anche affettive, sappiamo che Dante preferiva il volgare al latino ed esprime il suo pensiero in merito nel Convivio. Nel De vulgari eloquentia, scritto in latino, proprio perché si tratta di un’opera soprattutto teorica e destinata ai competenti. Nel cap. 1, paragrafi 16-18, di questa opera, egli delinea il suo ideale di lingua volgare a cui tutti devono tendere.
Paragrafo XVI
Nel paragrafo XVI, Dante afferma che il volgare illustre, in realtà non sembra appartenere a nessuna città e ad essi gli altri volgari vengono paragonati. In altre parole, Dante sostiene che la valutazione dei vari linguaggi locali e la constatazione che ognuno di essi è inadeguato a fungere da lingua nazione sono fatte alla luce del nodello ideale che egli si immagina che verranno illustrate nelle righe seguenti.
Paragrafo XVII
Nel paragrafo XVII, Dante si propone di spiegare perché il modello di volgare auspicato venga definito illustre, cardinale, regale e curiale. Innanzitutto, spiega il valore del termine “illustre”. Per illustre si intende qualcosa che è in grado di diffondere la luce che risplende e che diffonde la luce, Infatti l’aggettivo è spesso associato al termine “uomini”, per gli uomini illustri sono coloro che diffondono sugli altri la luce di giustizia e di carità e che sono depositari di un alto magistero. Anche il volgare italiano che Fante ha in mente è investito di un alto magistero che gli dà la possibilità di distinguersi e di “sollevarsi ben in alto”, con onore e gloria. Fra gli uomini illustri, Dante cita Seneca e Numa Pompilio. Il primo fu un filosofo e il seco ndo che fu uno dei sette re di Roma, un grande legislatore. L’accostamento di queste due figure non è casuale perché a Dante, come auspicato nel De Monarchia, interessa un sovrano-filosofo, in grado di costituire una guida e una luce per il mondo. Citando come esempio Cino da Pistoia, uno scritto appartenente allo Stilnovo, Dante sottolinea il fatto che il modello di volgare illustre che sostiene si innalza sugli altri linguaggi che si distinguono da esso per le costruzioni intricate, per le desinenze sbagliate, per l’accento spesso campagnolo. In tal modo il volgare illustre si distingue per la nobiltà e la limpidezza, proprio come la raffinatezza delle composizioni del suo amico Cino da Pistoia. Il dialetto illustre ha anche un forte potere che lo esalta è in grado di smuovere il cuore degli uomini e di convincerli a fare ciò che magari non vorrebbero fare. Questa esaltazione della parola e quindi anche della poesia culmina, alla fine del paragrafo in un commosso accenno autobiografico (riferimento all’esilio) che dimostra proprio detto potere.
Paragrafo XVIII
Il paragrafo XVIII si apre con una similitudine. Il volgare illustre è chiamato anche cardinale e come la porta, in qualsiasi direzione si apra, va sempre dietro il cardine, come l’insieme dei volgari municipali si muove in funzione del volgare illustre proprio come si trattasse di un capofamiglia. Questa seconda similitudine sottolinea il ruolo decisionale e autorevole che spetta al volgare ipotizzato. Questo capofamiglia è anche coltivatore attento che impartisce ordine ai suoi giardinieri, ossia agli autori impegnati nell’attuazione del modello di lingua ideale.Per quanto riguarda il termine “regale” si collega all’ipotesi della presenza di una reggia in Italia. Tale reggia, nella prospettiva dantesca (che sarà poi esplicitata nel De Monarchia) è la sede imperiale che dovrebbe spettare a Roma: essa costituirebbe il punto di riferimento e il modello anche sul piano linguistico, in sintesi la “casa comune” come scrive testualmente Dante. Nella formulazione del ruolo della reggia, Dante pensa alla funzione unificatrice, culturale e propulsiva di Federico II di Svevia e di Manfredi. Da questo deriva che tutti coloro che frequentano i palazzi reali si esprimono sempre in volgare illustre e purtroppo, constata amaramente il poeta, il nostro volgare illustre se ne va pellegrino come uno straniero che trova accoglienza in ripari umili, dato che l’ Italia è priva di reggia.
Quindi passa a descrivere l’epiteto “curiale”. Nel Medioevo, per curialitas si intendeva l’agire con equilibrio di una persona all’interno di una comunità. In pratica, si trattava della razionale capacità di valutare e soppesare comportamenti e azioni. Il riferimento nel testo alla bilancia ci rimanda alle riunioni di dignitari che assistevano il sovrano nel suo governo e che quindi valutava il pro e il contro di ogni decisione da assumere. Per questo momento il volgare illustre è stato spesso soppesato nella curia più eccelsa d’Italia e per questo è degno di essere chiamato curiale.
Conclusione
La lingua di cui Dante delinea le caratteristiche non è una lingua d’uso comune, cioè di uso giornaliero. Si tratta di una lingua d’arte, un mezzo di espressione poetica e culturale, dal carattere raffinato ed illustre nel senso che diffonde luce intorno a sé. Essa è uno strumento comune ed unitario che può essere fattore dell’unità nazionale.Domande da interrogazione
- Qual è l'opinione di Dante riguardo al volgare rispetto al latino?
- Come descrive Dante il volgare illustre nel paragrafo XVI?
- Perché Dante definisce il volgare illustre come "illustre, cardinale, regale e curiale"?
- Qual è il ruolo del volgare illustre secondo Dante nel paragrafo XVIII?
- Qual è la visione di Dante sulla funzione unificatrice del volgare illustre?
Dante preferiva il volgare al latino per ragioni affettive e lo esprime nel Convivio, mentre nel De vulgari eloquentia, scritto in latino, delinea il suo ideale di lingua volgare.
Dante afferma che il volgare illustre non appartiene a nessuna città specifica e serve come modello ideale per valutare i vari linguaggi locali, che risultano inadeguati come lingua nazionale.
Dante spiega che il volgare illustre è "illustre" perché diffonde luce e giustizia, "cardinale" perché guida gli altri volgari, "regale" per la sua connessione con la sede imperiale di Roma, e "curiale" per la sua capacità di valutare e soppesare decisioni.
Il volgare illustre funge da capofamiglia per gli altri volgari municipali, impartendo ordine e fungendo da modello linguistico e culturale, simile a un sovrano che guida il suo popolo.
Dante vede il volgare illustre come uno strumento comune e unitario che può fungere da fattore di unità nazionale, diffondendo luce e cultura, nonostante l'assenza di una reggia in Italia.

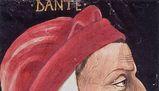





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo