Concetti Chiave
- Dante esplora la triplice dimensione dell'anima umana: vegetativa, animale e razionale, basandosi su Aristotele e la filosofia Scolastica.
- Individua salvezza, amore fisico e virtù come temi centrali da trattare con uno stile elevato, correlati a coraggio, amore ardente e retta volontà.
- Distinzione tra tragedia, commedia ed elegia è basata su stile e contenuti, con tragedia associata a uno stile superiore.
- Dante critica i contemporanei come Guittone d'Arezzo per trattare tematiche elevate senza uno stile adeguato, usando una similitudine per evidenziare la loro mediocrità.
- Relazione tra contenuto e forma è regolata da un criterio morale, influenzando il giudizio estetico e posizionando il moralmente superiore in cima al podio stilistico.
Indice
Introduzione
Dante, dopo aver espresso la sua preferenza per il volgare ed aver indicato le caratteristiche del modello di volgare, passa a codificare le regole dell’eloquenza in volgare. Il problema che lo scrittore affronta nel cap. II, 2,4 del De vulgari eloquentia era stato già ampiamente dibattuto in epoca classica. Esso consisteva nel rapporto fra l’argomento scelto e lo stile adeguato per trattarlo.
La triplice dimensione della natura umana
Per Dante, l’anima umana a tre dimensioni: vegetativa, animale e razionale che accomunano l’uomo rispettivamente alle piante, alle bestie e agli angeli. A seconda della dimensione si hanno obiettivi diversi: la dimensione vegetativa persegue l’utile come obiettivo, nella sua dimensione animale l’anima si pone come obiettivo l’utile, in quella razionale l’uomo è alla ricerca dell’onesto. Questa teoria è ripresa da Aristotile e dalla filosofia Scolastica. Quindi è chiaro che l’uomo fa ogni cosa in funzione di queste tre finalità. Nell’ambito di ogni finalità esistono cose di maggiore o minore importanza e quelle di maggiore importanza devono essere rattate in un volgare più elevato.I sommi temi da trattare o argomenti di massima portata
Prima di proseguire, Dante individua quali siano le cose di massima importanza, Nell’ambito dell’utile, la cosa più importante è la salvezza, intesa in senso materiale come autoconservazione. Nell’ambito del piacere, abbiamo l’amore fisico e nel terzo ambito troviamo la virtù. Si tratta di tre argomenti che devono essere trattati con uno stile elevato, come deve essere fatto anche gli altre tematiche che sono in più stretta relazione con essi e cioè il coraggio nell’uso delle armi, l’amore ardente e la retta volontà. Aggiunge, poi, richiamando un precetto di Orazio, che, metaforicamente, ognuno deve adeguare alle proprie spalle il peso della materia al fine di evitare di cadere nel fango. Questo precetto significa che ogni individuo dovrebbe scegliere argomenti e stili letterari adatti alle proprie capacità e competenze per cadere nella mediocrità. Bisogna notare che l’accenno ad Orazio è appena accennato è questo dimostra che Medioevo che tale insegnamento era presente nei testi di retorica e quindi molto noto.
La distinzione fra tragedia, commedia ed elegia
Nell’ambito della materia oggetto di poesia deve essere fatta distinzione all’interno del modo di cantarli: tragico, comico o elegiaco. Sembrerebbe che con “tragedia” lo scrittore voglia riferirsi ad uno stile superiore, mentre lo stile proprio della commedia è riservato a tematica inferiori (= “lo stile degli infelici”). A questa distinzione, Dante fa spesso riferimento, ma non risulta sempre chiara la graduatoria di valore: tragedia, commedia, elegia, oppure tragedia, elegia e commedia. D’altra parte, non avendo Dante portato a termine il De vulgari eloquentia la distinzione fra volgare mediocre e volgare umile non la abbiamo e questo rende il problema ancora più difficoltoso da risolvere. Pertanto, da questo deriva una continua fluttuazione della commedia fra mediocritas e humilitas, cioè fra stile medio e stile umile. Un altro problema è rappresentato dall’incertezza del significato di “elegia”, che viene definita da Dante non in base a connotati stilistici, come avviene per la commedia e la tragedia, ma soltanto per i suoi contenuti. D’altra parte, sottolinea Dante, ciò che è sommo deve essere espresso in uno stile sommo, com’è il caso della salvezza, dell’amore e della virtù, purché essi non siano sviliti da qualche aspetto accidentale. In Dante, il termine “accidentale” si riferisce a qualcosa che è accessorio e non necessario e si contrappone al termine “substantia”, un’accezione ripresa dalla filosofia aristotelica e dalla Scolastica. Il poeta raccomanda di trarre ispirazione e insegnamento dalla tradizione poetica (= “…. Si abbeveri nelle acque d’Elicona”, la catena montuosa della Boezia, sede mitologica delle Muse e di Apollo). La capacità di discernimento e l’apprendimento della cautela sono due elementi che costituiscono la massima fatica poetica da sostenere a cui si deve aggiungere un ingegni vigoroso, una tecnica appropriata e il possesso della cultura.
La polemica contro certi letterati del tempo
A questo punto, Dante inserisce una forte polemica contro i poeti suoi contemporanei, probabilmente Guittone d’Arezzo e i suoi seguaci. Coloro che pur avendo l’ingegno e la capacità tecnica nonché la cultura necessaria si dedicano a cantare tematiche somme senza preoccuparsi di cantarle in uno stile elevate. Anche in questa circostanza, Dante ricorre ad una figura retorica: la similitudine. Nella loro presunzione e nella loro tendenza naturale ad essere fannulloni, la matura li ha creati oche e non possono imitare le aquile che si slanciano verso il cielo.
Nota conclusiva
Per Dante, il rapporto fra contenuto e forma, cioè fra contenuto e stile, è regolato da un criterio morale, per cui dal punto di vista stilistico ed estetico, arriva al gradito più alto di un ipotetico podio ciò che, moralmente è superiore. Per questo, si può affermare che il giudizio estetico è condizionato dalla valutazione morale.
Schematizzazione delle argomentazioni di Dante
L’anima ha tre dimensioni (vegetativa, animale e razionale. Ad ogni dimensione corrispondono una finalità da perseguire, degli obiettivi di massima portata e degli argomenti attinenti.Domande da interrogazione
- Quali sono le tre dimensioni dell'anima umana secondo Dante?
- Quali sono gli argomenti di massima importanza individuati da Dante?
- Come Dante distingue tra tragedia, commedia ed elegia?
- Qual è la critica di Dante verso i letterati contemporanei?
- Come Dante vede il rapporto tra contenuto e forma?
Secondo Dante, l'anima umana ha tre dimensioni: vegetativa, animale e razionale, che corrispondono rispettivamente alle piante, alle bestie e agli angeli.
Dante individua la salvezza, l'amore fisico e la virtù come argomenti di massima importanza, che devono essere trattati con uno stile elevato.
Dante distingue tra tragedia, commedia ed elegia in base allo stile e ai contenuti, con la tragedia associata a uno stile superiore e la commedia a tematiche inferiori.
Dante critica i poeti contemporanei, come Guittone d'Arezzo, per cantare tematiche elevate senza preoccuparsi di usare uno stile adeguato.
Dante vede il rapporto tra contenuto e forma come regolato da un criterio morale, dove il giudizio estetico è condizionato dalla valutazione morale.

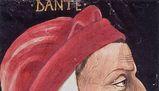





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo