Concetti Chiave
- Il trovatore, nato tra il 1120 e il 1130, proveniva da una famiglia di umili origini e visse una vita raminga tra diverse corti europee.
- Considerato il trovatore dell'amore, si distingue per concentrarsi esclusivamente su temi amorosi, evitando quelli politici, morali o religiosi.
- La sua opera poetica esplora l'amore in tutte le sue sfaccettature, con temi ricorrenti come la gelosia, le delusioni e l'estasi del primo bacio.
- Le poesie del trovatore sono caratterizzate da uno stile elegante e armonioso, arricchito da immagini inaspettate ispirate dalla natura.
- Le immagini naturali nella sua poesia conferiscono un'originalità distintiva, elevando il valore e la singolarità della sua opera.
Cenni biografici
Di questo trovatore non abbiamo notizie sicure. Sappiamo che nacque fra il 1120 e il 1130 da una famiglia di umili origini. Infatti, il padre era un servo del castello di Ventadorn, nella regione di Limoges. Condusse una vita raminga da una corte all’altra. Prima, visse presso il visconte di Ventadorn della cui moglie si innamorò; successivamente lo troviamo alla corte di Enrico II d’Inghilterra e di sua moglie Eleonora di Aquitania, famosa per il suo mecenatismo. Si innamorò anche di lei e le dedicò alcune liriche. In seguito fu alla corte di Raimondo di Tolosa. Dopo il 1173, di lui non si hanno più notizie.
Opera poetica
I critici considerano questo poeta il più grande dei trovatori e lo definiscono il trovatore dell’amore, poiché è l’unico che non affronta mai temi politici, morali o religiosi, come invece succedeva nella tradizione trobadorica con i sirventesi.Il problema che ci dobbiamo porre e che, tutto sommato riguarda tutti i trovatori, è la storicità degli eventi presenti nei componimenti. Il tema sempre presente è l’amore in tutte le sue sfaccettature: i languori, i desideri, le ansie del primo amore per una dama vagheggiata fin dall’infanzia, la donna amata prima distante e inaccessibile, poi incoraggiante, l’ebbrezza dell’ amore corrisposto, l’estasi del primo bacio, le amarezze, le delusioni, la gelosia del poeta nei confronti di un cavaliere che la nobildonne sembra preferire ad un giovane di umili origini, la gelosia del marito. Alcuni critici vedono nelle tematiche un riscontro perfetto nella biografia del poeta. Altri negano assolutamente il riflesso di situazioni realmente vissute. In altre parole, per questi ultimi, il poeta canterebbe situazioni frequenti nella poesia dei trovatori con indizi biografici vaghi e imprecisi: il poeta ha saputo immaginare molte situazioni amorose e colorirle con alcuni aspetti della realtà. In sintesi, ciò che per un critico appare evidente e molto certo, per un altro appare del tutto inaccettabile. Il critico tedesco Vossler, per definire la poesia di Bernart, ricorre al linguaggio della meccanica celeste: egli raffigura la lirica del poeta come un sistema planetario in cui intorno al sole, ossia “Minnie” (= la dama) ruotano tutti i vari componimenti come fossero dei pianeti, retti dai due poli del sole, il polo sensuale e il polo contemplativo. Il moto dà luogo a quattro fasi che il critico chiama “minnezeite” nelle quali l’arte del poeta si esaurisce ed è circolare poiché riporta sempre alla fase di partenza da cui il ciclo riprende; ed è molto importante che una stessa canzone si svolga lungo due o tre fasi.
I temi e le immagini
I temi affrontati sono i soliti della letteratura provenzale: l’amore umile e devoto verso la donna amata senza esserne corrisposto, l’austerità della dama, la timidità dell’amante, l’ardore del desiderio che, però, resta inappagato, il languore della lontananza, la reazione e il turbamento provocato dal primo bacio, la delusione del tradimento, l’affermazione del ruolo nobilitante del sentimento amoroso. Tutti questi sentimenti sono espressi in uno stile elegante, armonioso ed elegante, ma che spesso lasciano il lettore freddo. Nelle sue poesie, però, ad un tratto sopravvengono delle immagini inaspettate, ispirate dalla natura, che costituiscono l’originalità dell’opera, dandole valore e singolarità.
Esempio di immagini
“Che una chiarità mi illumina d’Amore, che nel cuore mi raggia. I prati mi sembrano verdi e vermigli come nel dolce tempo di maggio. La neve c’è come un fiore bianco e vermiglio”, oppure “La dolce voce ho udita del rosignoletto selvaggio; ed emmi balzata nel cuore….”Domande da interrogazione
- Chi era il trovatore descritto nel testo e quali sono le sue origini?
- Quali sono i temi principali dell'opera poetica del trovatore?
- Come viene descritta la poesia del trovatore secondo il critico tedesco Vossler?
- Quali sono le caratteristiche stilistiche delle poesie del trovatore?
- Qual è l'importanza delle immagini nella poesia del trovatore?
Il trovatore nacque tra il 1120 e il 1130 da una famiglia di umili origini, con il padre che era un servo del castello di Ventadorn. Visse una vita raminga, spostandosi da una corte all'altra.
I temi principali sono l'amore in tutte le sue sfaccettature, come i languori, i desideri, le ansie del primo amore, la gelosia, e le delusioni amorose. Non affronta mai temi politici, morali o religiosi.
Vossler descrive la poesia del trovatore come un sistema planetario in cui i componimenti ruotano intorno al sole, rappresentato dalla dama, con un moto che dà luogo a quattro fasi chiamate "minnezeite".
Le poesie sono caratterizzate da uno stile elegante e armonioso, ma a volte lasciano il lettore freddo. Tuttavia, contengono immagini inaspettate ispirate dalla natura, che conferiscono originalità e valore all'opera.
Le immagini ispirate dalla natura costituiscono l'originalità dell'opera, dandole valore e singolarità, come dimostrato dagli esempi di immagini poetiche che evocano la bellezza della natura.

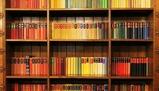





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo