In questo appunto di letteratura greca viene descritta il genere letterario greco della poesia lirica che era il più noto canto che si dedicava ai riti funebri. La poesia lirica inoltre acquistò ancora più spazio distanziandosi notevolmente dall’epos, che era più solenne.
I caratteri generali della poesia lirica
Con lo stabilizzarsi delle poleis come organizzazioni politiche autonome, cambiò anche la mentalità dell’uomo greco, che da una parte era ancora attaccato alle tradizioni, ma dall’altra era anche aperto al mondo, ne apprezzava la bellezza, e aveva bisogno che l’arte rispondesse alle sue esigenze. Fu in questo clima che nacque la lirica o meglio si affermò, perché già da tempo esisteva ma in tono minore; era infatti il canto dedicato ai riti funebri. Ben presto acquistò sempre maggiore spazio e si distanziò dall’epos, che era più solenne. Il termine ”lirica”, viene dalla lira, lo strumento che accompagnava il canto. Il suo nome più antico è “melica”, ripartita in monodica e corale. In seguito la definizione di lirica designò anche, l’elegia e il giambo.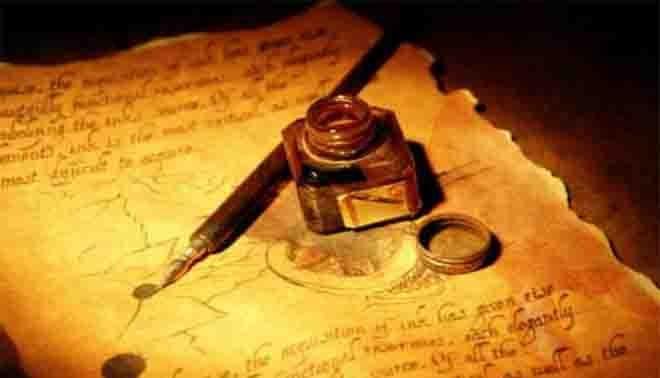
La lirica, poiché esprimeva sensazioni molto varie, necessitava di un metro più duttile dell’esametro epico, esso infatti era il distico elegiaco. I modi di accompagnamento musicale erano l’auletico e il citaristico, il primo con strumenti a fiato, il secondo a corda. Le danze che accompagnavano la musica erano molto varie: la pirrica, la gimnopedia, danze religiose e orgiastiche (per esempio quelle in onore di Dioniso).
Melica
La poesia melica era di due tipi:- Melica monodica: il tipo di lirica che più si avvicina al nostro modo di intenderla oggi. Era eseguita da un solista (mono odè).
- Melica coralica: come dice il nome era accompagnata da coristi ed era destinata al pubblico. Era tipica di manifestazioni, riti religiosi ed era a pagamento. L’esecutore veniva pagato a fine esecuzione e anche se non aveva il pregio dell’improvvisazione, raggiungeva alti livelli tecnici.
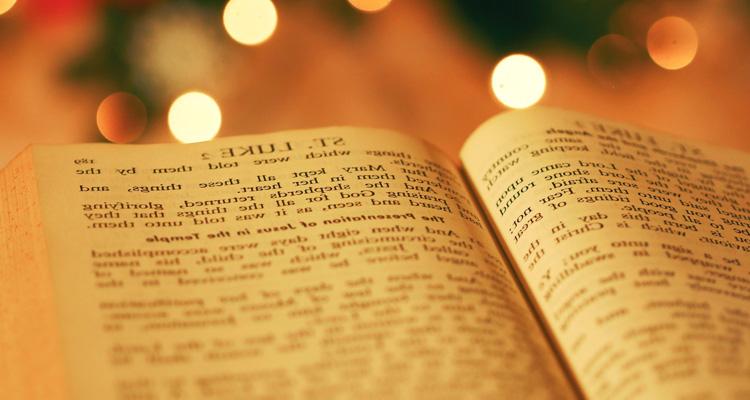
Elegia
L'elegia era di tono elevato, originaria della Ionia ed era una poesia recitata in pubblico con accompagnamento del flauto.Molto si discute, sull’origine del nome, alcuni infatti la fanno derivare da ελεγος (flauto), altri dall’espressione ευ λεγειν (dire bene) in accordo col fatto che pare fosse eseguita nelle lamentazioni e commemorazioni funebri.
Giambo
Il giambo differisce dall’elegia per tematiche e metro. Il nome deriverebbe da Iambe, la serva che con i sue scherzi e le sue facezie cercava di alleviare la sofferenza di Demetra, dopo che la figlia Persefone era stata rapita da Ade.Il giambo designa sia il genere poetico che il metro. Era una poesia di tono satirico e burlesco che diventava anche violento, tanto da indurre al suicidio coloro che ne erano vittima. Le composizioni erano cantate con l’accompagnamento della σαμβυκη. Il giambo, più degli altri metri era quello che si adattava al linguaggio parlato, e ciò motivò l’utilizzo del giambo in commedie e drammi satirici







 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo