Concetti Chiave
- Ungaretti's poetry is deeply autobiographical, reflecting his experiences and views, with an emphasis on the mystical and esoteric aspects of life.
- The poem "In memoria" addresses themes of exile and identity loss, using the memory of a friend to explore these ideas.
- "I fiumi" symbolizes different phases of Ungaretti's life through the imagery of four rivers, highlighting his connection to nature and existential reflection during wartime.
- In "Veglia," Ungaretti illustrates the harsh reality of war, juxtaposing the horror with an instinctual clinging to life and humanity.
- "Sentimento del tempo" presents a shift in perspective from "L’Allegria," focusing on the passage of time and its impact on human fate and spiritual reflection.
Indice
Infanzia e Formazione
Nasce il 18.02.1888 ad Alessandria d’Egitto. Qui inizia ad occuparsi intensamente di letteratura leggendo Leopardi e Nietzsche. Del luogo gli rimarrà impresso il paesaggio fantastico che si ritroverà nei suoi versi.
Esperienze di Guerra
Nel 1912 si reca a Parigi dove ha modo di approfondire la conoscenza della poesia decadente e simbolista (Baudelaire), frequentando gli ambienti di avanguardia. Nel 1914 ha contatto con i principali esponenti del Futurismo fiorentino. In quell’anno si era recato in Italia per partecipare alla guerra come volontario in un reggimento di fanteria. Viene inviato a combattere sul Carso e nel 1916 pubblica Porto sepolto e nel 1919 Allegria di Naufragi, raccolte che poi confluiranno ne L’Allegria.
Adesione al Fascismo
Nel 1921 si trasferisce a Roma dove aderisce al fascismo, convinto che la dittatura possa rafforzare la solidarietà nazionale dalla quale si era sempre sentito escluso. Dal 1919, pubblicate nel ‘33, si ricordano le poesie raccolte in Sentimento del Tempo.
Nel 1936 prende la cattedra di letteratura all’Università di Roma, fino al 1942.
La Seconda guerra mondiale segnano profondamente il poeta di una nuova e dolorosa consapevolezza, preceduta da alcuni lutti quali la morte del fratello (1937) e del figlio (1939); scrive quindi la prima raccolta del dopoguerra, Il dolore (1947).
→ Funzione della poesia: Ungaretti precisa che le sue prime poesie, delle quali il titolo è parte integrante e fondamentale per capirle, hanno carattere strettamente autobiografico, infatti per lui la poesia è come una confessione → concezione ermetica secondo cui letteratura e vita sono connesse tra loro e la letteratura ha un ruolo privilegiato perché svolge la funzione di svelare il senso nascosto delle cose => la poesia ha il compito di illuminare e illustrare l’essenza stessa della vita.
→ Analogia:
in Porto sepolto le liriche hanno un andamento che tende ad escludere le componenti realistiche, attraverso un’estrema riduzione della frase => sintesi della poesia;
Tale sintesi è possibile grazie all’uso di una nuova concezione dell’analogia, va oltre alla simbologia e alle metafore e cerca di mettere a contatto immagini lontane “in un baleno”.
La letteratura dell’800 era troppo analitica, istituendo legami chiari e comprensibili, tuttavia era una conoscenza lenta e faticosa (aspetti superficiali della realtà). La poesia di Ungaretti, invece, è rapida e sintetica e sa mettere in contatto immagini lontane che non esprimono un senso immediato => elimina tutto ciò che è superfluo, eccessivo e ripetitivo. Influenza su ciò il futurismo, con l’avvento delle parole in libertà, e il simbolismo.
→ Poesia come illuminazione: il poeta è un sacerdote della parola che sa cogliere i sensi nascosti delle cose. La poesia ha come un significato magico/esoterico, fino al limite dell’inconoscibile. Il mistero della vita non può essere svelato attraverso il discorso disteso ma solo illuminato a tratti grazie alla parola poetica.
→ Struttura dell’opera e temi: cinque sezioni.
Ultime, fase 1914-15;
Il porto sepolto → si riferisce ad un porto ad Alessandria scomparso dopo la ricostruzione della città, distrutta dalla guerra. Il secondo titolo è stato Allegria di Naufragi, in cui di parla dell’esultanza d’un attimo, cioè della gioia di trovarsi vivi dopo aver “subito un naufragio”;
Naufragi;
Girovago;
Prime.
I temi rendono evidente la componente autobiografica, per così dire trasfigurata, perché ogni evento rappresenta un momento in cui l’uomo incontra la verità e il senso della propria esistenza.
Guerra → momento di transizione, gli consente di stabilire un contatto con la propria gente e di ritrovare la consapevolezza di un’identità. Inoltre, la guerra lo costringe a vivere in un confine precario tra vita e morte.
Leopardi → collegamento con il concetto di infinito.
Poesia dedicata all’amico arabo suicida Moammed Sceab, morto perché non aveva più patria. Egli ha cercato di diventare francese, cambiando nome in Marcel, ma non c’è riuscito, finendo per non essere nemmeno musulmano (perdita delle radici).
→ Tema dell’esilio come perdita di ogni punto di riferimento. È la poesia che ha il compito di sanare, proponendosi come ricerca di un’identità perduta (Ungaretti si è salvato grazie ad essa, a differenza dell’amico).
Il componimento si propone di cogliere l’essenza della poesia e il mistero che l’avvolge, alludendo ad una sorta di rituale purificante di rinascita gioiosa. La poesia è ciò che al poeta resta, e si contrappone con il mistero profondo della vita.
→ Citazione dell’Infinito di Leopardi.
È un canto scritto in piena guerra in trincea, che parla dei quattro fiumi principali che rappresentano la vita di Ungaretti: l’Isonzo, il Serchio, il Nilo e la Senna.
→ Il poeta è tra le doline carsiche, durante la guerra, e si immerge nel fiume Isonzo per lavarsi, riconoscendosi nel tutto dell’Universo (richiami religiosi e al circo). Grazie all’Isonzo, ripensa ai fiumi del suo passato, ognuno associabile ad un momento preciso della sua vita, trovando la felicità solo quando tocca le profonde acque.
→ Serchio: fiume toscano, rappresenta le sue origini e i suoi antenati.
→ Nilo: fiume della sua infanzia ad Alessandria d’Egitto, l’ha visto nascere.
→ Senna: fiume dell’età adulta. La molteplicità delle culture che il poeta ha incontrato in Francia gli ha consentito di vivere molteplici esperienze.
Ungaretti è nostalgico, immerso nella notte che rappresenta la negazione al colore e quindi della vitalità => crisi esistenziale.
Ungaretti è in trincea accanto al cadavere di un amico soldato.
→ Crudezza della situazione che rivela la crudeltà della guerra.
→ Attaccamento alla vita che nasce dall’orrore e dal dolore => istinto naturale e riconquista dei valori umani.
Narra sempre dell’esperienza al fronte.
→ Titolo come grido disperato, come rivendicazione dell’umanità perduta (che però viene negata nei versi) durante la guerra.
→ Analogia fra la sua condizione di uomo impietrito dall’orrore della guerra e la fredda roccia attorno a lui. La guerra è vista come uno spettacolo di morte che priva l’uomo della sua umanità.
→ Il pianto del poeta coincide con la pietra perché la guerra l’ha trasformato in qualcosa di freddo e asciutto.
→ Ultima strofa: riflessione sulla morte, il sollievo di morire si ha solo dopo aver vissuto un grande dolore.
Immagini di desolazione e morte a seguito della guerra, attraverso un parallelismo tra le case distrutte ma ancora visibili e gli amici caduti, persi per sempre, ricordabili solo grazie alla memoria.
→ Linguaggio agevole e piano e parole in simmetria.
Definizione di Poesia
Componimento che serve per dare una definizione di poesia: la poesia racconta, non spiega. È una dedica a un amico.
→ Prima parte: definizione di poesia in generale, come la più appagante e completa dimensione dell’esistenza umana. La parola fa fiorire la poesia.
→ Seconda parte: definizione di poesia di Ungaretti (uso del possessivo) come miracolosa scoperta.
Motivo morale e religioso della vanità delle cose. Due poli:
Indefinito → rappresentato dalla luce del sole che si riflette nell’acqua, simbolo della vita;
Finito → rappresentato dall’uomo e dalla sua ombra che si specchia nell’acqua, la quale in qualche modo la spezza. Sta a raffigurare la fragilità della condizione umana.
→ Il titolo è un elemento essenziale, permette di capire la poesia.
→ Fragilità della vita umana, esattamente come quella di una foglia in autunno.
Rappresenta un viaggio metafisico alla ricerca della felicità.
Il titolo allude alla condizione esistenziale del poeta che non riesce a trovare un luogo sicuro che lo accolga.
→ Prime tre strofe: emerge l’estraneità rispetto alle cose che porta ad una ricerca di una perduta identità.
→ Ultima parte: necessità di godere di un istante breve ma autentico, che ricongiunga l’uomo con le radici più vere e profonde del suo essere.
Mutamento di Prospettiva
In questa raccolta si verifica un mutamento di prospettiva rispetto a quella de L’allegria, infatti qui il tempo viene visto come durata, come causa del mutare di tutte le cose; esso scorre, è recupero, dimensione, estensione.
Ci sono tre momenti del tempo:
Tempo nel paesaggio come profondità storica, quello che si vede guardandosi allo specchio, che passa sul poeta e lo trasforma.
Tempo che induce a meditare sul destino dell’uomo in relazione con l’eterno, ad esempio il susseguirsi delle epoche storiche a Roma.
Tempo come morte; come si può sconfiggere il tempo? Ciò che è eterno si contrappone ad essa, come Dio => Ungaretti scopre la fede, recuperando anche la tradizione poetica.
La composizione risale al soggiorno a Roma del poeta, la quale città è connessa con il tema fondamentale del tempo.
Essa è memoria, per i suoi monumenti antichi, e coglie il tempo come durata (il trascorrere del tempo fa perire tutto).
Opere barocche, che fanno sviluppare la poesia della metamorfosi del tempo, nell’incessante scorrere delle ore e delle stagioni (paesaggio => natura). Parla soprattutto di paesaggio d’estate che racchiude la secchezza e la morte (“stagione del barocco”).
Religione e Tempo
Religione: la vita, processo di creazione e distruzione, genera nell’uomo una drammatica condizione di divisione tra la creazione divina e la precarietà della propria condizione.
Riferimento all’antichità romana, in particolare alle divinità come CRONO → simbolo del tempo.
→ Novità sul piano tecnico: recupero delle strutture sintattiche e delle forme metriche tradizionali, attraverso la lettura di Petrarca e Leopardi, vicini anche per la riflessione su tempo.
Leopardi: sente la fine di una civiltà giunta alla fine della sua evoluzione.
Petrarca: cerca di ripristinare, attraverso la memoria dell’antico, il mondo classico.
Viaggio e Isolamento
Tra i temi principali ci sono quelli del viaggio e della nave.
Descrizione di un’isola irreale, senza collocazione geografica, svincolata da ogni spazio rintracciabile. In realtà Ungaretti dichiara che è il paesaggio di Tivoli, e “isola” perché è il luogo dove egli si isola, dove è solo, separato dal resto del mondo col suo stato d’animo => crea un’atmosfera rarefatta.
→ I protagonisti sono il pastore e il poeta, immersi in un paesaggio fisso, chiaro richiamo alla poesia classica. Il pastore non ha identità e si muove in un mondo irreale e fantastico [con il Porto sepolto rinasce una necessità di creazione mitica, non più autobiografia].
→ Il gioco delle analogie è possibile grazie all’attento uso delle parole e del loro significato.
→ Il poeta riesce a rappresentare la multiforme complessità di un’esistenza in cui il sentimento del tempo si confronta con la dimensione dell’eternità.
→ Viene espresso il dramma intimo e sofferto di una madre che aspetta il figlio alle soglie dell’eternità per vederlo redento con la sua preghiera.
→ Madre: umile e forte, è emblema di un amore che va oltre alla morte, e si sublima in sentimento religioso. Diviene, nella visione di Ungaretti, un simbolo di eterna pietà materna, che conduce per mano il figlio morto davanti al Signore, per fargli ottenere l’assoluzione, invocando il perdono. È solo quando Dio glielo avrà accordato che guarderà in volto il proprio figlio.
Come una volta: come al tempo dell’infanzia del poeta.
Decisa: risoluta nel chiedere il perdono di Dio per il figlio.
Sarai una statua: rimarrà immobile come una statua ad attendere il giudizio celeste.
Come già ti vedevo: nello stesso atteggiamento che il poeta assume in vita quando si raccoglieva in preghiera.
Mio Dio, eccomi: l’ansia che la madre prova per la salvezza del figlio è la stessa da lei provata per la propria salvezza, in punto di morte, secondo quella capacità delle madri di immedesimarsi nella sorte dei loro figli.
Un rapido sospiro: un sospiro che indica la fine dell’ansiosa attesa e il sollievo di sapere salvo purificato il figlio, ricongiunto a lei per sempre.
→ Tragedia contemporaneamente personale e storica infatti, all’inizio, il titolo della raccolta doveva essere un titolo al plurale.
Per quanto riguarda il personale, Ungaretti scrive: so che cosa significa la morte, lo sapevo anche prima; ma allora, quando mi è stata strappata la parte migliore di me, la sperimento in me, da quel momento, la morte. Il DOLORE è il libro che amo di più, il libro che ho scritto negli anni orribili, stretto alla gola. Se ne parlassi mi sembrerebbe di esse impudico. Quel dolore non finirà più di straziarmi. Si riferisce alla morte del figlio, a cui è dedicata la lunga poesia Giorno per giorno, ove descrive il dolore che giorno per giorno non passa mai. Ungaretti sentirà sempre la mancanza di questa presenza anche se la sentirà comunque vicina. Il dolore è come uno strappo di una parte di se stessi.
La parte di tragedia storica, invece, riguarda lo scoppio della Seconda guerra mondiale, in cui vediamo un Ungaretti spettatore e non partecipante. Per il poeta, lo scoppio di tale guerra è la dimostrazione che gli uomini non hanno imparato niente dalle guerre precedenti. Questo evento rappresenta una grande delusione per lui, rispetto agli avvenimenti della Prima guerra mondiale. Inoltre, per superare tutte le atrocità e le violenze che ha vissuto durante quel periodo, non ha fatto in tempo ad accorgersi del fatto che ne è scoppiata un’altra, di guerra.
→ Pubblicata nel 1947. La raccolta è l’esternazione di Ungaretti del suo dolore personale causato dalla perdita del figlio e del fratello - quindi legata alla sfera familiare - e causato dalla guerra - collettivo.
Questo è il libro più vicino al Canzoniere di Petrarca → risoluzione in una sorta di diario poetico.
- Morte dei cari: l’assenza della persona fisica è compensata da segni a cui si attribuisce la possibilità di proseguire un colloquio, che nonostante lo strazio, si vuole mantenere vivo. Ungaretti trasfigura il figlio in una speranza religiosa, e diviene così simbolo di innocenza.
- Guerra: le immagini della guerra danno l’idea di uno “sconvolgimento” dove le tragedie individuali si proiettano in quella dell’intera nazione, mostrando una “richiesta” di solidarietà a cui affidare le sorti di una intera nazione.
→ Poesia scritta alla fine della guerra, Ungaretti chiede di non “uccidere più i morti” perché le grida, il rumore della guerra, hanno rischiato di non far sentire più la loro voce, il loro messaggio, quei sussurri che riescono a crescere soltanto dove non passa l’uomo, dove può crescere l’erba.
→ Ungaretti si rende conto che la guerra in generale consiste nell’uccidere ancora una volta i morti. La storia, a tal proposito, non ci ha insegnato niente, il sacrificio dei morti non è servito a niente, la loro voce non viene ascoltata. Ciò succede ogni volta che non si prende esempio dalle vicende passate per imparare qualcosa per il futuro. Tutto ciò che è accaduto non viene visto come modello e i sacrifici precedenti di altri uomini non sono serviti a niente. La storia non viene vista più come magistra vitae.
→ Grida: modo per non ascoltare le voci dei morti, che sono flebili, quasi mute, voci che senza il silenzio non si sentono.
→ È la prima poesia del dolore. Il poeta afferma di aver perso tutto, di aver perso la sua infanzia e tutto quello che c’era di bello in essa, gli è rimasto solo il ricordo delle cose brutte.
→ Smemorarsi: i bambini non hanno memoria, hanno solo il futuro davanti, non hanno alcuna preoccupazione e possono gridare la loro gioia. Il poeta ha perso questa ingenuità, sono successe tante cose che lo hanno allontanato da ciò.
→ Infanzia: stagione mitica, dove non si conosce il dolore della vita e si può andare avanti con questa ingenuità, che trova la sua manifestazione più alta in un grido di un bambino. Il poeta ha vissuto troppi drammi, è come se una spada invisibile l’avesse separato per sempre dalla sua infanzia, dal suo passato.
→ Allusione al fratello, anche lui perduto => gioia nell’amore del fratello, ora ha perso anche questo legame.
→ La vita per il poeta è solo una disperazione continua, è rimasta solo una “roccia di gridi” arrestati in fondo alla gola → impossibilità di gridare.
Domande da interrogazione
- Quali sono stati gli eventi chiave dell'infanzia e della formazione di Ungaretti?
- Come ha influenzato la guerra la poesia di Ungaretti?
- Qual è stata la visione di Ungaretti sulla poesia e la sua funzione?
- In che modo la religione e il tempo influenzano le opere di Ungaretti?
- Quali sono i temi principali nelle poesie di Ungaretti legati al viaggio e all'isolamento?
Ungaretti è nato ad Alessandria d'Egitto nel 1888, dove ha iniziato a interessarsi alla letteratura leggendo autori come Leopardi e Nietzsche. Il paesaggio di Alessandria ha influenzato i suoi versi.
La guerra ha avuto un impatto significativo su Ungaretti, che ha partecipato come volontario. Ha pubblicato raccolte come "Porto sepolto" e "Allegria di Naufragi", che riflettono la sua esperienza al fronte e la consapevolezza della precarietà tra vita e morte.
Ungaretti vedeva la poesia come una confessione autobiografica e un mezzo per svelare il senso nascosto delle cose. La poesia, per lui, illuminava l'essenza della vita, andando oltre la simbologia e le metafore tradizionali.
Ungaretti esplora il tempo come durata e trasformazione, collegandolo alla fede e alla tradizione poetica. La religione emerge come un tema centrale, con la vita vista come un processo di creazione e distruzione, in relazione con l'eterno.
I temi del viaggio e dell'isolamento sono centrali nelle poesie di Ungaretti, che descrivono un'isola irreale come simbolo di separazione dal mondo. La poesia diventa un mezzo per esplorare l'identità perduta e la ricerca di un luogo sicuro.

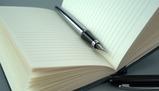





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo