Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
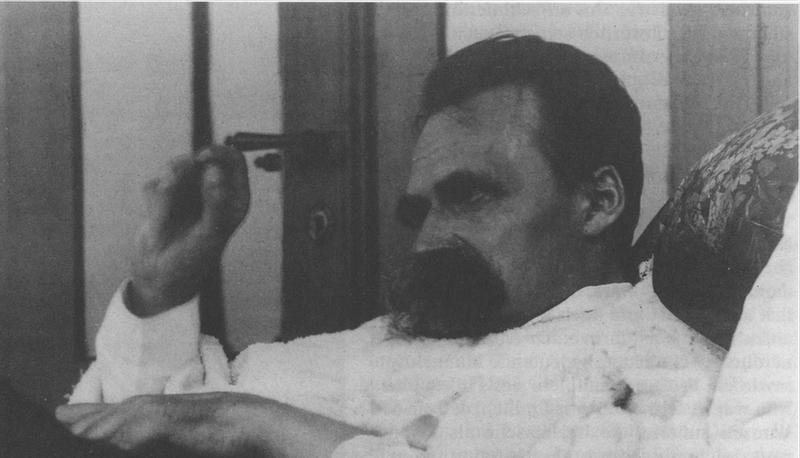
perdutamente del figliastro Ippolito, che però sdegna ogni compagnia
femminile ed è dedito esclusivamente alla caccia. Particolarmente importante
è sottolineare il momento della "dichiarazione" di Fedra a Ippolito. Si tratta
sicuramente di una scena culminante, dove la regina, disperatamente e
colpevolmente innamorata del figliastro, si decide a rivelargli la
sua passione. L'amore incestuoso ha travolto ogni limite: è il conflitto
inconciliabile tra ragione e passione, l'insanabile lacerazione interiore di chi è
furor
preda del e ha perso il controllo di sé e delle proprie azioni. Il
progressivo avvicinamento alla "dichiarazione" vera e propria è sapientemente
preparato attraverso una serie dì passaggi intermedi:
l) Fedra respinge l'appellativo di madre che Ippolito le rivolge;
2) Fedra gli si offre come schiava evocando implicitamente il tema del
servitium
amoris;
3) Fedra accenna alla probabile morte di Teséo, suo marito (morte che le
permetterebbe
di aspirare legittimamente ad un nuovo amore).
Quando il giovane afferma di essere disposto a prendere il posto dei padre,
questa pìetas)
affermazione (dettata dalla suona ambigua alle orecchie di Fedra e
induce
finalmente la regina a rivelare che la sua sofferenza è causata dall'amore. La
confessione è poi ancora ritardata dalla rievocazione della bellezza dì Teseo
giovane,
nella cui immagine Fedra proietta e contempla quella del figlio. Una volta
comprese le NUTRICE
intenzioni di Fedra, Ippolito esprime il suo orrore e la sua violenta
indignazione. Non c'è nessuna speranza di alleviare un
Respinta, Fedra si vendica accusando ìl giovane di aver cercato dì usarle
male così e non ci sarà mai fine per questa
violenza; ma follia.
La consuma una fiamma silenziosa, ma, per
quando, in seguito alla maledizione di Teseo che ha creduto alla clunnia, un
quanto nascosto, il suo ardore si tradisce nel
mostro volto;
marino suscitato dal dio del mare causa ad Ippolito un'orribile morte, Fedra,
sprizzano scintille dagli occhi, le palpebre
rifiutano
disperata, la luce; non sa quello che vuole, le sue
confessa la sua colpa e si uccide. Il suicidio si presenta come giusta punizione
membra, in preda a un dolore smanioso, si
della sua agitano in moti incoerenti. Ora si piega sulle
gambe, come in un collasso mortale, e
colpa e offerta sacrificale al morto lppolito, ma anche come unico sollievo
abbandona il capo ciondolante sul collo; ora
all'invincibile malattia d'amore ed estrema occasione per recuperare l'onore
torna a riposare, ma ha dimenticato
perduto. il sonno e trascorre la notte in lamenti: si fa
sollevare e poi di nuovo coricare, sciogliere i
Fedra è un'eroina consapevole, che si consegna ad una nobile fine,
capelli e poi di nuovo pettinarli: insofferente
accettando la di se stessa passa da uno stato d'animo
responsabilità dell'adulterio e la propria folle passione.
all'altro.
Non le importa più di nutrirsi, di vivere;
É il contrasto tra fedeltà ai principi etici e la forza della passione a consumare
cammina con passo vacillante, senza più
Fedra e portarla al delirio. A questo punto della tragedia si trovano i versi
forze; ha perduto il vigore di prima e il
riportati. colorito che le imporporate le guance; la
passione devasta le sue membra,
le gambe le tremolano, se n'è andata la
tenera bellezza di quello splendido corpo. E
gli occhi, che avevano il riflesso del sole, non
hanno più una scintilla di quel fuoco
ancestrale. Le lacrime rigano il volto e un
NUTRIX pianto continuo irrora le guance,
come le nevi perenni del Tauro si fondono
sotto una tiepida pioggia.
Ma ecco, si spalancano le porte della reggia,
è lei:
reclinata sul letto della camera dorata,
[360] Spes nulla tantum posse leniri malum,
finisque flammis nullus insanis erit.
Torretur aestu tacito et inclusus quoque,
quamvis tegatur, proditur vultu furor;
erumpit oculis ignis et lassae genae
[365] lucem recusant; nil idem dubiae placet,
artusque varie iactat incertus dolor.
Nunc ut soluto labitur marcens gradu
et vix labante sustinet collo caput,
nunc se quieti reddit et, somni immemor,
[370] noctem querelis ducit; attolli iubet
iterumque poni corpus et solvi comas
rursusque fingi: semper impatiens sui
mutatur habitus. Nulla iam Cereris subit
cura aut salutis; vadit incerto pede,
[375] iam viribus defecta: non idem vigor,
non ora tinguens nitida purpureus rubor;
populatur artus cura, iam gressus tremunt,
tenerque nitidi corporis cecidit decor.
Et qui ferebant signa Phoebeae facis
[380] oculi nihil gentile nec patrium micant.
Lacrimae cadunt per ora et assiduo genae
rore irrigantur, qualiter Tauri iugis
tepido madescunt imbre percussae nives.
Sed en, patescunt regiae fastigia:
[385] reclinis ipsa sedis auratae toro
solitos amictus mente non sana abnuit.
Phaedra,
da Seneca, (50-62 d.C.) vv. 360-386
COMMENTO
La descrizione della follia in cui cade Fedra è affidata alla nutrice, che sulla
furor
scena narra il delirio della padrona. Le caratteristiche del di Fedra sono
riconoscibili quasi in ogni verso del testo riportato: il trasparire dell'agitazione
dagli occhi (v.364), la gestualità scomposta (v.366), gli improvvisi mancamenti
(v.367), il passo malfermo (v.375), il colorito terreo (vv.376-77), lo sfiorire della
bellezza (v.379), lo sguardo spento (v.380-81), sono tipici segnali esteriori
della pazzia, che Seneca riprende dalla tradizione stoica. Insieme a questi, che
furor,
sono i sintomi fisici del il testo presenta con precisione anche gli stati
d'animo che li accompagnano: la metafora della fiamma segreta e silenziosa
che divora l'animo (v.362-63), la volontà divisa tra desideri opposti e
contraddittori (v.365, 370-72), l'insofferenza smaniosa (v.372), l'inedia (374), il
pianto ininterrotto (v.382) configurano la tipica descrizione della follia, che si
articola attorno all'alternarsi di
uno stato febbrile, sovreccitato, smanioso, con un secondo stato catatonico,
spento, inerte. Con questa reazione estrema e autodistruttiva, Fedra sfugge da
una realtà che non le dà pace: da un lato la passione d'amore proibita,
dall'altro il tentativo di tenere fede ai principi della morale configurano una
Es Super-Io:
conflittualità che anticipa quella freudiana tra e la follia che ne
consegue è il tentativo impossibile di
sottrarsi agli imperativi contraddittori che le due opposte istanze impongono
all’animo.
Freud scoprirà invece che le cause di follia e nevrosi sono da ricercarsi tra
forze psichiche in contrasto tra loro, che operano al di là della sfera di
consapevolezza del soggetto e non hanno una sede anatomica.
Freud dedusse che la differenza tra il malato e il sano è un fatto di quantità di
istinti, il sano riesce a mantenere l’equlibrio fra Es, Super Io ed Io.
Sostenendo egli infatti che la psiche umana è divisa in tre parti: l’Es che
raccoglie tutto un insieme di pulsioni o istinti che fanno capo a quella che
Freud chiamerà libido, il Super Io che rappresenta l’insieme delle proibizioni e
delle regole trasmesse dalla società per mezzo soprattutto della famiglia
infine, l’Io che è il centro dell’attività psichica e ha la funzione di ordinare e
mettere un equilibrio tra le esigenze dell’ Es e quelle del Super Io.
LA FOLLIA DALLA TRADIZIONE GRECA ALL'OPERA DI SENECA
A differenza dell'originale greco, la versione di Seneca, come già evidenzia il
titolo, è incentrata sulla protagonista femminile che da subito rivela la propria
passione, pronta a morire piuttosto di rinunciare al giovane. É una donna
tragicamente umana che segue un proprio istinto naturale, non più un essere
determinato dalla volontà degli dei, che,
nella versione di Seneca, scompaiono.
La contrapposizione tra umano e divino, che era centrale nel pensiero
euripideo, si trasforma, nella poesia del filosofo latino, in una profonda
riflessione sulla lotta tra passione e ragione, fragilità e fierezza, che porta ad
una estrema lacerazione della volontà.
Seneca opera dunque un significativo cambiamento rispetto ai tragici greci: il
contrasto non è più esterno al personaggio (l'uomo contro il fato) ma interno
furor mens sana).
(è il contro la Il furor viene umanizzato e sconsacrato: è
nefas, dolor, non più υβρις.
La tragedia di Seneca esamina a fondo i lati oscuri dell'anima con una
profondità psicologica nuova per il mondo antico.
Germania
L’opera la di Tacito sembra percorsa da una vena di implicita
contrapposizione dei barbari, ricchi di energie ancora sane e fresche, ai
Romani. Insistendo sulla indomita forza e sul valore
guerrirero dei germani , più che tesserne un elogio Tacito ha probabilmente
inteso sottolineare la loro pericolosità per l’impero, poiché il sistema politico
romano era basato sul servilismo e sulla corruzione. Nella
Germania Tacito sottolinea la contrapposizione tra i due popoli, quello
romano e quello barbaro dei germani, in ogni ambito: dalla gestione delle
risorse economiche all’organizzazione sociale, dalle abitudini guerriere allo
svago e al divertimento. Il contrasto polemico risulta
particolarmente evidente quando Tacito affronta l’organizzazione della
famiglia e soprattutto il tema della fedeltà coniugale.
ONESTA’ DELLE DONNE GERMANICHE
[18,1] Quamquam severa illic matrimonia, nec ullam morum partem magis laudaveris. Nam
prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt, exceptis admodum paucis, qui non
libidine, sed ob nobilitatem plurimis nuptiis ambiuntur. Dotem non uxor marito, sed uxori
maritus offert. Intersunt parentes et propinqui ac munera probant, munera non ad delicias
muliebres quaesita nec quibus nova nupta comatur, sed boves et frenatum equum et scutum
cum framea gladioque. In haec munera uxor accipitur, atque in vicem ipsa armorum aliquid
viro adfert: hoc maximum vinculum, haec arcana sacra, hos coniugales deos arbitrantur. Ne se
mulier extra virtutum cogitationes extraque bellorum casus putet, ipsis incipientis matrimonii
auspiciis admonetur venire se laborum periculorumque sociam, idem in pace, idem in proelio
passuram ausuramque. Hoc iuncti boves, hoc paratus equus, hoc data arma denuntiant. Sic
vivendum, sic pereundum: accipere se, quae liberis inviolata ac digna reddat, quae nurus
accipiant, rursusque ad nepotes referantur. Germania 18-20
LA CORRUZIONE DI PONZIA, NOBILE ROMANA
Per idem tempus Octavius Sagitta plebei tribunus, Pontiae mulieris nuptae amore vaecors,
ingentibus donis adulterium et mox, ut omitteret maritum, emercatur, suum matrimonium
promittens ac nuptias eius pactus. sed ubi mulier vacua fuit, nectere moras, adversam patris
voluntatem causari repertaque spe ditioris coniugis promissa exuere. Octavius contra modo
conqueri, modo minitari, famam perditam, pecuniam exhaustam obtestans, denique salutem,
quae sola reliqua esset, arbitrio eius permittens. ac postquam spernebatur, noctem unam ad
solacium poscit, qua delenitus modum in posterum adhiberet. statuitur nox, et Pontia consciae
ancillae custodiam cubiculi mandat. ille uno cum liberto ferrum veste occultum infert. tum, ut
adsolet in amore et ira, iurgia preces, exprobratio satisfactio, et pars tenebrarum libidini
seposita; ea quasi incensus nihil metuentem ferro transverberat et adcurrentem ancillam
vulnere absterret cubiculoque prorumpit. postera die manifesta caedes, haud ambiguus
percussor; quippe mansitasse una convincebatur. sed libertus suum illud facinus profiteri, se
patroni iniurias ultum esse. commoveratque quosdam magnitudine exempli, donec ancilla ex
vulnere refecta verum aperuit. postulatusque apud consules a patre interfectae, postquam
tribunatu abierat, sententia patrum et lege de sicariis
condemnatur.
NIETZSCHE Annales 13-44
Dobbiamo, di tanto in tanto, riposarci dal peso di noi stessi, volgendo lo
sguardo là in basso su di noi, ridendo e piangendo su noi stessi da una
distanza di artisti: dobbiamo scoprire l'eroe e anche il giullare che si cela
nella nostra passione della conoscenza, dobbiamo, qualche volta, rallegrarci
della nostra follia per poter stare contenti della nostra saggezza." (Gaia
scienza 322)
Per Nietzsche l'uomo dovrebbe più spesso volgere lo sguardo a se stesso con
occhio distaccato, da artista, riscoprire l'eroe ed il giullare celato in ogni








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









