Concetti Chiave
- I comuni italiani dell'XI secolo si ispirano alla democrazia greca, ottenendo autonomia da Papato e Impero attraverso coniurationes, associazioni di cittadini.
- Il XIII secolo vede l'emergere del ceto produttivo che guida la rivolta per un ruolo nel governo, con mercanti e corporazioni al centro di questo movimento.
- Si sviluppa un sistema politico diversificato con assemblee cittadine, consigli e cariche elettive, introducendo figure come il potestà per garantire imparzialità.
- La legittimità del potere deriva dal consenso dei cittadini, come dimostrato dal "Liber paradisus" di Bologna nel 1257, che paragona la schiavitù a un germe sociale.
- Nonostante l'enfasi su libertà ed eguaglianza, la partecipazione politica è limitata a gruppi organizzati, escludendo i lavoratori non qualificati dalle decisioni politiche.
L'origine dei comuni italiani
L’antico spirito della democrazia greca si ritrova nei comuni italiani, piccole realtà cittadine che si formano
sul finire dell’XI secolo conquistando l’autonomia dal Papato e dall’Impero. Il loro nucleo iniziale è costituito
da piccoli associazioni, le coniurationes, di cittadini che si associano mediante un giuramento che li pone in
una società autonoma contrapposta al potere feudale. Prima di queste associazioni il monopolio del potere
era esercitato dai nobili e dai cavalieri, ma all’inizio del XIII secolo, principalmente nell’Italia centro-
settentrionale), il popolo inizia un movimento di ribellione rivendicando un ruolo nel governo, ma a farlo è
comunque il ceto produttivo della società ( mercanti, esponenti delle Arti o delle Corporazioni, funzionari
nell’ambito giuridico), che stava emergendo portando anche un incremento demografico e di inurbamento.
Il sistema politico dei comuni
Inizia una vivace attività civica: il popolo viene riunito in assemblee che prendono decisioni come la nomina
di magistrati o il conflitto con altre città. Si sviluppa un sistema di diversificazione politica grazie a diverse
cariche ed istituzioni, tra gli istituti collegiali più importanti vi sono i consigli degli anziani, del popolo,
l’arengo (assemblee cittadine), le rappresentanze delle Arti e dei mestieri. Le cariche pubbliche di vertice
sono elettive e dalla breve durata. Inizialmente i comuni vengono governati da consoli, ma successivamente
si sviluppa la figura del potestà, autorità politica che proviene dall’esterno della città, in grado dunque di
essere imparziale e non farsi condizionare dalle lotte di fazione. Si sviluppa l’idea che sia il governo a dover
essere al servizio dei cittadini e l’operato del potestà viene controllato sia durante a sua carica annuale, sia
alla fine del mandato, dove invece di ricevere l’ultima rata dell’onorario viene sottoposto al controllo da
una commissione di cittadini apposita.
Libertà e contraddizioni
Per quanto colma di contraddizioni la vita politica generale è dominata dal principio di libertà e aequalitas,
in cui gioca un ruolo chiave l’elezione del governo, invece della sua successione. La legittimità del potere
deve derivare dal consenso che ad esso danno i cittadini liberi ed uguali. La città di Bologna sancirà nel 1257
tramite il “Liber paradisus” la liberazione di tutti i servi e schiavi del contado che vengono riscattato
attingendo alle finanze comunali; nel documento la schiavitù viene paragonata ad un germe capace di
contaminare l’intera città, inoltre si sostiene che la libertà sia un diritto degli uomini poiché la natura li ha
generati liberi e Dio stesso ha mandato il figlio sulla terra per trasmettere questo messaggio (Rousseau dirà
che l’uomo nasce libero, ma è comunque condannato a vivere in catene). Questo documento sancisce una
libertà sia economica che politica; la libertà comunale ha come peculiarità il voler rendere tutti i cittadini
eguali, ma nonostante questo non garantisce la partecipazione politica per tutti, poiché essa è decretata
con l’articolazione della cittadinanza in gruppi e corpi intermedi, che la canalizzano ed organizzano
neutralizzando così il ruolo politico dei lavoratori non qualificati che non possono pertanto far parte di
alcuna corporazione.
Domande da interrogazione
- Qual è l'origine dei comuni italiani e come si sono sviluppati?
- Quali erano le principali istituzioni politiche nei comuni italiani?
- Come veniva garantita la legittimità del potere nei comuni italiani?
- Quali erano le limitazioni alla partecipazione politica nei comuni italiani?
I comuni italiani si sono formati alla fine dell'XI secolo, conquistando l'autonomia dal Papato e dall'Impero. Inizialmente, erano costituiti da coniurationes, associazioni di cittadini che si opponevano al potere feudale. Nel XIII secolo, il popolo, principalmente il ceto produttivo, iniziò a rivendicare un ruolo nel governo, portando a una vivace attività civica e alla creazione di istituzioni politiche diversificate.
Nei comuni italiani, le principali istituzioni politiche includevano i consigli degli anziani, del popolo, l'arengo, e le rappresentanze delle Arti e dei mestieri. Le cariche pubbliche erano elettive e di breve durata. Inizialmente governati da consoli, i comuni successivamente adottarono la figura del potestà, un'autorità politica esterna e imparziale.
La legittimità del potere nei comuni italiani derivava dal consenso dei cittadini liberi ed uguali. Il principio di libertà e aequalitas dominava la vita politica, con l'elezione del governo al posto della successione. Il "Liber paradisus" di Bologna del 1257 sancì la liberazione dei servi e schiavi, promuovendo la libertà come diritto naturale.
Nonostante l'enfasi sulla libertà e l'uguaglianza, la partecipazione politica nei comuni italiani non era garantita a tutti. La cittadinanza era articolata in gruppi e corpi intermedi, che organizzavano e canalizzavano la partecipazione, escludendo i lavoratori non qualificati che non potevano far parte di alcuna corporazione.

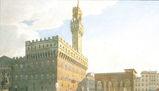





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo