Concetti Chiave
- Il blocco sociale protezionista emerse con Crispi, sostenuto da borghesia industriale e grandi proprietari fondiari, favorendo uno stato forte e autoritario.
- La politica estera di Crispi, orientata verso la Germania e la conquista coloniale, culminò in disastri in Abissinia e una crisi politica ed economica.
- La svolta liberale del 1900 con Giolitti promosse riforme sociali e sviluppo economico, conciliando interessi di borghesia e proletariato.
- La politica di Giolitti accentuò le disparità nord-sud, favorendo l'industria settentrionale e trascurando il Mezzogiorno, spingendo all'emigrazione.
- Le elezioni del 1913 segnarono la fine dell'egemonia giolittiana, con un blocco clerico-moderato che portò a una svolta autoritaria, preludio alla prima guerra mondiale.
Indice
Blocco sociale e politica di Crispi
• Intorno alla scelta protezionistica si era formato un nuovo blocco sociale, nel quale confluirono la borghesia industriale e i grandi proprietari fondiari del nord e del sud. La nuova classe dirigente voleva uno stato forte, regolatore del mercato interno e dei conflitti sociali e promotore di nuove opportunità sul mercato mondiale. Crispi fu il portavoce di questi interessi, avviando una politica interna autoritaria che puntava alla repressione di ogni opposizione sociale. L’ingresso dei cattolici nella vita politica e sociale del paese era ormai un processo avviato. La crescita e la presa di coscienza politica del movimento cattolico vennero incentivate dall’enciclica RERUM NOVARUM di Leone XIII.
Politica estera e crisi di Crispi
• La politica estera di Crispi si basò sull’intensificazione dei rapporti con la Germania e sulla ripresa della conquista coloniale in Abissinia, che si risolse però in gravi disastri militari che fecero perdere la leadership a Crispi. 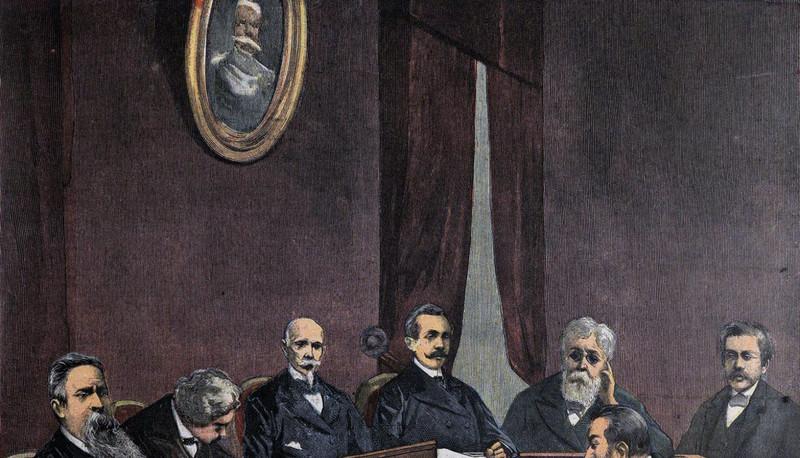 Si aprì una grave crisi politica accentuata dalla crisi economica e finanziaria di cui fecero le spese soprattutto le banche.
Si aprì una grave crisi politica accentuata dalla crisi economica e finanziaria di cui fecero le spese soprattutto le banche.
Svolta liberale e riformismo sociale
• Le elezioni del 1900 segnarono la sconfitta del fronte autoritario e aprirono la via a una svolta liberale. Una stagione di moderato riformismo sociale venne inaugurata da Zanardelli e proseguita da Giolitti, la cui strategia politica mirava a conciliare gli interessi della borghesia e del proletariato. Il “compromesso” giolittiano fu reso possibile anche da una congiuntura economica favorevole, nella quale maturarono il decollo industriale e la modernizzazione della società italiana. I settori chiave dello sviluppo economico furono la meccanica, la siderurgia e la chimica. Crebbe considerevolmente la massa del proletariato industriale, mentre s’ingrandivano gli agglomerati urbani per il massiccio afflusso di manodopera in città.
Differenze nord-sud e impresa di Libia
• La politica giolittiana accentuò le differenze tra nord e sud. Infatti il riformismo si rivolgeva per lo più ai lavoratori settentrionali mentre il Mezzogiorno rimaneva ai margini di questo disegno politico e fu di fatto lasciato nella sua arretrata struttura agraria. La miseria diffusa alimentò un imponente fenomeno di emigrazione. Giolitti si riavvicinò a Francia e Gran Bretagna e diede avvio all’impresa di Libia, che si concluse con l’annessione della colonia africana e con l’occupazione di Rodi e del Dodecaneso. La campagna di Libia ebbe effetti destabilizzanti nel quadro politico perché provocò fratture all’interno del partito socialista, facendo venir meno la leadership di Turati, principale interlocutore di Giolitti. L’egemonia giolittiana era anche minacciata dall’ascesa delle forze popolari, favorita dalla riforma elettorale del 1912 che sanciva il suffragio universale maschile.
Tramonto dell'egemonia giolittiana
• Le elezioni del 1913 segnarono il definitivo tramonto dell’egemonia giolittiana. I cattolici conservatori votarono a favore dei candidati liberali per contrastare l’avanzata socialista, dando vita a un blocco clerico-moderato che impose una svolta autoritaria e conservatrice. Le forze popolari non furono in grado di esprimere una maggioranza politica alternativa; Giolitti si dimise nel 1914 e non fu più in grado di riprendere in mano la situazione, che si evolveva in senso più reazionario verso la prima guerra mondiale.
Domande da interrogazione
- Quali furono le principali caratteristiche della politica interna di Crispi?
- Come si sviluppò la politica estera di Crispi e quali furono le sue conseguenze?
- In che modo la politica di Giolitti cercò di conciliare gli interessi della borghesia e del proletariato?
- Quali furono le conseguenze della campagna di Libia sulla politica italiana?
Crispi adottò una politica interna autoritaria, mirata alla repressione delle opposizioni sociali, sostenendo un blocco sociale formato da borghesia industriale e grandi proprietari fondiari.
La politica estera di Crispi si concentrò sull'intensificazione dei rapporti con la Germania e sulla conquista coloniale in Abissinia, che portò a disastri militari e alla sua perdita di leadership.
Giolitti promosse un moderato riformismo sociale, favorito da una congiuntura economica positiva, che mirava a conciliare gli interessi della borghesia e del proletariato, sostenendo lo sviluppo industriale e la modernizzazione.
La campagna di Libia destabilizzò il quadro politico, provocando fratture nel partito socialista e minacciando l'egemonia giolittiana, mentre la riforma elettorale del 1912 favorì l'ascesa delle forze popolari.






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo