Concetti Chiave
- Nel XVI secolo, le corti italiane vedevano i cortigiani come figure chiave, consiglieri e esecutori delle decisioni dei principi.
- Baldassar Castiglione scrisse "Il Cortigiano", un manuale che delineava le qualità e le competenze essenziali per essere un buon cortigiano.
- Il cortigiano ideale doveva possedere una formazione poliedrica: lettere classiche, armi, giochi, danza, musica, e arti visive.
- Castiglione sottolineava l'importanza del contegno e dell'eloquio, elementi cruciali per influenzare positivamente i principi.
- La cortigianeria assunse una dimensione pedagogico-politica, con il cortigiano come modello di virtù e cultura per il principe.
Indice
Il passaggio del potere
Nel 1500, con raffermarsi delle signorie e dei principati si trasformarono gli ideali civili poiché la sovranità era passata dalle mani dei liberi cittadini a quelle dei singoli signori.
All’inizio del secolo XVI Roma dominava su tutte le altre città per la sua grandiosità, ma in Italia le corti erano tante e tutte avevano qualcosa di particolare. A Venezia vigeva un’economia prospera, ben rappresentata dalle opere architettoniche che abbellivano la città (nel 1559 fu fatta costruire la grande scalinata del Palazzo Ducale); alla corte di Mantova regnavano i Gonzaga che dal 1525 al ’35 fecero costruire il Palazzo del Tè, progettato da Giulio Romano; a Urbino si era insediata la corte dei Montefeltro; a Ferrara, presso la sfarzosa corte degli Estensi, viveva Ludovico Ariosto.
Il ruolo dei cortigiani
Nei secoli XV e XVI nell’ambito delle tante corti che si erano create nell’Italia centrale e settentrionale, il compito di consigliare i singoli principi e di attuare le loro decisioni non era affidato a funzionari di governo o a una gerarchia ma a un gruppo ristretto di persone privilegiate, che gravitavano attorno ai signori e che assolvevano a compiti di vario genere. Erano i cortigiani. Poiché tutte le iniziative importanti delle società del tempo ricevevano impulso dalle corti, i cortigiani assunsero un ruolo determinante.
Il manuale del cortigiano
Il Cortigiano, il trattato in forma di dialogo scritto da Baldassar Castiglione, è un manuale per imparare a condurre bene la vita di corte. Per essere un buon cortigiano, Castiglione considerava essenziale poter disporre di alcune doti naturali individuali come essere di nobile famiglia perché la nobiltà di nascita infiamma alla virtù, rende coraggiosi nelle trattative dirette con altri nobili e rende immuni dall’invidia popolare. Ma tutto il resto, secondo Castiglione, poteva e doveva essere appreso.
Le qualità del cortigiano
Come formazione di base il cortigiano doveva imparare a conoscere le lettere latine e greche e l’uso delle armi, ma non doveva essere né letterato né soldato di professione; doveva imparare a essere coraggioso ma non vantarsi dei suoi meriti: doveva imparare a essere esperto in ogni tipo di giochi ed esercizi come l’equitazione, caccia, nuoto, salto, scherma, scacchi, ciascuno dei quali, possiede un forte valore formativo; doveva imparare a danzare con eleganza e sobrietà. Il cortigiano ideale doveva apprendere tutte queste attività ma solo per saperle mettere in pratica all’occorrenza; nessuna doveva rappresentare una professione.
L'arte della conversazione
Il cortigiano doveva imparare a compiere tutti i gesti utili a corte, con abilità ma con un certo moderato distacco. Doveva imparare a condurre la conversazione senza eccedere; imparare a essere spiritoso contenendosi entro i giusti limiti adattando la prontezza di spirito e il tipo di battute all’ambiente nel quale si trovava.
Doveva imparare la musica in modo da saper apprezzare quella eseguita da altri ma saperla eseguire anche personalmente, in quanto suonare è il passatempo migliore dopo il lavoro. Doveva imparare il latino e il greco perché molti documenti erano scritti in quelle lingue, ma doveva imparare anche l’uso corretto del volgare, arricchito con parole provenienti dalle varie zone d’Italia.
L'educazione artistica
Doveva imparare anche i fondamenti della pittura, della scultura e del disegno in modo che facessero parte del suo patrimonio culturale. Secondo Castiglione, infatti, queste arti affinavano il gusto e rendevano possibile una più profonda comprensione dell’armonia del creato. In più, la pittura e il disegno avevano anche una funzione pratica in quanto permettevano, all’occorrenza, di tracciare schizzi topo-grafici, rilievi di fortificazioni, disegni di luoghi.
La missione del cortigiano
La cultura, l’eloquio, la finezza di spirito consentivano al cortigiano di aiutare il principe a operare bene. E se il signore si mostrava sordo ai consigli del cortigiano, quest’ultimo poteva abbandonarlo, la cortigianeria infatti assunse con il tempo il carattere di una vera missione pedagogico-politica, in cui il cortigiano si poneva davanti al principe come modello di perfezione.
Domande da interrogazione
- Quali erano le caratteristiche essenziali per essere un buon cortigiano secondo Baldassar Castiglione?
- Qual era il ruolo dei cortigiani nelle corti italiane del XV e XVI secolo?
- Quali abilità pratiche doveva possedere un cortigiano ideale?
- Come veniva vista la cortigianeria nel tempo secondo il testo?
- Qual era l'importanza delle arti per un cortigiano secondo Castiglione?
Secondo Castiglione, un buon cortigiano doveva avere doti naturali come la nobiltà di nascita, ma anche imparare lettere latine e greche, l'uso delle armi, e varie abilità come l'equitazione, la danza, e la musica, senza eccellere in nessuna come professione.
I cortigiani avevano il compito di consigliare i principi e attuare le loro decisioni, assumendo un ruolo determinante poiché le iniziative importanti delle società ricevevano impulso dalle corti.
Un cortigiano ideale doveva saper condurre conversazioni, essere spiritoso, apprezzare ed eseguire musica, conoscere il latino e il greco, e avere nozioni di pittura, scultura e disegno.
La cortigianeria assunse il carattere di una missione pedagogico-politica, dove il cortigiano si poneva come modello di perfezione davanti al principe, aiutandolo a operare bene.
Le arti affinavano il gusto e permettevano una comprensione più profonda dell'armonia del creato, oltre a fornire abilità pratiche come tracciare schizzi e disegni di luoghi e fortificazioni.

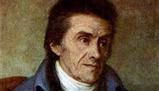





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo