Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
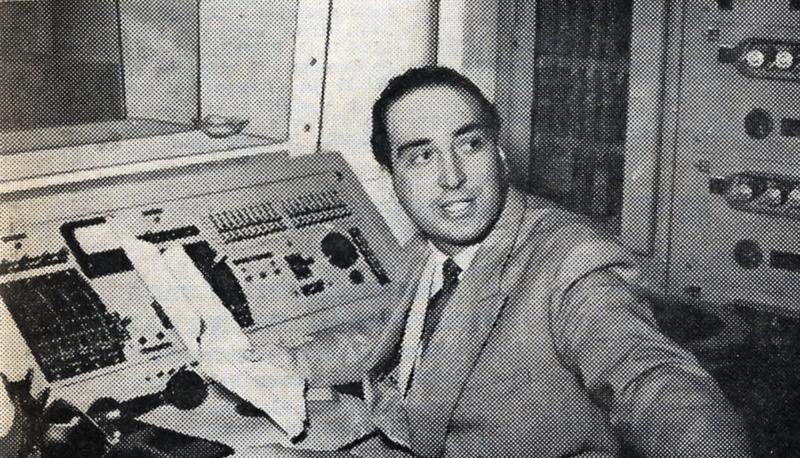
Sommario
Cenni storici
• Biografia di Guglielmo Marconi
• Evoluzione dell’invenzione di Marconi
Comunicazione tramite onde radio
• Onde elettromagnetiche e onde radio
La prima radio: la radio a galena
• Antenne
• Sintonia
• Circuiti risonanti serie
• Circuiti risonanti parallelo (o antirisonanti)
• Accorgimenti per aumentare la selettività
• Cenni sulle modulazioni
• Modulazione d’ampiezza (AM)
• Modulazione di Frequenza (FM)
• Trasmissioni radio stereofoniche e informazioni RDS
• Rivelazione
• Il diodo
• Il rivelatore a galena
• Schema elettrico
• Dimensionamento dei componenti
• Costruzione del ricevitore
Evoluzione dell’invenzione di Marconi
Guglielmo Marconi aveva fatto i primi esperimenti di trasmissione a distanza nel 1895 e ottenuto un
collegamento fra l’Inghilterra e la Francia nel 1897. Nel 1901 realizzò la prima trasmissione
transoceanica, che apriva la via alle comunicazioni su scala “globale”; si trattava di telegrafo in
codice “digitale” (alfabeto Morse) – e non era broadcasting, comunicazione diffusa: né Marconi né
altri in quel periodo avevano immaginato che potesse nascere qualcosa come la radio.
Le “radiodiffusioni” sono un concetto completamente diverso dal “telegrafo senza fili” e si
svilupparono vent’anni più tardi: la prima emittente radiofonica nacque nel 1920 negli Stati Uniti
mentre negli anni seguenti la radio si diffuse in Europa (in Italia nel 1924) diventando così un
mezzo di comunicazione di massa: il grande pubblico si forniva di apparecchi riceventi con cui
seguiva i programmi radiofonici trasmessi dalle poche emittenti allora esistenti. E’ evidente quindi
che a pochi soggetti attivi corrisponde una massa assai numerosa di ascoltatori passivi.
In America, e soprattutto negli Stati Uniti si svilupparono presto un gran numero di emittenti che si
finanziavano con gli introiti delle pubblicità. In Europa invece vigeva il monopolio pubblico: una
compagnia statale era addetta alla fornitura del servizio radiofonico e si finanziava grazie al
contributo dei cittadini riscosso sotto forma di “abbonamento” (analogamente all’attuale canone
RAI). In Italia durante il periodo fascista il servizio era affidato alla URI (Unione Radiofonica
Italiana) che iniziò ufficialmente la sua attività nell’ottobre 1924.
La radio svolse un importantissimo ruolo di informazione di massa durante la seconda guerra
mondiale soprattutto in Italia dove all’inizio della guerra erano diffusi poco più di un milione di
apparecchi: nonostante la ridotta diffusione di apparecchi radiofonici il popolo si sentiva
direttamente partecipe di eventi che solo pochi potevano vedere di persona. Negli Stati Uniti il
presidente Roosevelt pronunciò molti suoi discorsi alla radio in modo da assicurarsi una campagna
politica capillare; in Italia il 9 maggio 1936 Benito Mussolini pronunciava il “discorso di
proclamazione dell’Impero fascista” che passò alla storia come più alto successo propagandistico
del fascismo: per l’occasione furono posti degli altoparlanti nelle più grandi piazze d’Italia in modo
da permettere anche a chi non avesse apparecchi radiofonici di ascoltare il discorso.
Oltre al ruolo di informazione e politico la radio diventò la colonna sonora di milioni di persone con
la musica, i varietà e le trasmissioni radiofoniche di intrattenimento.
Nel corso degli anni trenta fu messa a punto la tecnologia della televisione e cominciò la diffusione
dei primi apparecchi televisivi. Nel 1938 la seconda guerra mondiale era ormai alle porte quando in
Italia furono realizzate le prime trasmissioni televisive sperimentali; lo sviluppo di questo nuovo
mezzo di comunicazione si arrestò temporaneamente durante il conflitto mentre la radio ebbe un
boom inaspettato. Dopo la guerra la televisione ebbe rapidamente il successo che meritava e nel
1954 si ebbero le prime trasmissioni televisive anche in Italia.
Col passare degli anni la televisione ha assorbito dalla radio tutte le forme di comunicazione
esistenti: cinema, musica, teatro e intrattenimenti di piazza valorizzando così anche gli aspetti più
umili della cultura popolare e proponendosi come la naturale evoluzione della radio stessa mentre il
cinema perdeva sempre di più il suo pubblico.
Nel frattempo la radiofonia non fu completamente soppiantata (come qualcuno ipotizzò all’avvento
della televisione) ma assunse funzioni diverse: perse il suo carattere familiare divenendo così mezzo
di comunicazione individuale: la scoperta dei semiconduttori e il progredire delle tecnologie
permise la realizzazione di apparecchi portatili mentre il pubblico diventava molto variabile a
seconda delle fasce orarie, analogamente a come accade oggi per la televisione.
La casa non era più un luogo di raccoglimento protetto dalla comunicazione pubblica, che fino ad
allora aveva come teatro la piazza, ma era costantemente collegata con il resto del mondo attraverso
la rete telefonica, e poteva accogliere i messaggi più disparati dalla televisione e dalla radio. 4
Comunicazione tramite onde radio
Onde elettromagnetiche e onde radio
La propagazione delle onde elettromagnetiche è governata dalle leggi di Maxwell della
circuitazione del campo elettrico e del campo magnetico:
d E
d B
e B d s i
E d s
0 ch 0 dt
dt
Dove la prima equazione rappresenta la legge dell’induzione di Faraday e la seconda è la sintesi
matematica del teorema di Ampere - Maxwell, teorema che rappresenta il frutto di una ricerca di
simmetria tra campi elettrici e magnetici.
Le soluzioni di queste equazioni sono funzioni d’onda per il campo elettrico e per il campo
magnetico:
E E sen kx t
m
B B sen kx t
m
Dove è il numero d’onda e è la pulsazione dell’onda.
k
L’esperimento dell’induzione elettromagnetica, rappresentato in figura, è di per sé un esempio di
trasmissione di energia elettrica senza l’interposizione di un conduttore: nel circuito indotto, pur
essendo isolato dal circuito induttore, si genera una fem indotta. E’ da notare inoltre che la
propagazione avviene solo se c’è una variazione nel tempo delle grandezze elettriche nel circuito
induttore, questo fatto diventa caratteristico nella trasmissione radiofonica dal momento che le
stazioni si identificano proprio per mezzo della loro frequenza.
Le onde elettromagnetiche sono dunque la propagazione di campi elettrici e magnetici che si
concatenano a vicenda secondo le equazioni di Maxwell. A partire da questo presupposto si possono
spiegare alcuni fenomeni caratteristici che differenziano le onde elettromagnetiche dalle onde
meccaniche:
La propagazione dell’onda elettromagnetica può avvenire anche nel vuoto
Qualunque siano le proprietà meccanico/fisiche del luogo in cui si propaga l’onda (non
possiamo parlare di mezzo), essa non varia la sua velocità di propagazione in modo
consistente: questa è infatti molto prossima alla velocità di propagazione della luce,
8 1
3 10 m s
Il campo elettromagnetico non è un mezzo dispersivo, quindi la potenza dell’onda è costante
in ogni punto dello spazio.
Come le onde meccaniche, anche le onde elettromagnetiche sono caratterizzate da una frequenza e
da una lunghezza d’onda; per le onde elettromagnetiche la lunghezza d’onda è sempre inversamente
proporzionale alla frequenza per mezzo di una costante fisica: la velocità della luce c. 5
La classificazione delle onde elettromagnetiche viene fatta a partire dalla loro lunghezza d’onda; di
seguito è riportato lo spettro completo delle onde elettromagnetiche e le relative lunghezze d’onda,
ordinate in modo crescente
Sotto il nome di Onde radio vanno dunque le onde elettromagnetiche con una lunghezza che varia
da 1cm a 1km; a causa della vastità del loro spettro le onde radio sono suddivise a loro volta in
Microonde (centimetriche)
UHF (decimetriche)
VHF (metriche)
Onde corte (decametriche)
Onde medie (ettometriche)
Onde lunghe (chilometriche).
Si utilizzano onde con diversa lunghezza a seconda della distanza da coprire e dalla potenza da
trasmettere. 6
La prima radio: la radio a galena
Finalmente siamo giunti a parlare di un apparecchio ricevitore vero e proprio; esso è progettato per
la ricezione di stazioni radiofoniche che trasmettono nella gamma delle onde medie. Seppur
rudimentale e poco pratico ha due pregi: non necessita di alcun tipo di alimentazione e può essere
realizzato molto facilmente dal momento che richiede un esiguo numero di componenti e la sua
realizzazione non è critica. La semplicità costruttiva, la facile reperibilità dei componenti negli anni
’40, ha fatto sì che questo apparecchio avesse grande diffusione tra i profughi e i prigionieri di
guerra.
Antenne
Per ricevere un onda elettromagnetica, la prima cosa di cui si ha bisogno è un antenna: un
dispositivo che traduce la perturbazione elettromagnetica in una differenza di potenziale e
viceversa, a seconda se esse sono utilizzate in trasmissione o in ricezione.
Si è visto che le perturbazioni elettromagnetiche si formano da una variazione temporale di un
campo elettrico o magnetico; per propagare un onda elettromagnetica abbiamo bisogno di un modo
pratico per creare un campo elettrico o magnetico variabile nel tempo.
Il modo più semplice (e più intuitivo) consiste nell’utilizzare una spira percorsa da una corrente
variabile: ad essa si concatena un campo magnetico anch’esso variabile che poi darà origine alla
perturbazione elettromagnetica.
Allo stesso modo la parte magnetica di un onda elettromagnetica che concatena una spira, genera al
suo interno una corrente variabile: possiamo immaginare la spira come una linea di circuitazione:
per la quarta equazione di Maxwell la circuitazione del campo elettrico indotto all’interno della
spira non è nullo, per cui non ci si trova in condizioni di equilibrio elettrostatico: c’è una corrente
che scorre nella spira.
Interrompendo la spira, tra i due estremi della stessa si forma una differenza di potenziale (che
peraltro è uguale alla circuitazione del campo elettrico prendendo come linea di circuitazione la
spira stessa).
Questo costituisce un’antenna comunemente detta “dipolo ripiegato” e largamente utilizzata sia in
trasmissione sia in ricezione; spesso la forma di quest’antenna però non è una spira circolare ma una
spira molto schiacciata in cui si affiancano ad una distanza molto piccola due rami in cui circolano
correnti controverse; questo accorgimento tecnico aumenta il rendimento dell’antenna stessa. 7
Un altro tipo di antenna è il dipolo semplice: esso è formato da due conduttori lineari che giacciono
sulla stessa retta, isolati elettricamente tra loro:
In questo caso sul conduttore che costituisce l’antenna si instaura un campo elettrico indotto in
modo del tutto analogo a quanto accade per il dipolo ripiegato.
Le antenne sono l’equivalente di un circuito risonante RLC serie (che sarà analizzato
dettagliatamente nel corso della trattazione dei circuiti di sintonia), pertanto esse hanno una certa
frequenza di risonanza, cioè hanno una certa attitudine a ricevere (ma lo stesso discorso vale anche
per la trasmissione) onde elettromagnetiche a determinate lunghezze d’onda.
Per far sì che si formi un campo elettrico indotto l’antenna deve andare in “risonanza”, cioè su di
essa si deve instaurare un onda elettromagnetica stazionaria (come avviene su una corda percossa su
cui si instaura un onda meccanica stazionaria).
La frequenza di risonanza di un antenna è caratteristica dell’antenna e varia in base alla sua
geometria (in modo analogo a quanto accade per una corda elastica):
Un dipolo semplice in risonanza può essere rappresentato come in figura:
La sua lunghezza complessiva è pari a metà della lunghezza d’onda poiché l’antenna risulta essere
aperta ad entrambe le estremità (in una di esse si forma un ventre mentre in un'altra una cresta che
poi si alternano a vicenda lasciando al centro dell’antenna un nodo).
In un antenna a dipolo ripiegato l’onda stazionaria che si forma avrà un nodo al centro del dipolo e
uno situato su ognuno dei due ripiegamenti che sono alle estremità dell’antenna.
Trasmettere o ricevere segnali ad una frequenza piuttosto bassa richiede quindi antenne di grandi
dimensioni.
Si presta particolarmente alla ricezione e
trasmissione in onde medie e onde lunghe
l’antenna “ground-plane” (alla lettera “piano
di terra”) che offre dimensioni fortemente
vantaggiose rispetto ai tipi precedentemente
descritti, a discapito del rendimento: essa è
costituita da uno stilo metallico che parte da








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









