vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
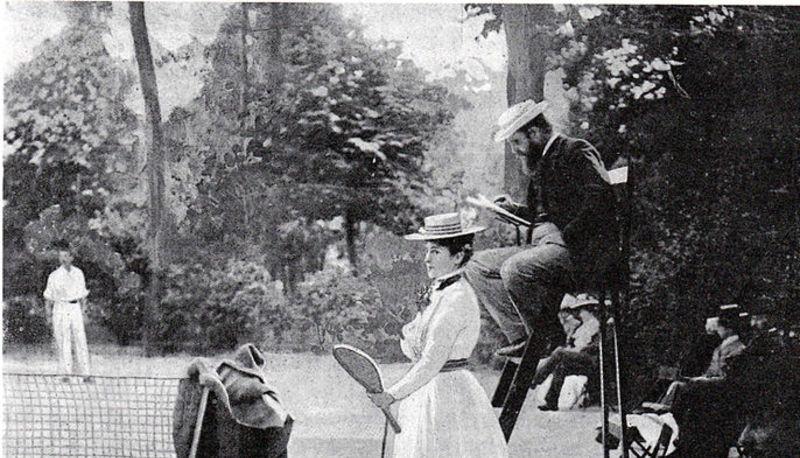
La Belle Époque
1900-1920
Tesina 1900-1920
(diritto riservato esclusivamente a Skuola.net)
Hobsbawm, storico inglese, ritiene che storicamente il XX secolo si possa fare iniziare nel
1914, con l’inizio del primo conflitto mondiale e terminare nel 1991, con la disgregazione
del blocco orientale che segna la fine della guerra fredda. Nei primi 45 anni del secolo si
sono addensati gli avvenimenti politico-storico-sociali più importanti.
In antitesi al secolo breve troviamo il secolo lungo 1789-1914 –l’ottocento allungato-, in cui
si afferma la borghesia, che credeva di poter tenere saldamente in mano il mondo attraverso
le scienze “positive” ed un cieco ottimismo nell’industrializzazione e nella tecnologia.
Così prima Nietzsche e poi Freud, due grandi maestri del sospetto, trovano, analizzando i
fenomeni culturali, delle falle nascoste nella coscienza della società e soggetto.
Nietzsche, appurata la crisi della società ottocentesca, come un “Colombo dell’anima”,
comprende che la società borghese mira solo ad ambizioni egoistiche e opportunistiche
ridotte all’accumulo di denaro e che la morale cristiana è ormai divenuta un fantasma. Ecco
il grande annuncio di Zaratustra (1883-85 attraverso aforismi: si noti qui la frammentarietà
tipica delle avanguardie novecentesche vs. tradizione, passato), “la morte di Dio”, l’uomo
deve andare oltre se stesso, rifidanzandosi con la natura, da lui stesso abbandonata e con un
salto dionisiaco-vitalistico, andare oltre il nichilismo che lo attanaglia e superarsi dandosi
una “morale autonoma”. Altra via di uscita? Le Volontà di potenza (1901 – postuma). Verrò
capito fra quarant’anni.
In un breve ma denso scritto del 1916, Una difficoltà della psicoanalisi, Freud, dopo
Copernico, Darwin, Nietzsche, assesta un altro colpo al “narcisismo dell’umanità”. Il
soggetto umano vede ora messa radicalmente in dubbio dalla psicanalisi la sua assoluta
padronanza dei propri contenuti concettuali e della propria volontà. “L’Io non è più padrone
in casa propria” nel momento in cui viene dimostrato come pensieri, volontà, comportamenti
siano il risultato della censura che compie il razionale Io alle pulsioni dell’ Es, sospese tra
Eros e Thanatos, e ai comandi sociali del Super-Io. (Strutturazione Io, Es, Super-Io di tipo
ottocentesco-razionale)
I primi anni del ‘900 furono anni formidabili a livello scientifico e tecnologico: a vecchie e
antiquate teorie se ne sostituirono altre che nonostante l’opposizione dei vecchi conservatori,
contribuirono a segnare l’era moderna; la relatività di Einstein, la deriva dei continenti di
Wegener o la
Nel 1912 Wegener formulò l’ipotesi, nota come teoria della deriva dei continenti, secondo
la quale
Prove geomorfologiche. Dall’esame dell’atlante geografico si nota che le sponde
o dell’Africa e delle regioni meridionali del Sudamerica si potrebbero incastrare come
pezzi di un puzzle. Tale incastro può essere giustificato, secondo Wegener, solo
accettando l’ipotesi di una passata unione dei due continenti. I suoi oppositori misero
in dubbio il valore di questa prova. Innanzitutto l’incastro non è preciso come
sembra a prima vista, in secondo luogo buona parte dei geologi riteneva assai
improbabile che la morfologia delle coste, continuamente sottoposte all’azione
erosiva del mare, potesse essere rimasta inalterata per tempi lunghi, conservando la
corrispondenza iniziale. Oggi sappiamo che il limite reale tra continenti e oceani non
corrisponde alla linea di costa, ma si trova al di sotto del livello del mare, a circa 900
m di profondità, cioè dove la scarpata separa la piattaforma continentale dai fondali
oceanici.
Prove paleontologiche. dal confronto di rocce e fossili sulle due sponde dell’Oceano
o Atlantico si è potuto osservare che, in alcune località, sono sorprendentemente simili.
È il caso di certi tipi di rocce e di resti fossili di felci e di rettili ritrovati solo in una
parte del Sudamerica e nella parte dell’Africa corrispondente. Secondo la teoria
evolutiva una tale somiglianza tra gli esseri viventi di continenti diversi implica
necessariamente che sia esistita la possibilità di passare con facilità da una zona
all’altra. In precedenza per spiegare la distribuzione della flora e della fauna ai due
lati dell’Atlantico si ricorreva all’ipotesi dei ponti continentali, tratti di crosta
continentale che in passato avrebbero collegato continenti ora separati. I ponti
sarebbero poi sprofondati nei fondali oceanici e flora e fauna avrebbero cominciato a
diversificarsi. Secondo Wegener una teoria del genere non ha alcun fondamento: non
è possibile, infatti, che le rocce granitiche e leggere dei ponti sprofondino nel
materiale più denso che è presente nella crosta degli oceani. Inoltre, non sono mai
stati ritrovati sui fondali oceanici i resti della crosta continentale che avrebbe
costituito questi giganteschi ponti.
Prove paleoclimatiche. Dallo studio della distribuzione dei climi sulla Terra in
o epoche passate si è potuto dedurre che nei continenti meridionali, in regioni che oggi
hanno un clima tropicale, c’erano condizioni di clima freddo, documentate dalla
presenza di depositi glaciali risalenti a più di 300 milioni di anni fa. Grandi depositi
evaporatici, che si formano solo in ambienti caldi e secchi, e giacimenti di carbone,
tipici di un clima tropicale, risalenti allo stesso periodo, testimoniano invece
l’esistenza di climi caldi in diverse regioni settentrionali. Secondo Wegener l’unica
possibile spiegazione di questi dati è che i continenti fossero all’epoca uniti e
spostati molto più verso sud di quanto non lo siano attualmente.
Fin da quando fu enunciata, la teoria di Wegener sulla deriva dei continenti fu accolta con ostilità e
scetticismo dagli scienziati. Il motivo di ciò è da ricercare soprattutto nel fatto che le forze indicate
originariamente da Wegener quali causa della deriva erano obiettivamente sproporzionate agli
effetti prodotti. Wegener supponeva che la forza centrifuga originata dalla rotazione terrestre avesse
spinto i continenti verso l’equatore e che altre forze, come l’attrazione luni-solare, fossero state la
causa della deriva verso ovest del continente americano. Tali forze però sono da considerarsi
largamente insufficienti e perciò la forza in grado di provocare una deriva deve essere cercata
all’interno della Terra. In effetti Wegener, nell’ultima revisione della propria teoria, indicò le
correnti convettive del mantello come possibile causa della deriva continentale.
Dal 1900 La luce elettrica entra lelle case: a cavallo fra il XIX e XX secolo la luce
elettrica iniziò a diffondersi e divenne subito molto popolare perché non comportava alcun
rischio di esplosione e la luce poteva essere ottenuta premendo semplicemente un
interruttore. Nel 1879 Edison realizzò la prima lampadina elettrica al mondo.
Vuoi per queste scoperte tecnologiche, vuoi per la mancanza da anni di guerre, l’Europa
attraversava un periodo di benessere tra il 1900 e il 1914. Questo periodo va sotto il nome di
Belle Epoque. Crisi =>nascita nazionalismi kultur vs. civilization. 1905-1917 Rivoluzione
russa. Sindacati.
La Grande guerra ’14-’18
Durata - estensione
o Mobilitazione totale
o Utilizzazione militare della tecnica
o Guerra di posizione
o Massificazione della società
o Rilevanza degli avvenimenti contenuti e scatenati
o
Gli orientamenti letterari del primo ‘900
La letteratura del primo ventennio del Novecento in Italia, oscilla tra una tendenza tardo
ottocentesca simbolista ed estetizzante, portata avanti dagli ormai maturi Pascoli e D’Annunzio, ed
una nuova tendenza sovversivistica che rompe con il passato e con la tradizione: le avanguardie.
I crepuscolari: un’avanguardia ambigua
La rottura con il passato si manifesta con una concreta “perdita d’aureola”, non abbiamo un poeta-
vate bensì uno veggente. La professione del poeta viene dunque riportata all’interno di un ruolo
quotidiano, piccolo-borghese (Pascoli docet), che viene privato e depurato di qualsiasi istanza
retorica e trionfalistica: l’immagine dell’artista risulta fortemente ridimensionata e circoscritta a una
concezione del mondo ristretta, personale, mai totalizzante o assoluta. Se guardiamo alle metafore
con cui i giovani poeti di questa generazione tratteggiano la figura del poeta possiamo facilmente
individuare questa crisi del ruolo. Palazzeschi si realizza nell’uso smodato di licenze poetiche in “E
lasciatemi divertire”, Moretti rileva la finzione di un’esistenza soffocata e repressa “A Cesena”. La
metafora dell’esistenza, equivale a una dichiarazione di impotenza e di incapacità a definire il
mondo e la realtà come funzionali a qualcosa di altro rispetto alla poesia: in altri termini, mentre in
D’Annunzio la letteratura consisteva nella riproduzione di una vita straordinaria ed eccezionale, nel
caso dei crepuscolari e di altre esperienze vicine, l’obiettivo del poeta è essenzialmente quello di
concentrarsi sul testo, sull’elaborazione artistica in quanto unico elemento di confronto con la
realtà, vera e propria fonte di salvezza spirituale.
Spetta al critico letterario Giuseppe Antonio Borgese il merito di avere per primo adoperato in un
articolo giornalistico il termine di “crepuscolare” per indicare lo spegnersi di una poesia sublime e
aulica, quella di Carducci e D’Annunzio. L’articolo, pubblicato sulla “Stampa” di Torino il 1
settembre 1910, si intitolava appunto Poesia crepuscolare. Anzitutto andrà precisato che i
crepuscolari non dettero vita a nessun movimento o raggruppamento precostituito: essi non si
attennero a ordini, schemi, modelli e strategie comuni, come avrebbero fatto invece i futuristi o altre
avanguardie artistiche di questo periodo.
Il futurismo
Il Futurismo è un movimento artistico e letterario di portata europea, che nasce ufficialmente il 20
febbraio del 1909 con il Manifesto del futurismo, steso da Marinetti e apparso sul “Figaro” di
Parigi,. Esso raccoglie e amplifica tendenze già largamente presenti nel clima culturale di quel
periodo, e, oltre alla letteratura e alle arti figurative, coinvolge la musica, il teatro, il cinema, la
danza, ed anche la politica.
Vera e propria avanguardia storica, il Futurismo costituisce una delle tante forme di rottura nei
confronti dell’arte del passato che si manifestarono agli inizi del Novecento. Il Futurismo esalta un
ideale di vita attiva, fondata sullo slancio e sull’aggressività, sull’amore per il pericolo, l’audacia e
la temerarietà, in un impegno globale della mente e del corpo. L’entusiasmo per gli aspetti più
appariscenti del mondo moderno in continua evoluzione, la tendenza a proiettarsi verso un futuro








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









