Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
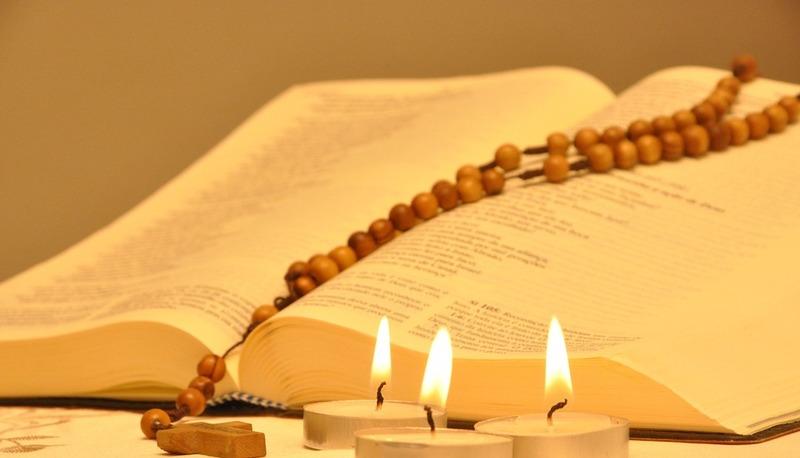
INTRODUZIONE
LE RADICI DELLA RELIGIONE - dove nasce la religione
-Bisogno di una spiegazione della parte irrazionale legata alla sfera dei sogni
-Volontà di controllare la natura e il mondo circostante
-Funzione sociale della religione
-Funzione catartica
IL PARADOSSO GRECO – mondo greco
-Problema del peccato
-Problema della sofferenza
UNA SOCIETÀ IN CONTINUA CRISI - mondo latino
-La prima crisi dopo le guerre puniche
-L’attacco delle nuove filosofie
-L’epoca augustea
IL CRISTIANESIMO NEI SECOLI
DALLA REALTÀ FRANTUMATA A DIO - Luigi Pirandello
-Il fu Mattia Pascal (il contrasto tra vita e forma)
-Uno, nessuno, centomila (la risoluzione del contrasto)
-Approdo ad una visione religiosa
LA SPERANZA SENZA SPERANZA – Eugenio Montale
-Il poeta del male di vivere
-La tensione irrisolta verso un oltre
LA RICERCA VERSO IL NULLA - Italo Calvino
-Palomar: ricerca di un ordine nel caos della vita
-Negazione di questo ordine
UN CICLO CHE SI RIPETE – Il New Age e i giorni nostri
BREVE PRECISAZIONE FINALE
LA VIA CHE PORTA A DIO
(Il rapporto tra crisi e religione)
Questa tesina è nata senza avere alle spalle una motivazione precisa ma è il risultato di una serie
di riflessioni che spesso faccio, non solo su questo ma su molti altri temi.
Il fatto che essa fosse collegabile e soprattutto sostenibile tramite gli argomenti trattati durante il
corso di questo anno scolastico, ha reso possibile una stesura che si adattasse all’esigenza di
presentare una tesina all’esame orale di maturità.
Quanto sopra può sembrare a prima vista un’affermazione che banalizza il mio lavoro ma in realtà
serve a dimostrare come questa tesina sia molto personale dato che essa è stata creata non solo per
un’esigenza di tipo scolastico ma per un mio bisogno personale che mi spinge a riflettere su molte
delle cose che compongono la nostra vita e il nostro mondo.
Questo “compito” è stato quindi l’occasione per rendere organico almeno uno dei tanti discorsi
che ogni giorno tentano di articolarsi nella mia mente. 1
INDICE
INTRODUZIONE
LE RA DICI DELLA RELIGIONE - dove nasce la religione
-Bisogno di una spiegazione della parte irrazionale legata alla sfera dei sogni
-Volontà di controllare la natura e il mondo circostante
-Funzione sociale della religione
-Funzione catartica
IL PARADOSSO GRECO – mondo greco
-Problema del peccato
-Problema della sofferenza
UNA SOCIETA’ IN CONTINUA CRISI - mondo latino
-La prima crisi dopo le guerre puniche
-L’attacco delle nuove filosofie
-L’epoca augustea
IL CRISTIANESIMO NEI SECOLI
DALLA REALTA’ FRANTUMATA A DIO - Luigi Pirandello
-Il fu Mattia Pascal (il contrasto tra vita e forma)
-Uno, nessuno, centomila (la risoluzione del contrasto)
-Approdo ad una visione religiosa
LA SPERANZA SENZA SPERANZA – Eugenio Montale
-Il poeta del male di vivere
-La tensione irrisolta verso un oltre
LA RICERCA VERSO IL NULLA - Italo Calvino
-Palomar: ricerca di un ordine nel caos della vita
-Negazione di questo ordine
UN CICLO CHE SI RIPETE – Il New Age e i giorni nostri
BREVE PRECISAZIONE FINALE 2
INTRODUZIONE
Per cercare di capire qual è il nucleo centrale del discorso portato avanti in questa sede, inizierei nel
prendere spunto dalle riflessioni fatte sul tema della religione dal filosofo Soren Kierkegaard.
Egli, nelle sue due opere fondamentali “Concetto dell’angoscia” e “La malattia mortale”, sostiene
che la situazione in cui si trova l’uomo è di radicale incertezza, di dubbio e che questa è data dalla
natura costituzionale dell’uomo. Questa condizione si traduce nel sentimento dell’angoscia che a
sua volta porta alla disperazione. La disperazione è data dal volere o non volere essere se stessi: nel
primo caso non si giunge all’equilibrio in quanto l’essere umano è finito e quindi insufficiente a se
stesso, nel secondo caso si arriva ad una impossibilità di fondo in quanto si tenta di distruggere l’io
nella sua costituzione. La disperazione è quindi “l’impossibilità del tentativo”.
L’antidoto alla disperazione è la fede in quanto con essa l’uomo riesce ad accettare la sua
insufficienza e a riconoscere la sua dipendenza da Dio.
Con questa breve esposizione delle teorie di Kierkegaard ho voluto evidenziare il tipico
atteggiamento umano di fronte alle crisi. Infatti, egli dice chiaramente che la soluzione ai problemi
esistenziali (nella sua opera, alla disperazione) è la fede, la religione, il credere in qualcos’altro da
cui siamo dipendenti che sia più potente di noi e abbia la capacità di risolvere e di ordinare tutto.
E’ quello che dice Nietzche nel tema della “morte di Dio” quando afferma che la concezione di un
cosmo ordinato, governato da scopi ben precisi e retto da entità superiori provvidenti è ciò di cui
abbiamo bisogno per sopravvivere al caos della vita.
L’uomo non è in grado di accettare il relativismo assoluto dell’intero universo e per questo ha
bisogno di crearsi dei punti fissi che non possano crollare e che quindi, per questo, debbono essere
trascendentali.
Con questa tesina ho intenzione di cercare di mettere in luce il rapporto di causa-conseguenza
esistente tra crisi e religione, crisi che può essere di tipo culturale, esistenziale o spirituale. Infatti,
vedremo come l’uomo primitivo sia arrivato alla religione per soddisfare determinate esigenze e in
seguito come la religione sia stata la risposta alle esigenze provocate dalle varie crisi. 3
LE RADICI DELLA RELIGIONE
Per riuscire a penetrare le cause più intime che spingono costantemente l’uomo verso un oltre,
bisogna innanzi tutto partire dalle prime forme di religione e cioè dalle religioni primitive.
Il primo studioso che gettò le basi di uno studio antropologico della religione fu Edward B. Tylor. Il
suo discorso prende prevalentemente in esame l’aspetto animistico della religione e cioè la credenza
in esseri soprannaturali dei popoli primitivi. Infatti egli ritiene che essa abbia avuto origine da una
errata ma coerente interpretazione dei sogni, allucinazioni, stati epilettici riflettendo sui quali
l’uomo sia arrivato a distinguere l’anima dal corpo; anima che oltretutto sopravvive al corpo in
quanto questi popoli credono che i morti visitino i vivi durante questi stati d’incoscienza.
E siccome l’uomo tende a vedere tutto a sua immagine e somiglianza, anche gli animali e le piante
hanno un’anima che agisce, che aiuta o ostacola l’uomo.
Questa teoria seppur limitata ad un ristretto ambito delle religione è una buona base di partenza per
un discorso più ampio sulle radici della religione.
Un secondo studioso, Sir James Frazer tratta tra gli altri aspetti anche l’istinto umano di controllare
ogni cosa. Egli nel suo libro “Il ramo d’oro” sostiene che innanzi tutto l’uomo tenta di controllare la
realtà tramite la magia e la “scienza” ma nel momento in cui non riesce, fa appello a entità superiori
che sono in grado di controllare tutto, per avere il loro aiuto e la loro protezione.
(E’ quello che dice Nietzche nel tema della “morte di Dio” quando afferma che la concezione di un
cosmo ordinato, governato da scopi ben precisi e retto da entità superiori provvidenti è ciò di cui
abbiamo bisogno per sopravvivere al caos della vita.)
E su questo si basa anche il concetto del totemismo che per citare la definizione di Frazer “è la
intima relazione che si suppone esista fra un gruppo di persone imparentate da una parte, e una
specie di oggetti naturali o artificiali dall’altra, oggetti che sono chiamati totem del gruppo umano”.
Il totemismo ha quindi due funzioni principali che comprendono l’interesse dell’uomo per ciò che
lo circonda e la volontà di controllarlo e la necessità di un raggruppamento sociale.
Questo sottolinea l’aspetto della religione più vicino alla realtà e agli immediati interessi della vita
pratica e ci fa notare quindi come la religione non sia il risultato solo di allucinazione e irrazionalità
ma come sia influenzata anche dalla visione e dal ragionamento razionale dell’uomo. Inoltre
l’ultima osservazione fatta sul totemismo ci porta a considerare l’aspetto sociale della religione,
spesso trascurato.
E’ indubbio che la credenza in un’unica idea unisca il gruppo e tanto più l’idea viene alimentata e
conservata gelosamente tanto più il gruppo si sentirà investito di un compito speciale: quello di
tramandare l’idea ai soli componenti del gruppo e di far sì che questa conoscenza non vada
perdendosi.
Per questo motivo all’interno di tutti i gruppi la conoscenza viene tramandata di generazione in
generazione tramite precisi e faticosi riti d’iniziazione durante i quali i giovani per dimostrare il loro
valore e guadagnarsi il diritto di accedere alle rivelazioni e insegnamenti degli anziani devono
superare numerose prove fisiche e di ascesi. Questi riti, oltre a servire per custodire gelosamente la
conoscenza della tribù, segnano anche il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Infatti si è notato
come molti riti e credenze delle popolazioni primitive siano legati ai momenti di crisi e di passaggio
quali il concepimento, la gravidanza, la nascita, la pubertà, il raggiungimento della maturità, il
matrimonio e la morte.
La tribù come istituzione è finalizzata a contrastare tutte le forze centrifughe presenti all’interno di
essa, come ad esempio la morte. La morte di un membro della tribù è un momento di crisi per la
tribù stessa e la religione ha il compito di risolverla. Infatti i componenti della tribù sono dilaniati da
due forze contrapposte: la ripugnanza per il cadavere e l’amore per il morto. La prima è una forza
disgregatrice che se non venisse controllata farebbe fuggire tutti i membri della tribù, distruggendo
la tribù stessa. E qui, in questo gioco di forze emotive, in questo supremo dilemma, si introduce la
religione, scegliendo le credenze positive, le opinioni confortanti, la credenza, culturalmente di gran
valore, nell’immortalità, nello spirito indipendente dal corpo e nella continuazione della vita dopo la
4
morte. La convinzione dell’uomo che la vita continui è uno dei doni supremi della religione, che
valuta e sceglie la migliore delle due alternative suggerite dall’autoconservazione: la speranza di
una continuazione della vita e la paura dell’annientamento. La credenza nell’immortalità è
supportata inoltre dalla credenza negli spiriti dovuta ai sogni e agli stati d’incoscienza (teoria di
Tylor descritta sopra); la religione salva l’uomo dalla resa alla morte e alla distruzione e lo fa
semplicemente servendosi delle osservazioni dei sogni, delle ombre, delle visioni..
Analizzando più nello specifico la funzione dei riti i funerali, gli atti di lutto, la disperazione rituale
esprimono l’emozione della privazione e della perdita di tutto il gruppo. Essi confermano e
riproducono i sentimenti naturali dei superstiti e sebbene negli atti di lutto, nella disperazione
mimica del pianto, nel trattamento del cadavere e nella sua eliminazione non si raggiunga nessun
obiettivo ulteriore, questi atti adempiono un’importante funzione catartica e posseggono un valore
considerevole per il mantenimento e la sopravvivenza della tribù.
Abbiamo visto finora come la religione sia nata sia per spiegare determinati fenomeni che si
verificano intorno o all’interno di noi, sia per la necessità di controllare la realtà, sia per delle
esigenze emotive proprie dell’essere umano. In seguito vedremo come la religione diventi via via
sempre più una risposta a dei momenti di crisi di intere popolazioni o di singoli uomini. 5
IL PARADOSSO GRECO
E’ opinione comune e tutti siamo d’accordo nell’affermare che il mondo greco è l’origine di tutta la
cultura occidentale. Quello che però spesso non viene preso in considerazione è il fatto che una
delle cause della diffusione del cristianesimo, fondamento e linea guida dell’evoluzione della nostra
cultura è proprio da ricercarsi nella cultura greca, o meglio nelle sue irrisolvibili contraddizioni che
portano tutto il mondo classico ad una crisi dei valori e ad una ricerca di nuovi valori.
Fin dai primordi della cultura greca esiste il problema del peccato. Il termine peccato è improprio in
questa sede in quanto nel mondo greco non esisteva l’idea di peccato ma lo utilizzeremo lo stesso
per riassumere brevemente il concetto a cui vogliamo riferirci.
Partendo dalla figura di peccatrice più grande dell’Iliade possiamo partire ad analizzare l’intero e
controverso problema.
Elena è colei che col suo adulterio fu causa di una atroce guerra: quella di Troia. Per causa sua
perirono numerosi soldati valenti tra i quali Patroclo da una parte ed Ettore dalla parte avversaria.
Lei è La Peccatrice per eccellenza. Ma tuttavia lo stesso Euripide in una tragedia intitolata Elena ci
narra di una leggenda secondo la quale la ragazza all’interno delle mura di Troia non sarebbe stata
Elena bensì un’ombra creata dagli dei, mandata per punire Paride dell’affronto fatto ad Atena ed Era
durante il famoso concorso di bellezza.








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









