Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
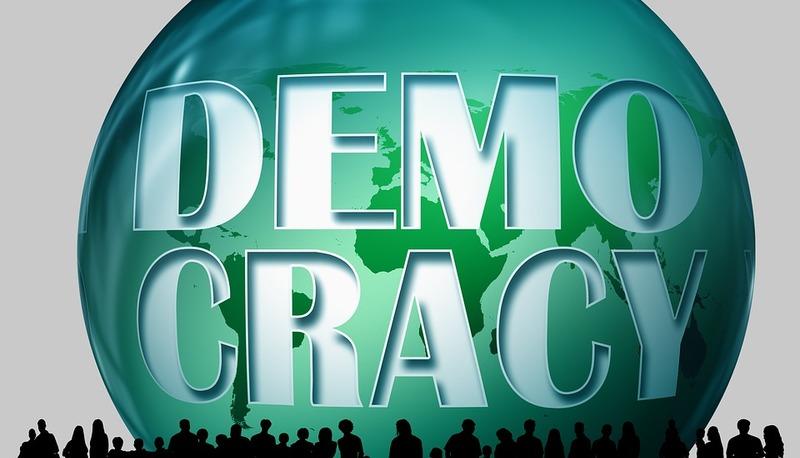
L’obiettivo di questa tesina è quello di definire, circoscrivere e limitare il concetto di democrazia.
E’ opinione piuttosto radicata che il termine significhi “potere del popolo”, ma questa è una semplificazione azzardata ed erronea. Vedremo come la πόλις non fosse nelle mani dell’intera comunità, ma solo dei possidenti, che guidavano la città con la forza.
Anche nel sistema democratico moderno, d’altra parte, sebbene apparentemente tutelato dal principio di maggioranza, proprio in nome di questo presupposto, l’individuo mette in costante rischio le proprie libertà personali. Attraverso l’analisi del pensatore De Tocqueville, scopriremo il più grande paradosso della democrazia moderna e affronteremo il tema del conformismo, dinamica sociale oggetto di pesanti critiche da parte di vari intellettuali.
Partendo dalle ultime raccolte (Satura e Diario’71) approfondiremo il pensiero montaliano e il suo comportamento nei confronti della società contemporanea .
Infine, individueremo un esempio storico di Stato paternalistico descritto nel romanzo Animal Farm di Gorge Orwell.
Alla base di tutto ci sono alcuni interrogativi fondamentali: chi ha la cittadinanza? In che
condizione si trovano coloro che non la possiedono? Quali sono gli strumenti per
esercitarla concretamente?
La πόλις è costituita da πολίται, che sono anche πολιτευόμενοι, cioè coloro che
esercitano la cittadinanza.
Ma il corpo civico varia nello spazio e nel tempo.
Se prendiamo in considerazione l’Atene periclea, godono del diritto di cittadinanza tutti i
maschi liberi nati da genitori ateniesi. Compare già una limitazione al numero di effettivi
cittadini: i purosangue in una città notoriamente dedita al commercio e ai contatti col
mondo esterno non era certamente considerevole.
Osserviamo poi che in epoca classica l’immagine del cittadino era obbligatoriamente
accostata a quella del guerriero, infatti solo chi era in grado di espletare la principale
funzione del maschio libero, cioè la guerra, aveva accesso alle assemblee decisionali.
Se pensiamo infine che esser soldato implicava anche la capacità di provvedere da sé
ad un’armatura, immediata è l’associazione del cittadino-guerriero al possidente.
Capiamo, dunque, come una città libera, com’era la πόλις di Atene, praticasse in fondo
5
una “democrazia decurtata” .
La cittadinanza era un bene prezioso che veniva concesso con parsimonia solo ai pochi
beneficiari.
In generale, anche negli anni successivi, il corpo civico nelle πόλεις coincise con il
corpo combattente.
Se esaminiamo, per esempio, l’Atene di Solone, più aperta verso il mare, al tempo delle
guerre persiane, notiamo un allargamento del corpo combattente: i non possidenti (i
“teti”) diventano delle figure fondamentali per “spingere i remi e muovere le navi”, come
sostiene con fastidio l’anonimo oligarca della Costituzione degli Ateniesi. In quanto
marinai della più potente flotta del mondo greco, anche essi assurgono così alla dignità
di cittadini-guerrieri.
Appare chiaro come anche la collocazione di una città e il suo impegno commerciale
possano provocare delle variazioni nel numero corpo civico.
5 cf. Canfora 2004 pag. 34.
Abbiamo così dimostrato il significato più vero di πλείονας in quella famosa
affermazione di Pericle. Non è dunque il “popolo intero” ad avere accesso alle
assemblee decisionali.
Quanto a tali riunioni, strumenti per esercitare concretamente la cittadinanza, esse non
funzionavano in modo automatico o indiscriminato come potremmo pensare.
Proprio ad Atene era in vigore la famosa ”diobelia”, un incentivo proposto dal popolare
Cleofonte per evitare l’assenteismo in assemblea dei non possidenti, risarcendoli della
perdita di una giornata di lavoro.
Per quanto l’allargamento della cittadinanza abbia provocato ad Atene dei cambiamenti
ai vertici del sistema, tuttavia i gruppi dirigenti restano quelli delle due classi di censo
più alte, che si alternano nel controllo della città.
Alcuni non sono contrari alla situazione che si è creata, cioè che la cittadinanza sia
stata concessa anche ai non possidenti, e per questo vengono definiti “democratici”,
perché puntano a dirigere tale sistema, stando al suo gioco.
Dall’altra parte, invece, ci sono coloro che sognano il buon-governo, fondato sulla
σοφροσύνη e per questo propongono la riduzione della cittadinanza ai soli possidenti.
Essi vengono definiti dagli avversari “i pochi”, gli oligarchi.
Dopo aver presentato i protagonisti di questo rapporto di poteri è necessario definire la
natura del legame.
Ingenuamente siamo portati a pensare che chi si trova agli alti vertici guidi il popolo
senza condizionamenti, ma lo stesso Tucidide ammette che Pericle “non era guidato da
loro più di quanto egli stesso non li guidasse”, riconoscendo l’inevitabilità di esser
guidati se si ha a che fare con la massa popolare.
Ecco dunque in cosa consisteva la democrazia greca: non in un governo popolare, ma
nella “guida del regime popolare da parte di quella non piccola porzione dei ricchi e dei
6
signori che accettano il sistema” FILOSOFIA
La degenerazione della democrazia in Stato paternalistico e il conformismo sociale
(De Tocqueville)
6 Cf. Canfora 2004 pag. 42.
Non si può affrontare il tema della democrazia senza prima definire i due tratti
caratteristici dell’essere umano che ne è il protagonista: libertà e diversità.
Si tratta di due caratteristiche che bisogna coniugare sempre insieme; infatti la libertà,
senza una pluralità di opinioni e comportamenti, rischia di affievolirsi e scomparire.
Questi principi, enunciati dal filosofo tedesco Humboldt nelle Idee per un saggio sui
limiti dell’attività dello Stato (1851), sono alla base dei successivi studi sui limiti degli
Stati democratici moderni.
Il filosofo vede nel progresso della civiltà una minaccia alla differenziazione di gusti e
opinioni individuali, pericolo che prende forma con lo sviluppo della società moderna.
Humboldt temeva quello che fu poi definito conformismo sociale, cioè la tendenza degli
uomini a seguire la moda e i costumi di massa, persino nel tempo libero e negli svaghi.
Tale comportamento piega le facoltà umane superiori, intelligenza e creatività, poiché gli
uomini considerano i gusti individuali e l’originalità dei comportamenti un danno da
evitare.
Il rischio di questo nuovo conformismo di massa è, dunque, la totale eliminazione delle
qualità del singolo, l’annullamento dell’individuo, causato dal livellamento della cultura e
delle coscienze, fino a una vera e propria spersonalizzazione.
“Ovunque il dispotismo della consuetudine si erge a ostacolo del progresso umano, ed è
in costante antagonismo con quella disposizione a tender verso qualcosa che sia migliore
dell’abitudine, chiamata, a seconda delle circostanze, spirito di libertà o di progresso o di
7
”
innovazione
Le cause di ciò vanno cercate in tre fattori tipici della società moderna.
In primo luogo lo sviluppo dell’industria manifatturiera con la diffusione sistematica di
beni secondari ha provocato un innalzamento delle aspirazioni di tutte le classi sociali;
poi il potenziamento dell’istruzione ha fatto sì che si divulgassero conoscenze e
informazioni uguali per tutti, livellando preferenze e sentimenti di ognuno; infine il
7 Cf. Mill 1997
Nel celebre saggio Sulla libertà Mill muove dalla preoccupazione di Tocqueville, per cui la democrazia porterebbe
progressivamente ad uniformare le masse, ma ha un debito anche nei confronti di Humboldt, che emerge in
particolare dall’idea che un individuo è libero di raggiungere la propria felicità come crede e che nessuno può
costringerlo a fare qualcosa, se non quando la libertà di uno provochi danno a qualcun altro.
sistema democratico ha dato a tutti un’illusione di uguaglianza, portando, invece, ad
una progressiva spersonalizzazione.
Concentrando l’attenzione soprattutto sull’ambito politico, ci rendiamo conto che un
sistema democratico non è necessariamente garanzia di libertà individuali e capiamo
che è sempre presente il rischio di annullamento della personalità.
Questo problema venne affrontato già nella prima metà dell’800 da A. De Tocqueville,
pensatore e uomo politico francese, in La democrazia in America, un acuto e
lungimirante saggio sulla democrazia americana, considerata non tanto come un
esempio da ammirare e seguire, quanto come un modello per capire il presente e il
futuro delle società moderne.
Il filosofo comprese già allora il carattere paradossale di un sistema democratico: da
una parte esso innalza l’uomo sia dal punto di vista economico sia politico, abolendo la
divisione in ceti sociali e promuovendo il singolo nel ruolo di cittadino, ma dall’altra
provoca un’assurda conseguenza: il peggior rischio di una democrazia è la sua
8
trasformazione in Stato paternalistico, cioè una vera e proprio dittatura .
Questo esito è possibile proprio a causa del principio di rappresentanza politica,
secondo cui i governanti non sono altro che persone delegate dai cittadini a ricoprire,
per un periodo limitato e sotto il controllo della legge , le funzioni amministrative.
Tale principio, però, si presta ad essere frainteso, qualora si voglia sottomettere la
minoranza al volere della maggioranza.
Tocqueville mette in guardia davanti a un caso del genere: 9
“ ”
l’onnipotenza in sé mi sembra una cosa cattiva e pericolosa
Lo Stato che si verrebbe a formare viene definito dal filosofo “potere immenso e
tutelare”.
8 Toqueville, all’interno del suo saggio affronta le principali differenze tra la tirannide antica, e quella moderna.
Si tratta di disuguaglianze relative a mezzi impiegati e soggetti coinvolti.
In passato non è mai esistito un despota tanto assoluto e potente come è lo Stato nella nostra società.
La sua tirannia non si limita alla repressione di alcuni gruppi selezionati e chiusi, di solito i più emarginati e deboli, ma
si rivolge a tutti indistintamente, penetrando nel profondo della vita di ognuno.
Tuttavia non fa uso della forza e non minaccia la morte, degrada gli uomini senza tormentarli. Così viene svelato
l’obbiettivo principale di questo tiranno; esso non minaccia i beni materiali, che anzi promette di salvaguardare e
accrescere, o il corpo, che appaga schiavizzandolo, ma colpisce l’anima e i beni spirituali.
9 Cf. De Tocqueville 1996 10
“ ”
E’ assoluto, particolareggiato, regolare, previdente e mite
Viene paragonato addirittura all’autorità paterna se non per il fatto che “cerca di fissare
11
irrevocabilmente nell’infanzia” i suoi figli.
Lo Stato si occupa dei suoi cittadini e del loro benessere, provvede ad ogni bisogno e
soddisfa ogni necessità con così tanto zelo che ci si chiede 12
“ ”
non potrebbe esso togliere interamente loro la fatica di pensare e la pena di vivere?
La situazione che si creerebbe prevede, quindi, da una parte un’autorità superiore e
dall’altra
“una folla innumerevole di uomini uguali, intenti solo a procurarsi piaceri piccoli e volgari,
con quali soddisfare i propri desideri.
Ognuno di essi, tenendosi da parte, è quasi estraneo al destino di tutti gli altri: i suoi figli e
i suoi amici formano per lui tutta la specie umana; quanto al rimanente dei suoi
concittadini, egli è vicino a esse, ma non li vede; li tocca ma non li sente affatto; vive in se
stesso e per se stesso e , se gli resta ancora una famiglia, si può dire che non ha più
13
patria.”
10 Cf. op. cit.
11 Cf. op. cit.
12 Cf. op. cit.
13 Cf. op. cit.
Edvard Munch, Sera sulla via Karl Johann, 1892. Olio su tela, 84,5x121cm. Bergen, Collezione
14
Rasmus Meyer.
14 In quest’opera la società è interpretata come un luogo dove la solitudine di ciascuno resta incomunicabile: lo
dicono gli sguardi allucinati e stretti nel silenzio dei personaggi ridotti a maschere, ritratti in una passeggiata più
simile a un corteo funebre.
Il dipinto illustra con chiarezza l’atteggiamento critico di Munch nei confronti della borghesia; dal corteo si stacca una
figura nera, che si incammina sulla destra che metaforicamente rappresenta l’artista che si sottrae al controllo sociale
e non chiede consensi né alla classe dominante né alla massa.
Nonostante, dunque, il popolo si trovi in condizione di sudditanza, abbruttito e
massificato, tuttavia non si accorge del suo dominatore, poiché esso agisce di
nascosto, in modo non manifesto.
Scrive Tocqueville:
“ esso non spezza le volontà, ma le infiacchisce, le piega e le dirige; raramente costringe
ad agire, ma si sforza continuamente di impedire che si agisca; non distrugge , ma
impedisce di creare, non tiranneggia direttamente, ma ostacola, comprime, snerva,
estingue, riducendo infine la nazione a non essere altro che una mandria di animali timidi
15
”
ed industriosi, della quale il governo è il pastore
Ecco dunque qual è il successo di un tale Stato: agire “all’ombra della sovranità del
16
popolo” .
L’errore, riscontrato in America, che è causa di tale degenerazione dello Stato è “la
17
scarsa garanzia che vi è contro la tirannide” .








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









