vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
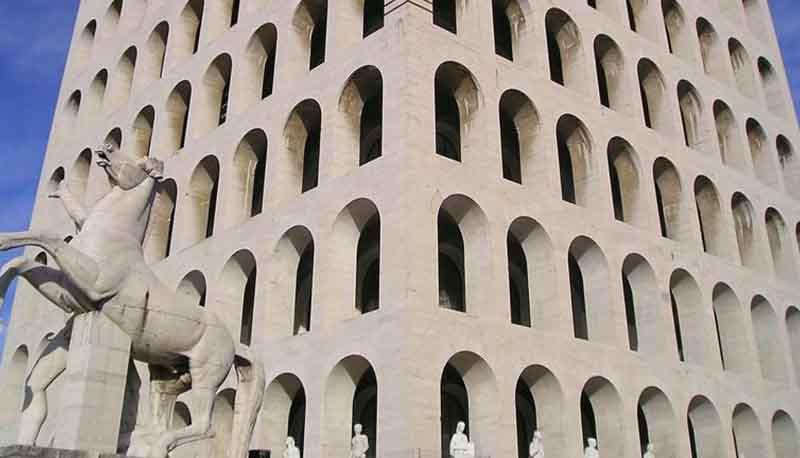
all’occhiello per un partito rivoluzionario. Questo creava un po’ di problemi tra gli
architetti “razionali" che progettavano, sulla spinta dei molti concorsi, secondo
razionalità e classicità.
Il regime fascista diede il via alla progettazione di aree urbane, alla costruzione di
edifici e nuove città come Littoria ( l’attuale Latina), Pomezia, Sabaudia ed Aprilia.
Alcune di queste opere hanno pura funzione propagandistica, altre rappresentano dei
capolavori ed altre ancora degli scempi ( come nel caso di via della Conciliazione a
Roma). Gli edifici eretti in quegli anni avevano un’immagine gelida e cupa seppur
grandiosa, a causa dell’utilizzo del marmo, di facciate con lastre piane, della
ripetizione di forme geometriche come il cubo e il cilindro, il contrasto dei bianchi e
dei neri e l’assenza di decorazioni. Lo scopo principale dell’architetture era quello di
incanalare il gusto popolare in un’estetica che fosse lo specchio fedele del regime
fascista è quello di “ smuovere le masse”.
Questo è l’esempio di una città nata durante
l’età del fascismo in Friuli:
TORVISCOSA
L'attuale centro nacque nel 1938 con la
bonifica delle paludi, effettuata a partire dal
1927, e la fondazione di una fabbrica per la
produzione di fibre artificiali.L'insediamento
sorse a Zuino denominato poi Torre di
Zuino, in antichità è documentato un castello
che sorgeva in questi luoghi dal 1278.
Prima della bonifica, effettuata a partire dal 1927, la zona presentava le caratteristiche
di una palude: la morfologia del terreno non permetteva infatti uno scolo adeguato
delle acque dei corsi d'acqua (in particolare Ausa, Corno, Zumello, Zuina e Storta) e
non esistevano né canali di scolo né argini.Tristemente famosa come area malarica, la
zona vide sporadici tentativi di bonifiche parziali ad opera degli agricoltori locali,
scoraggiati peraltro dalla bassissima fertilità del terreno, sino all'opera di risanamento
conclusiva avvenuta in epoca fascista nell'ambito di un grande progetto di espansione
industriale che le trasformò completamente.Sono di quest'epoca il razionale assetto
viario, arredi, edifici pubblici e abitativi, impianti sportivi e strutture produttive che
ne fanno uno degli esempi più interessanti di pianificazione urbanistica del
Ventennio.Del vecchio paese resta la settecentesca chiesa della Madonna del Rosario
che racchiude diverse opere e una intensa Madonna con Bambino lignea di scuola
tolmezzina (sec. XVI).
I maggiori interpreti dell’architettura fascista furono Marcello
Piacentini, Giovanni Muzio e Giuseppe Terragni.
MARCELLO PIACENTINI
Marcello Piacentini ( casa del fascio a destra ) è il
grande regista della febbrile attività architettonica e
urbanistica del ventennio Fascista.
L’ interesse per l’urbanistica lo portò nel 1937 ad
aprire Via della Conciliazione a Roma, che sfocia in
piazza San Pietro. Nel 1931 viene approvato un
piano regolatore che fa di Roma una fotografia della
politica urbanistica del regime:riqualificazione
monumentale del centro significa apertura di squarci
prospettici nel tessuto urbano ed espulsione verso le borgate dei ceti popolari.
Nel monumentale Palazzo di Giustizia, realizzato tra il 1933 e il 1940, sono già
evidenti le caratteristiche che l’architettura sta assumendo. Il rivestimento marmoreo,
l’esagerata dilatazione delle finestre costituiscono elementi in evidente
contraddizione con l’originale linguaggio razionalista, secondo il quale le dimensioni
dovevano essere suggerite dalle necessità di utilizzo e non certo da quelle della
propaganda ideologica.
Marcello Piacentini è quindi la figura che più di ogni altro dominò l’architettura
Italiana durante il Regime Fascista, i maggiori incarichi pubblici sono suoi ed il suo
stile influenzerà, o in qualche modo verrà imposto non solo a molti architetti negli
incarichi minori ma anche ai maggiori razionalisti come Pagano e Michelacci.
L’esempio più significativo di questa
compromissione lo si avrà per il progetto
dell’Eur o E42, nel quale la presenza di quattro
architetti razionalisti su cinque componenti la
commissione non riesce ad imporre la propria
linea; Piacentini, usando la sua tattica di
mediatore fra tradizionalisti e modernisti, vince,
ed il suo stile trionfa in tutti i sensi nelle
architetture dell’esposizione.
La sua architettura è una sorta di “neoclassicismo semplificato” che può farsi
rientrare in quella serie di tendenze che sono state definite dai critici col termine
“monumentalismo”.
Molte città Italiane vengono monumentalmente ridisegnate, con la demolizione di
fette importanti di centro storico e la ridefinizione dei suoi edifici più importanti in un
ideale collegamento alla “romanità”passata.
Oggi v’e da parte di alcuni una certa rivalutazione del "Neoclassicismo semplificato"
Piacentiniano, e questo è legato al suo apparente collegamento alle forme del Post-
Modern. Un fatto comunque è certo ed accettato da tutti: l’Italia del ventennio è
isolata dal mondo culturale Europeo più evoluto, che propone in architettura i temi
del Movimento Moderno, così questi non sono conosciuti o vengono mal interpretati
dagli architetti italiani.
Il tutto si concentra in dibattito superficiale, che non coglie i caratteri originari
dell’International Style’’ e si riduce ad una modernizzazione esteriore dello stile, con
l’adozione di forme semplificate, murature lisce, balconi pieni, cornici spianate,
capitelli allegeriti, archi elementarizzati , colonne smussate , e così il livello
dell’edilizia pubblica si abbassa notevolmente. In una parola lo stile Piacentini.
Le più importanti realizzazioni della monumentalizzazione Italiana, sono:
• la nuova città Universitaria di Roma sebbene con qualche eccezione;
• E42 di cui molti edifici sono stati progettati da razionalisti;
• Via della Conciliazione a Roma; il centro storico di Brescia;
• Piazza Augusto imperatore sempre a Roma;
• le Città di fondazione, monumentali e di Bonifica;
alcune nuove città sfuggono a questa logica del monumentalismo:
• la città di Sabaudia, progettata tra gli altri da
Luigi Piccinato;
• la città d’oltremare di Portolago in Grecia, nell’isola di Leros del Dodecaneso, che
hanno un impronta decisamente più “moderna”.
GIOVANNI MUZIO Giovanni Muzio nacque a Milano il 12
Febbraio 1893 e nel 1902 si trasferì con la
famiglia a Bergamo dove, nel 1904, muore il
padre Virginio, valido architetto.
Dopo aver frequentato il ginnasio e il liceo,
entra per concorso al collegio Ghisleri di
Pavia dove segue il biennio della facoltà di
ingegneria. Nel 1912 si trasferisce a Milano,
iscrivendosi al terzo anno della Scuola
d’Applicazione per Architetti Civili.
Nel 1915 vive in prima persona l’esperienza della Grande Guerra.
Nel 1926 affronta con i colleghi del Club degli urbanisti la prova del concorso per il
piano regolatore di Milano, riportando con la sigla “Forma Urbis Mediolani, il
secondo premio. Dal 1951 al 1963 è ordinario dell’architettura alla facoltà da
ingegneria di Milano.
Tra le sue opere ricordiamo il Palazzo del Governo di Sondrio, il Palazzo dell’Arte al
Parco Sempione di Milano (immagini triennale di milano sopra e sotto), la basilica
dell’Annunciazione a Nazzareth.
Giovanni Muzio muore a Milano il 21 maggio 1982.
GIUSEPPE TERRAGNI Il primo esempio di architettura fascista
fu un edificio di appartamenti stile
“Novocomun” costruito a Como
( immagini ).
Nel 1932 Terragni conclude il progetto
della famosa “Casa del Fascio”, opera
simbolo del razionalismo italiano.
Sempre a Como negli anni dal 1930 al
1933 viene costruito il Monumento ai
caduti di Como: l’edificio presenta una
struttura di cemento armato sulla quale sono stati posti grossi blocchi di pietra di
Carso, in memoria di dove si erano svolti i combattimenti.
Giuseppe Terragni, Casa del Fascio, Como (1933-36)
A conferma del fatto che si tratta di un razionalismo propriamente italiano, sta il fatto
che Terragni presenta una pianta piuttosto semplificata, quadrilatera; non utilizza il
metodo proprio del razionalismo europeo, l’arretramento della struttura, facendo
sporgere i solai e rendendo in tal modo la facciata indipendente dalla struttura.
Terragni invece utilizza una specie di griglia forata a rappresentare una membrana,
elemento di separazione che non nega la distinzione fra l'interno e l'esterno ma
neanche la conclama come frattura irrimediabile.
Terragni, in altre parole, rifiuta l'ultimo dei cinque punti di Le Corbusier, quello della
facciata libera, e tiene fortemente a rappresentare anche in facciata il vincolo
appositamente scelto di una maglia ortogonale, predeterminata, all'interno della quale
poter scegliere una articolazione interna.
È riconoscibile nella linea progettuale di Terragni l’adozione di precise tipologie. Uno
dei punti più importanti di questa costruzione, ad esempio, è rappresentato dal
“cortile”, il quale si trova in posizione leggermente decentrata, un'interpretazione
della regolarità della maglia ortogonale non vincolata da un principio di simmetria, di
assialità di stampo classico, ma "elaborata". All'interno del cortile è possibile
riconoscere quello che lui stesso definisce "un chiostro di arcaica classicità".
Da un lato è presente l'idea del cortile coperto dal vetro-cemento, dove ancora una
volta l'utilizzo di questo materiale è emblema di alta tecnologia per l'epoca; l'idea
dello spazio utile per le grandi riunioni, per le adunate dei rappresentanti del regime;
dall'altro lato vi è il riferimento tipologico al chiostro della classicità e, al tempo
stesso, alla tipologia del sistema a logge. Si tratta di un cortile che mostra la doppia
altezza dell’edificio attraverso un sistema di loggiati che si affacciano e
rappresentano, in chiave moderna e razionale, la reinterpretazione di una tipologia già
assimilata dalla tradizione architettonica tipica della scuola italiana.
’EUR, un'edilizia politica tra passato e
futuro
Il primo piano urbanistico del quartiere EUR fu
voluto nel 1937 da Mussolini, che intendeva creare
la Terza Roma al di fuori dei confini della città
eterna, lungo un'asse ideale che da piazza Venezia
portava al mare. Il progetto definitivo prevedeva la
realizzazione di palazzi ed infrastrutture con uno
stile architettonico monumentale e scenografico, un
grande spazio per le zone verdi ed altri elementi
naturalistici.
Dopo l'esposizione internazionale del 1935
dovevano passare almeno sei anni prima di poter
organizzare una nuova esposizione che avrebbe
dovuto tenersi, dunque, nel 1941. Per Mussolini
questo evento rappresentava un'occasione propizia per festeggiare il Ventennale del
regime fascista e perciò fece slittare la data di un anno in modo da farla coincidere. Il
1942 è, quindi, l'anno fissato per l'Esposizione Universale di Roma (che dà il nome al
progetto) e per l'inaugurazione del nuovo quartiere.
Nel 1937 il progetto,
precedentemente noto come
"Esposizione del 1941-42", prese il nome
di "E42".
Il progetto dell'insediamento fu affidato
agli architetti Pagano, Piccinato, Vietti ed Ettore Rossi, gruppo diretto da Piacentini
che conferì all'operazione un carattere monumentale e retorico.
Il progetto dell'E42 mirava a trasformare lo spazio espositivo in centro
monumentale della Roma fascista con la conversione delle mostre temporanee legate
alla storia e alla civiltà romane in musei permanenti. La struttura urbanistica si
sviluppava attorno alla via Imperiale (oggi Cristoforo Colombo) e al viale Europa,
avente come centro la Piazza Imperiale racchiusa dai quattro edifici delle mostre:
Etnografica, delle Scienze, dell'Arte Antica e dell'Arte Moderna. "Per creare un
rapporto d'interazione tra il costruito e l'ambiente naturale era previsto un invaso
artificiale con una spettacolare cascata, immerso in un boschetto di eucalipti". Oltre il
lago trovava posto il parco dei divertimenti. Inoltre presso la porta a Sud in direzione
del mare si sarebbe dovuto erigere su progetto di Libera un maestoso arco a tutto
sesto in vetro e alluminio, alto 100 metri, che però non sarà mai realizzato nonostante








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









