vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
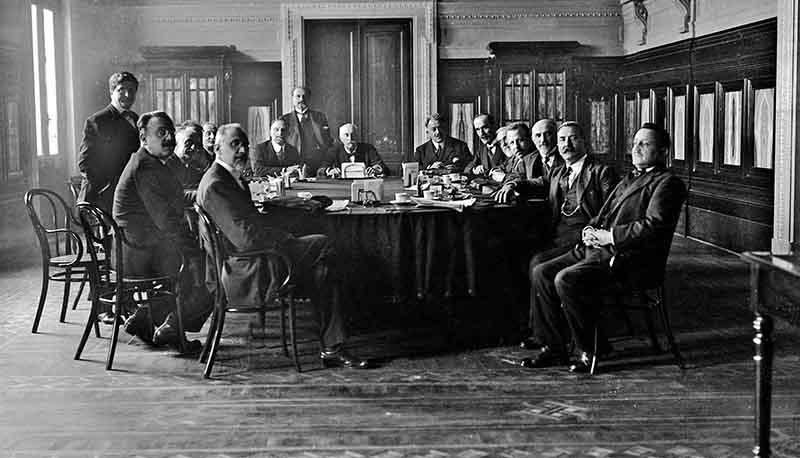
Veronica Zappacosta
5° A i.g.e.a.
a.s. 2007/2008
Istituto Tecnico Statale Commerciale per
Geometri e Turistico “Ferdinando Galiani”
L’ Italia in guerra ai primi del ‘900
e lo Stato
- : L’Italia in guerra ai primi del ‘900
STORIA
- : Gabriele D’Annunzio
LETTERATURA
- : Lo Stato di diritto
DIRITTO PUBBLICO
- : Il bilancio dello Stato
SCIENZA DELLE FINANZE
- : La funzione informativa del
ECONOMIA AZIENDALE
bilancio d’esercizio
- : The United Kingdom
INGLESE
- : Le Président et Le Parlement
FRANCESE
- : Ricerca operative
MATEMATICA
L’ Italia in guerra ai primi del ‘900
La causa della Prima guerra mondiale fu dovuto all’assassinio di Sarajevo il 28
giugno 1914, in cui trovarono la morte l’arciduca d’Austria e la moglie. Ma le
vere cause della guerra furono più complesse.
La prima fondamentale causa fu il contrasto tra Germania e Inghilterra. La
Germania era impegnata nel commercio in Europa e nell’Impero Ottomano e
questo intimoriva Francia e Russia e soprattutto minacciava gli interessi
britannici nel Medio Oriente. neutrale
L’Italia ancora legata alla Triplice Alleanza si dichiarò il 3 agosto del
1914 e ciò provocò proteste dagli interventisti.
Infatti ci fu un dibattito sull’eventualità di intervenire nel conflitto o sul
mantenimento della neutralità ed è per questo che ci fu una divisione tra
neutralisti e interventisti.
Tra i cosiddetti “neutralisti” vi erano:
liberali
- la maggior parte dei ispirati da Giolitti che erano preoccupati
di una guerra a cui si riteneva che il paese non fosse preparato;
cattolici,
- i il cui neutralismo si fondeva sul pacifismo di Benedetto XV
e sulla simpatia per l’Austria;
socialisti
- i che erano spinti da motivi ideologici e dalla
consapevolezza che il prezzo della guerra sarebbe stato pagato
soprattutto dai ceti operai.
Invece tra gli “interventisti” comprendeva:
grande industria,
- la interessata alle commesse pubbliche;
Vittorio Emanuele III
- il re che era favorevole alla guerra cosicché
avrebbe potuto portare un rafforzamento internazionale dell’Italia;
democratici
- i con motivi patriottici erano a favore di una guerra
contro l’Austria che avrebbe potuto portare all’unione di Trento e
Trieste all’Italia;
anarchici sindacalisti rivoluzionari
- e convinti che la partecipazione al
conflitto avrebbe indebolito il capitalismo;
movimento nazionalista
- il che all’interno erano presenti molti
intellettuali di gran nome come il poeta Gabriele D’annunzio e molti
pittori e poeti.
Gabriele D’Annunzio
Nato nel 1863 a Pescara, da agiata famiglia borghese, a soli 16 anni esordì con
“Primo vere” un libretto in versi. A 18 anni si trasferì a Roma, dove abbandonò
gli studi per la vita mondana. E’ qui che iniziò per lui una più brillante
avventura letteraria. Gli anni in cui D’Annunzio acquistò notorietà
attraverso versi, opere narrative, articoli giornalistici, che spesso suscitavano
scandalo per i loro contenuti erotici, erano gli stessi anni in cui lo stesso
D’Annunzio si creò la maschera dell’esteta, dell’individuo superiore, che rifiuta
la mediocrità borghese, rifugiandosi in un mondo di arte, e che disprezza la
morale corrente, accentando come regola di vita solo il bello. Poi
però il poeta entrò in crisi; una crisi dovuta solo al passaggio dal primitivo
estetismo a una diversa mitologia, quella appunto del superuomo, un mito non
più soltanto di bellezza, ma di energia erotica, tutto ciò grazie all’influenza
nietzschiana. Nella realtà D’Annunzio puntava a creare l’immagine di una vita
eccezionale il cosiddetto “vivere inimitabile”, una vita non comune.
D'Annunzio condusse una vita da principe rinascimentale con un dispendio di
denaro che non riusciva a controllare, egli disprezzava il denaro borghese, ma
non poteva farne a meno per la sua vita lussuosa. Proprio per l’immagine
mitica che voleva dare di sé, tentò anche l’avventura politica, schierandosi
prima con la destra e poi con la sinistra.
Ma nonostante la sua fama fosse alle stelle, D’Annunzio, a causa dei creditori,
dovette fuggire dall’Italia rifugiandosi in Francia.
L’occasione per tornare in Italia gli fu offerta dalla Prima guerra mondiale, dove
iniziò una campagna interventista, arruolandosi volontario. Aveva combattuto
una guerra eccezionale non in trincea, ma con un nuovo mezzo cioè l’aereo.
Nel dopoguerra capeggiava una marcia di volontari su Fiume dove aveva
instaurato un dominio personale. Cacciato via, sperava di riproporsi come
“duce” ma fu scalzato da Mussolini. Il Fascismo lo esaltava come padre della
Patria ma lo guardò anche con sospetto confinandolo nel “Vittoriale degli
Italiani”, una villa di Gardone, che egli trasformò in vero mausoleo. Qui
trascorse gli ultimi anni fino alla morte avvenuta il 1° marzo 1938.
Lo Stato di Diritto
GLI ELEMENTI DELLO STATO DI DIRITTO
Lo Stato di diritto è lo Stato in cui è vietato l’arbitrio dei poteri pubblici.
L’arbitrio può essere combattuto imponendo agli organi dello Stato il rispetto
della legge. Lo Stato di diritto è quel regime che si preoccupa non solo che gli
organi dello Stato rispettino la legge ma anche che la legge non sia arbitraria.
Il secondo elemento è l’esistenza di diritti dei singoli cittadini di fronte allo
Stato. Lo Stato di diritto è quello che rispetta i diritti dei suoi cittadini.
Il terzo elemento è la separazione dei poteri, perché avendo troppo potere si
potrebbe tornare in arbitrio. La separazione consente a un organo di tenere a
bada l’altro.
Attraverso la separazione dei poteri, il potere dello Stato viene diviso in tre e
attribuito a tre organi tra loro indipendenti:
- il potere di fare leggi cioè il potere legislativo è conferito al
Parlamento;
- il potere di eseguirle è attribuito al potere esecutivo;
- il potere di applicare le leggi spetta al potere giudiziario.
LO STATO LIBERALE
Una forma di stato di diritto è lo Stato liberale o Stato legale.
L’essenza dello Stato legale è il principio di legalità.
Il principio di legalità significa che nessun atto del potere esecutivo o sentenza
dei giudici sono validi se
a) non si fondano su una legge che li prevede
b) non rispettano i limiti che la legge assegna loro.
Praticamente, in base al principio di legalità il potere esecutivo e il potere
giudiziario sono vincolati al rispetto del diritto. Il potere legislativo è invece
sovrano senza limiti e vincoli.
LO STATO DEMOCRATICO
Un'altra forma di Stato di diritto è lo Stato democratico o Stato costituzionale.
Secondo questo principio la legge è libera di assumere qualsiasi contenuto,
perché il legislatore è onnipotente. Il principio di legalità è stato integrato col
principio di costituzionalità.
Il principio di costituzionalità significa che il legislatore è vincolato al rispetto
del diritto, in particolare delle norme giuridiche contenute nella Costituzione
rigida.
La legge che viola la Costituzione è invalida e può essere eliminata
dall’ordinamento attraverso procedimenti che si svolgono davanti all’organo di
Corte
giustizia costituzionale che nel nostro ordinamento ha il nome di
Costituzionale. Il bilancio dello Stato
PROFILI GENERALI DEL BILANCIO DELLO STATO
Il bilancio dello Stato è un documento giuridico - contabile che elenca le entrate
e le spese relative all’attività finanziaria dello Stato, che può essere un anno
(bilancio annuale) o un periodo di più anni (bilancio pluriennale).
Il bilancio dello Stato può essere classificato in diversi modi.
A seconda del momento in cui viene preparato e agli scopi a cui è diretto, il
bilancio può essere:
preventivo riguarda le entrate e le spese che si prevede di riscuotere e
di effettuare nell’esercizio successivo, e bisogna predisporlo prima
dell’inizio dell’anno di riferimento;
consuntivo si riferisce a un anno già trascorso, e dà conto delle entrate
e delle spese già realizzate in questo esercizio.
Rispetto al contenuto, il bilancio può essere:
di competenza che comprende le entrate che si ha diritto a riscuotere e
le spese che si ha l’obbligo di pagare nel corso dell’esercizio;
di cassa che riporta le entrate effettivamente riscosse e le uscite
effettivamente pagate nel corso dell’esercizio.
LE FASI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
Le entrate e le spese vengono realizzate attraverso varie fasi, le seguenti:
- accertamento, consiste nell’individuazione dell’ammontare del
credito;
- riscossione, che riguarda il guadagno dell’importo accumulato da
parte di agenti incaricati dello Stato;
- versamento, costituito dall’incasso effettivo da parte dello Stato;
Le Spese vengono effettuate attraverso le seguenti fasi;
- impegno, che si ha quando la pubblica amministrazione assume
l’obbligo di effettuare un pagamento;
- liquidazione, costituita dall’individuazione del creditore e dalla
determinazione dell’ammontare preciso della somma da pagare;
- ordinazione, che consiste nell’emissione del titolo di spesa con cui gli
uffici contabili ordinano il pagamento agli organi esecutivi;
- pagamento, che consiste nel versamento di denaro da parte dello
Stato al creditore, estinguendo così l’obbligazione.
Oltre alla funzione contabile, il bilancio svolge anche funzioni altrettanto
importanti, quali:
politica, il rapporto di fiducia tra il Parlamento ed il Governo;
giuridica, rappresenta un autorizzazione preventiva delle spese, che il
parlamento concede all’organo di competenza il compito di dare
esecuzione al bilancio;
economica, perché determina il regolare andamento dei cicli economici.
TEORIA DEL BILANCIO IN PAREGGIO
La teoria del bilancio in pareggio è basata sul principio della finanza neutrale,
cioè lo Stato deve ridurre il suo intervento nella vita economica e svolgere
soltanto le attività istituzionali, quelle non convenienti per i privati, che
consentono il funzionamento del mercato.
TEORIA DEL DOPPIO BILANCIO
Nella teoria del doppio bilancio le spese ordinarie dovevano essere finanziate
con entrate tributarie mentre le spese in conto capitale con l’emissione di titoli
pubblici.
TEORIA DEL BILANCIO CICLICO
Secondo la teoria del bilancio ciclico i bilanci devono compensare l’andamento
del ciclo economico.
TERORIA DEL BILANCIO FUNZIONALE
Questa teoria ci dice che il bilancio pubblico non deve essere solo strumento
contabile, ma deve essere usato come strumento per realizzare gli obiettivi di
politica economica.
LE POLITICHE DI BILANCIO
Le manovre delle entrate e delle spese pubbliche per raggiungere obiettivi di
politica economica sono:
espansiva, se l’obiettivo da raggiungere è l’aumento dell’occupazione e
del reddito;
restrittiva, se è finalizzata alla lotta all’inflazione e al riequilibrio dei
conti con l’estero.
La funzione informativa del bilancio d’esercizio
Il bilancio d’esercizio è il documento redatto dagli amministratori al termine del
periodo amministrativo, con cui si presenta la situazione patrimoniale e
finanziaria dell’azienda e il risultato economico d’esercizio.
Il bilancio d’esercizio svolge un importante ruolo perché fornisce informazioni
essenziali in merito alla consistenza patrimoniale e agli andamenti finanziari ed
economici dell’impresa. Le informazioni possono essere di tipo prospettico
ossia proiettate verso il futuro, e sono ricavabili attraverso l’utilizzo dell’analisi
per indici e l’analisi per flussi.
Il bilancio è senza dubbio quello che risponde maggiormente alle esigenze
conoscitive del pubblico.
Quelli che utilizzano il bilancio sono di due tipi:
i soggetti interni all’impresa, portatori di interessi diretti, ossia il
proprietario o i soci di maggioranza e i lavoratori dipendenti;
i soggetti esterni all’impresa, portatori di interessi indiretti, ossia gli
investitori, i finanziatori, i clienti e i fornitori, insomma tutti i soggetti con
i quali l’azienda entra in contatto.
I soggetti interni sono interessati al grado di redditività degli investimenti
produttivi, perché è in relazione a questo che si valuta la convenienza a








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









