
Il 21 aprile 2025 è morto Papa Francesco, una delle figure più influenti del nostro tempo. Il suo pontificato, iniziato nel 2013, ha segnato profondamente la storia recente, non solo della Chiesa cattolica ma del mondo intero. Primo Papa gesuita, primo non europeo da oltre mille anni, il suo nome – scelto in onore di San Francesco d’Assisi – è diventato simbolo di sobrietà, attenzione agli ultimi e dialogo.
Nel contesto del colloquio orale della Maturità 2025, che si fonda su un approccio multidisciplinare, la figura di Papa Francesco potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza per costruire un percorso coerente tra le materie. La sua attenzione all’ambiente, ai poveri, ai migranti e al dialogo tra le religioni apre infatti a moltissimi collegamenti, dalla Storia alla Filosofia, dall’Italiano alle Scienze Umane.
Qui di seguito ti proponiamo i collegamenti disciplinari che possono aiutarti a costruire un percorso originale e ben strutturato, qualora lo spunto iniziale del colloquio sia proprio incentrato sul Pontefice recentemente scomparso. Ricorda: l’importante non è solo citare l’autore o il tema giusto, ma saper fare collegamenti consapevoli e motivati.
Indice
- Storia: la Chiesa e il mondo contemporaneo
- Filosofia: il valore dell’uomo tra Kant e Marx
- Educazione Civica: diritti, ambiente e cittadinanza attiva
- Arte: misericordia e rivoluzione dell’immagine sacra
- Italiano: Ungaretti, Pasolini e la parola che si fa carne
- Scienze Umane: sociologia e psicologia della povertà e dell’inclusione
- Scienze: ecologia, cambiamento climatico e responsabilità
Storia: la Chiesa e il mondo contemporaneo
Il pontificato di Papa Francesco si inserisce nel quadro della storia globale del XXI secolo, segnato da migrazioni di massa, crisi ambientali e disuguaglianze sociali. La sua visita a Lampedusa nel 2013, poco dopo l’elezione, è diventata un gesto simbolico di grande impatto: una denuncia concreta contro l’indifferenza verso i migranti.
Puoi collegarlo allo studio della globalizzazione, ai grandi flussi migratori, oppure al ruolo della religione nel mondo contemporaneo. È utile anche per approfondire la rinuncia di Benedetto XVI, evento senza precedenti nell’epoca moderna, che ha aperto una nuova stagione nella storia del papato.
Filosofia: il valore dell’uomo tra Kant e Marx
Papa Francesco ha posto al centro del suo pontificato l’idea di dignità della persona e la giustizia sociale. Questi temi si legano bene ad alcuni grandi autori del programma di Filosofia.
Con Immanuel Kant, ad esempio, si può parlare dell’imperativo categorico: agire sempre considerando l’altro come fine e mai come mezzo. È un’idea che risuona nelle parole di Francesco, che ha spesso denunciato le logiche dello scarto e del profitto a ogni costo.
Un altro collegamento possibile è con Karl Marx, soprattutto per quanto riguarda la critica alle disuguaglianze e all’alienazione dell’uomo in una società dominata dall’economia. Anche se da prospettive diverse, entrambi sollevano la questione di come restituire centralità all’essere umano.
Educazione Civica: diritti, ambiente e cittadinanza attiva
Non dimentichiamo poi che il Papa argentino è stato un punto di riferimento mondiale per il richiamo alla responsabilità collettiva. La sua voce è stata autorevole nel difendere i diritti dei migranti, la tutela del pianeta, la dignità del lavoro, tutte tematiche centrali anche nel programma di Educazione Civica.
Il suo magistero può essere legato agli Obiettivi dell’Agenda 2030: in particolare l’obiettivo 10 (ridurre le disuguaglianze), l’obiettivo 13 (lotta contro il cambiamento climatico) e l’obiettivo 16 (pace, giustizia e istituzioni solide). È anche l’occasione per riflettere sul ruolo del singolo nella società, sull’importanza dell’informazione responsabile e della partecipazione democratica.
Arte: misericordia e rivoluzione dell’immagine sacra
Papa Francesco ha rinnovato anche il modo in cui la Chiesa comunica, non solo con le parole ma anche con le immagini e i gesti simbolici. Il suo stile semplice ha influenzato anche la comunicazione visiva del Vaticano, meno sfarzosa e più orientata al volto umano della fede.
Puoi collegare questo stile a opere d’arte che mettono al centro l’uomo, la misericordia, la fragilità. Ad esempio:
-
il Caravaggio della Vocazione di San Matteo o della Maddalena penitente, per il loro sguardo empatico e rivoluzionario;
-
o anche Van Gogh, per il suo modo di restituire dignità agli ultimi (vedi I mangiatori di patate).
Oppure puoi confrontare l’immagine del potere religioso nel passato (come nei ritratti papali del Rinascimento) con quella sobria e comunicativa di Papa Francesco, che ha saputo usare anche i social media in modo diretto e coinvolgente.
Italiano: Ungaretti, Pasolini e la parola che si fa carne
Papa Francesco ha sempre usato una lingua semplice, concreta, accessibile a tutti, quasi poetica. Il suo stile può essere collegato alla ricerca di essenzialità di Giuseppe Ungaretti, ma anche al linguaggio di denuncia e compassione di Pier Paolo Pasolini.
Pasolini, ad esempio, è un autore che ha saputo raccontare con forza le marginalità e gli "scarti" della società – una parola molto cara anche a Papa Francesco. Interessante anche il confronto con Leopardi, se si vuole riflettere sul rapporto tra uomo e natura e sulla condizione umana in un mondo in crisi.
Scienze Umane: sociologia e psicologia della povertà e dell’inclusione
Il concetto di “Chiesa in uscita”, che va incontro alle periferie esistenziali, è perfettamente in linea con il concetto sociologico di inclusione e con l’analisi delle disuguaglianze sociali. Francesco ha più volte parlato dei “nuovi poveri”, di chi viene emarginato nel mondo del lavoro, nella società, nella comunicazione.
Puoi collegarlo alla sociologia della devianza, alle dinamiche di esclusione sociale, oppure alla psicologia dell’empatia e della relazione d’aiuto. Anche temi come l’identità religiosa e il pluralismo possono rientrare in un percorso ben costruito.
Scienze: ecologia, cambiamento climatico e responsabilità
Con l’enciclica "Laudato si’" (2015), Papa Francesco ha fatto qualcosa di inedito: ha parlato di ecologia integrale, cioè di un rapporto tra uomo e natura che tiene conto anche della giustizia sociale. Il suo messaggio è chiaramente in linea con le basi scientifiche del cambiamento climatico, ma le amplia in una visione che unisce scienza, etica e spiritualità.
Un ottimo punto di partenza per collegare il suo messaggio con temi come l’effetto serra, l’impronta ecologica, la sostenibilità. E per riflettere, anche in sede d’esame, su quanto la scienza da sola non basti, se non è accompagnata da una visione etica.




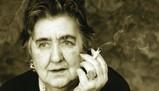


 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo