Concetti Chiave
- I dittonghi e trittonghi si formano con la combinazione delle vocali I e U con altre vocali, mentre lo iato si ha quando queste vocali sono accentate vicino ad un'altra o in un dittongo senza I e U.
- I digrammi e trigrammi sono gruppi di lettere inseparabili che includono combinazioni come ch, gi, gl, gn, sc + vocale per i digrammi, e chi, ghi, gli, sci + vocale per i trigrammi.
- Le parole italiane possono essere classificate in tronche, piane, sdrucciole e bisdrucciole a seconda dell'accento, che cade rispettivamente sull'ultima, penultima, terzultima o quartultima sillaba.
- Il discorso italiano è composto da 9 parti, tra cui 5 variabili (articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo) e 4 invariabili (avverbio, preposizione, congiunzione, interiezione).
- Gli aggettivi si classificano in qualificativi, di relazione e determinativi, con vari gradi di intensità come positivo, comparativo e superlativo, e comprendono anche numerali cardinali, ordinali e moltiplicativi.
Indice
Dittonghi, trittonghi e iati
Si ha un dittongo quando la I o la U si uniscono ad altra vocale;
Si ha un trittongo quando la I e la U si uniscono ad altra vocale;
Si ha uno iato quando la I o la U sono accentate vicino ad un’altra vocale o quando c’è un dittongo senza né la presenza della I, né la presenza della U.
Digrammi e trigrammi
I digrammi sono alcuni gruppi di lettere inseparabili: ch; gi; gl; gn; sc + vocale
I trigrammi sono alcuni gruppi di lettere inseparabili: chi; ghi; gli; sci + vocale
La s impura è la s di alcuni gruppi inseparabili, come ad esempio str.
Per avere una sillaba bisogna avere per forza una vocale. Se si ha un dittongo o un trittongo si ha già una sillaba. Le doppie si separano.
La parola tronca ha l’accento sull’ultima sillaba;
La parola piana ha l’accento sulla penultima sillaba;
La parola sdrucciola ha l’accento sulla terzultima sillaba;
La parola bisdrucciola ha l’accento sulla quartultima sillaba.
Accenti e troncamenti
Il sé si accenta;
Il sì si accenta solo se è affermativo;
Il che si accenta nella parola perché;
Il do non si accenta;
Il da si accenta solo se è verbo dare;
Il fa non si accenta;
Il né si accenta solo quando è negativo;
Il po’ è invece un troncamento.
Elisione e troncamento
L’elisione è la caduta della vocale finale di una parola davanti ad un'altra vocale (una oca = un’oca);
Il troncamento è la caduta di una vocale o di una sillaba alla fine di una parola (frate martino = frà martino).
Il discorso è costituito da 9 parti, 5 variabili e 4 invariabili. Le 5 parti variabili sono: l’articolo, il nome, l’aggettivo, il pronome e il verbo. Le 4 parti invariabili sono: l’avverbio, la preposizione, la congiunzione e l’interiezione.
Articoli e preposizioni
L’articolo precede il nome e concorda in esso in genere e in numero. Tutte le parole che seguono l’articolo diventano sostantivi, perché l’articolo precede sempre e solo un nome.
L’articolo può essere determinativo e indeterminativo:
-determinativo quando il nome che lo accompagna va inteso in modo preciso e determinato;
-indeterminativo quando il nome che lo accompagna va inteso in modo generale e indefinito.
L’articolo può indicare un’intera classe di oggetti, assumere un valore distributivo o introdurre un nuovo elemento nuovo nella comunicazione.
Per indicare un plurale indeterminato si possono adoperare gli articoli partitivi.
Le preposizioni articolate sono delle preposizioni formate da un articolo più una preposizione semplice ( dello = di + lo )
L’articolo indeterminativo può assumere un significato particolare:
-in frasi negative l’articolo può valere uno solo;
-davanti a un numerale, un corrisponde all’avverbio circa;
-in alcuni casi, specie con i nomi di sensazioni, l’indeterminativo rafforza il valore del sostantivo;
-anche l’articolo indeterminativo può essere seguito da un nome proprio quando un, uno o una hanno il valore di un certo, un tale;
-precedono un nome famoso adoperato per antonomasia per indicare qualcuno al livello di;
-sono adoperati per metonimia, cioè quando non indicano direttamente un personaggio, ma qualche oggetto che a lui faccia riferimento (un Guttuso)
-accompagnano un nome seguito da una determinazione (un Totti in gran vena).
Nomi e loro classificazione
Il nome, all’interno della frase può essere soggetto, nome del predicato, apposizione o complemento.
A seconda del significato i nomi possono essere:
-concreti: sono cose che si possono percepire con i sensi;
-astratti: sono cose che non si possono percepire con i sensi, ma solo rappresentare mentalmente;
-comuni: indicano animali, persone e cose in modo generico;
-propri: indicano persone, animali e cose in modo specifico;
-individuali: indicano un solo individuo, oggetto o concetto;
-collettivi: indicano un insieme d’individui, oggetti o concetti;
-maschili: indicano esseri di sesso maschile e oggetti, idee e concetti convenzionalmente considerati maschili;
-femminili: indicano esseri di sesso femminile e oggetti, idee e concetti convenzionalmente considerati femminili;
-singolari: indicano un solo individuo, una sola cosa, un solo concetto, una sola azione o un solo insieme;
-plurali: indicano più individui, cose, concetti, azioni e insiemi;
-primitivi: nomi di base che non derivano da altre parole;
-derivati: derivano da un’altra parola, con l’aggiunta di un prefisso o di un suffisso;
-alterati: con l’aggiunta di un suffisso, modificano il significato della parola da cui derivano;
-composti: si formano dall’unione di due o più parole.
Generi e numeri dei nomi
Il maschile generico è usato molto spesso per indicare gli individui di un
a determinata specie, sia per indicare quelli di sesso maschile, sia quelli di sesso femminile.
Esistono alcuni nomi di cose che presentano due desinenze differenti, una per il maschile e una per il femminile: si tratta di nomi diversi che per il maschile hanno un significato, per il femminile un altro (il banco = la banca).
Un gruppo di nomi di persona e di animale forma il maschile e il femminile da due radici completamente diverse. In questo caso si parla di nomi indipendenti, perché le forme dei due generi sono indipendenti l’una dall’altra (padre = madre).
Alcuni nomi hanno una sola forma valida sia per il maschile che per il femminile e il loro genere può essere distinto solo attraverso l’articolo o l’aggettivo che li accompagna. Si parla di nomi di genere comune (il giornalista = la giornalista).
La maggioranza dei nomi di animali ha un’unica forma per designare sia il maschio sia la femmina. Questi nomi sono detti di genere promiscuo e in questi casi per distinguere il maschile dal femminile si aggiunge la parola maschio o femmina (la volpe = la volpe maschio- la volpe femmina).
Alcuni nomi conservano al plurale la stessa forma del singolare (i caffè = il caffè).
Alcuni nomi non si adoperano mai al plurale, ma solo al singolare (la pietà non può diventare le pietà).
Alcuni nomi non si adoperano mai al singolare, ma solo al plurale (le mutande non può diventare la mutanda).
Aggettivi e loro funzioni
L’aggettivo accompagna il nome per indicarne una qualità o per determinarlo meglio. L’aggettivo si riferisce sempre ad un nome e ne condivide genere numero e funzione sintattica.
Gli aggettivi si distinguono in qualificativi, di relazione e determinativi.
-gli aggettivi qualificativi esprimono una qualità particolare di ciò che il nome indica precisandone l’aspetto, la forma, il colore, le qualità morali o intellettuali.
-gli aggettivi di relazione sono aggettivi derivati tramite particolari uscite ed esprimono una relazione con il nome da cui derivano.
-gli aggettivi determinativi individuano altre informazioni relative a ciò che il nome indica.
Gli aggettivi determinativi possono essere: possessivi; dimostrativi; indefiniti; interrogativi ed esclamativi e numerali.
Esistono anche degli aggettivi composti, formati da due aggettivi (emiliano-romagnolo).
Gradi degli aggettivi
L’aggettivo qualificativo si distingue in tre gradi: positivo; comparativo e superlativo.
-il grado positivo attribuisce ad un nome una certa qualità senza precisarne l’intensità e senza fare riferimento ad altri termini di confronto (Anna è simpatica = non sappiamo se è più o meno simpatica di un’altra persona)
-il grado comparativo attribuisce ad un nome una qualità mettendola a confronto con la stessa qualità posseduta da un’altra persona (Anna è più simpatica di Laura)
-il grado superlativo attribuisce ad un nome una qualità esprimendola al massimo livello in due modi: assoluto (senza termini di riferimento); relativo (facendo riferimento ad un gruppo di persone o cose).
Comparativi e superlativi
Paragonando due persone, animali o cose sono possibili tre risultati:
-il comparativo di maggioranza (A è maggiore di B). La qualità è più presente nel primo che nel secondo termine di paragone.
-il comparativo di minoranza (A è minore di B). La qualità è presente meno nel primo che nel secondo termine di paragone.
-il comparativo di uguaglianza (A è uguale a B). La qualità è presente in misura uguale nei due termini messi a confronto.
Ci sono anche altri termini di paragone, come il superlativo relativo e il superlativo assoluto:
-il superlativo relativo è molto simile al comparativo di minoranza e maggioranza, ma a differenza di questi, nel superlativo i due avverbi sono sempre preceduti dall’articolo determinativo. Nel superlativo relativo si indica una posizione di primato di un elemento rispetto ad un gruppo.
-il superlativo assoluto indica una qualità al massimo grado, senza termini di confronto o di riferimento. Solitamente si forma con il suffisso –issimo aggiunto all’aggettivo di grado positivo, ma ci sono delle particolarità quali l’aggiunta del suffisso –errimo (acre-acerrimo; celebre-celeberrimo; integro-integerrimo) ed –entissimo (maledico-maledicentissimo; benefico-beneficentissimo; benevolo-benevolentissimo).
Aggettivi numerali
Gli aggettivi numerali possono essere cardinali, ordinali, moltiplicativi.
-i numeri cardinali si distinguono in: primitivi (i numeri da uno a dieci, venti, trenta ecc.); derivati (quelli delle decine in –anta e delle miglia glia in –mila); composti (i numeri da undici a diciannove e tutti gli altri).
-i numerali ordinali sono normali aggettivi variabili in genere e in numero (primo, secondo, terzo).
-i numerali moltiplicativi si distinguono in due serie: doppio e le forme in –plo (triplo, quadruplo); le forme in –plice (duplice, triplice).
Domande da interrogazione
- Cosa definisce un dittongo, un trittongo e uno iato?
- Qual è la differenza tra elisione e troncamento?
- Come si distinguono le parole tronche, piane, sdrucciole e bisdrucciole?
- Quali sono le parti variabili e invariabili del discorso?
- Come si classificano i nomi in base al significato?
Un dittongo si ha quando la I o la U si uniscono ad un'altra vocale; un trittongo quando la I e la U si uniscono ad un'altra vocale; uno iato quando la I o la U sono accentate vicino ad un’altra vocale o quando c’è un dittongo senza né la I né la U.
L'elisione è la caduta della vocale finale di una parola davanti ad un'altra vocale, mentre il troncamento è la caduta di una vocale o di una sillaba alla fine di una parola.
Le parole tronche hanno l’accento sull’ultima sillaba, le piane sulla penultima, le sdrucciole sulla terzultima e le bisdrucciole sulla quartultima.
Le parti variabili sono l’articolo, il nome, l’aggettivo, il pronome e il verbo; le parti invariabili sono l’avverbio, la preposizione, la congiunzione e l’interiezione.
I nomi possono essere concreti, astratti, comuni, propri, individuali, collettivi, maschili, femminili, singolari, plurali, primitivi, derivati, alterati e composti.




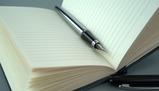





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo