Concetti Chiave
- La destra e sinistra hegeliana rappresentano due correnti opposte dell'idealismo di Hegel: la sinistra critica la religione e privilegia un approccio materialistico, mentre la destra cerca di conciliare religione e filosofia in senso trascendentale.
- Feuerbach, esponente della sinistra hegeliana, è noto per il suo ateismo filosofico e per ribaltare la concezione di Hegel, sostenendo che l'uomo e la natura sono la vera realtà, non un concetto ideale come Dio.
- Karl Marx, influenzato da Feuerbach, sviluppa una teoria materialistica della storia e della società, introducendo il concetto di lotta di classe e proponendo la rivoluzione come mezzo per superare il capitalismo.
- La Scuola di Francoforte, nata nel 1922, critica il capitalismo e mira a ripristinare il marxismo, analizzando le contraddizioni della società moderna e sostenendo la necessità di una società libera dallo sfruttamento.
- Adorno e Horkheimer, membri della Scuola di Francoforte, sottolineano l'alienazione e la manipolazione culturale nella società capitalistica, criticando la ragione strumentale che domina la natura e gli uomini.
Destra e sinistra Hegeliana: due correnti nate in opposizione all’idealismo. Hegel affermava che religione e filosofia esprimevano lo stesso contenuto in due forme distinte, la prima nella rappresentazione, la seconda nel concetto.
Indice
Sinistra hegeliana e Feuerbach
• Sinistra: approfondisce il concetto di natura tramite una concezione materialistica. Questi credono che ci sia una diversità tra rappresentazione e concetto, concependo la filosofia come distruzione della religione: credono nell’inconciliabilità fra concetto e rappresentazione e cercano di fare della filosofia uno strumento di contestazione razionale della religione.
o Feuerbach (1804-1872)
o Marx (1816-1883)
• Destra: interpreta l’idea di Hegel in senso trascendentale: afferma l’esistenza di un Dio, conciliandola col materialismo. Questi ritenevano vi fosse un’identità tra rappresentazione e concetto e concepivano la filosofia come conservazione della religione. Amputando i concetti immanenti di Hegel e adattando la sua dottrina a quella cristiana, questi cercano di, tramite una sorta di scolastica dell’hegelismo, dare una giustificazione razionale delle credenze religiose. I rappresentanti sono Goschel, Conradi, Gabler.
Fondatore dell’ateismo filosofico ottocentesco: opere fondamentali sono “Critica della filosofia hegeliana (1839)”, “L’essenza del cristianesimo” e “L’essenza della religione”. La sua esigenza è di cogliere l’uomo e la realtà nella loro concretezza: capovolge la concezione di Hegel, secondo il quale il concreto era un attributo subordinato all’astratto. Egli afferma che invece è l’astratto ad essere attributo del concreto, rovesciando così i rapporti tra soggetto e predicato. Se per Hegel la natura è inadeguata e non esprime il principio ideale, Feuerbach, partendo dalla natura, afferma che il pensiero è inadeguato alla realtà. L’inizio della filosofia non è un concetto ideale quale Dio, ma la natura. Egli ha un interesse per l’uomo, per quello che è: si parla di umanismo (uomo soggetto discorso) integrale e naturale (fa della natura la realtà da cui tutto dipende), non astratto ma concreto (tanto da dire l’uomo è ciò che mangia, essendo così cosciente dell’unità psicofisica dell’uomo), riguardante una componente psicosomatica (corpo) e una psichica, influenzata da pensieri e sentimenti. L’uomo non può vivere da solo, gli altri sono infatti necessari per raggiungere la moralità. Anche la verità è raggiunta solo tramite l’altro: una conoscenza particolare di un uomo ha valore solo quando viene confermata da un altro individuo. L’essenza dell’uomo è quindi dato della comunità. Egli critica inoltre la religione: non è più Dio (astratto) ad aver creato l’uomo (concreto), ma viceversa. Dio non esiste, è una creazione umana, è la proiezione illusoria delle aspirazione umane che l’uomo non può realizzare: Dio è l’uomo, o meglio l’alienazione delle speranze dell’uomo (che appaiono realizzate), fuori da se (nella teologia c’è quindi l’antropologia). Adorando Dio l’uomo adora se stesso. La religione supera l’antitesi, e l’essere in cui è abolita è Dio: l’uomo è illimitato nel desiderio ma limitato nella vita.
Marx e il materialismo storico
Nasce nel 1818 da famiglia ebrea e muore nel 1883. La sua opera principale è “Il capitale” (1867) (ma anche il “Manifesto del partito comunista” del 1848), in cui compie un’analisi economica della società (confrontando la stratificazione sociale con il passato). Le classi sono distinte in base alla proprietà: la società è inoltre controllata tramite la propaganda. L’obbiettivo marxista è di portare le classi alla coscienza di classe che devia dagli interessi di chi comanda, e porta inevitabilmente alla rivoluzione. Il vanto marxista in campo sociologico è proprio quello di dare il concetto di classe: si sviluppa nella sociologia un senso critico, dovendo tener conto di questa coscienza e delle varie visioni soggettive della società. Come Feuerbach Marx ha una visione materialistica della realtà, e ne accetta inoltre in concetto di autoalienazione religiosa, da distruggere e risolvere nell’esistenza terrena per Marx. Secondo Marx però Feuerbach non ha individuato le cause dell’alienazione dell’uomo: questa è per Marx la situazione sociale intollerabile che porta l’uomo all’immaginazione. L’unica soluzione coincide con l’azione pratica, non contemplativa. Per Marx l’essenza della realtà è la materia intesa come natura in continuo sviluppo, da cui derivano uomo e società. Questo sviluppo avviene tramite una dialettica materialistica di stampo hegeliano. La tesi (le necessità economiche dell’uomo), ostacolata dall’antitesi (ovvero ciò che impedisce di soddisfare queste necessità), si risolve nella sintesi (il superamento di questi ostacoli). Con il concetto di materialismo storico si indicano le necessità umane prettamente economiche e materiali. La società si divide così in:
• Struttura: ovvero l’economia, base della vita sociale, e ciò che distingue l’uomo dall’animale.
• Sovrastruttura: elementi spirituali della società, riflesso della struttura economia, essi non hanno valore autonomo (religione, filosofia, morale, politica, arte, ideologia).
Dialettica e struttura sociale
A differenza di Hegel (che proponeva una dialettica della ragione), Marx propone una dialettica materialistica: in essa la sintesi non conserva la tesi ma la supera. Il processo dialettico è continuo, in quanto sopraggiungo nuove necessità: la storia si configura come l’attuazione di questo processo dialettico, di stampo sempre materialistico. Proprio la storia è inoltre divisibile in 5 tappe:
• Economia primitiva: non esisteva la proprietà privata e di conseguenza nemmeno lo sfruttamento.
• Regime di schiavitù: nasce la proprietà privata, la schiavitù, lo sfruttamento e quindi l’odio e la lotta di classe.
• Società feudale: si passa da schiavitù a servilismo; lo sfruttato è il servo della gleba.
• Regime capitalistico borghese: in seguito alla rivoluzione industriale, i capitalisti concentrano nelle loro mani i mezzi di produzione; si instaura la lotta capitalisti proletari. Il processo produttivo cambia: da uno di sussistenza a uno capitalista.
• Società proletaria: conclusione del processo dialettico; i proletari compiono una rivoluzione contro lo stato. La coscienza di classe promossa da Marx è meno presente nei proletari , in quanto privi di mezzi per conoscere. Il progetto politico di Marx era quello di dare ai proletari una coscienza di sé: ciò avviene tramite la rivoluzione in questa fase.
Il socialismo di Marx è un socialismo scientifico perché analizzò la società senza preconcetti (senso critico soggettivo), arrivando a conclusioni scientifiche (dialettica). Marx teorizza la distruzione del capitalismo: ciò avverrà perché i piccoli produttori verranno rovinati dalle grande industrie; aumenterà la produzione grazie ai macchinari ma diminuirà il numero di operai e lo stipendio: da questa situazione nascerà la rivoluta contro i capitalisti e si instaurerà una dittatura del proletariato. I capitali si sono formati tramite un furto, uno sfruttamento nei confronti del proletariato: la differenza tra il salario (prodotto tra salario orale e ore di lavoro) e il prezzo di vendita di un prodotto è detto plusvalore. Questo permette al capitalismo di arricchirsi sempre più a scapito del lavoratore. Per affrettare il tramonto del capitalismo bisogna:
• Distruggere la famiglia: l’organizzazione che permette di passare i beni di padre in figlio.
• Annullare la patria: perché porta al nazionalismo e a guerre.
• Far scomparire la religione: oppio dei popoli che non sa vedere la realtà essendo asservita ai capitalisti.
• Abolire la proprietà: che porta allo sfruttamento.
Questo tipo di analisi porterà a riforme sociali, mirando alla giustizia fra gli uomini, cercando di abolire i privilegi. Essa però annulla l’integrità dell’uomo riducendo la realtà a una realtà economica e materiale: Marx nega valori fondamentali per l’uomo (moralità, famiglia ecc…). Per aumentare il plusvalore deve essere abbassato il salario dell’operaio (capitale variabile rispetto a quelli invariabili, quali i costi dei materiali): l’operaio inoltre è costretto a lavorare di più per aumentare un plusvalore di cui non usufruirà mai. Chi ha i mezzi di produzione esaspera l’aumento di plusvalore, riducendo al minimo i salari, impoverendo gli operai ma anche avendo una produzione altissima che porta a mancanza della domanda, a crisi di sovrapproduzione e a una competitività del mercato. Il prodotto non ha più la funzione di soddisfare i bisogni di chi lo produce: tra prodotto e produzione vi è una alienazione che genera disinteresse; il produttore dovrebbe usufruire del prodotto e non di una minima parte di esso sotto forma di guadagno. Il superamento del capitalismo avverrà tramite il comunismo dove non esisteranno più le classi, non ci sarà divisione tra produttore e prodotto e i mezzi di produzione saranno di proprietà comune. Venendo meno le classi e lo sfruttamento, viene meno la sovrastruttura ideologica. La proprietà privata è trasformata in proprietà di tutti; in una seconda fase avverrà la vera abolizione della proprietà privata.
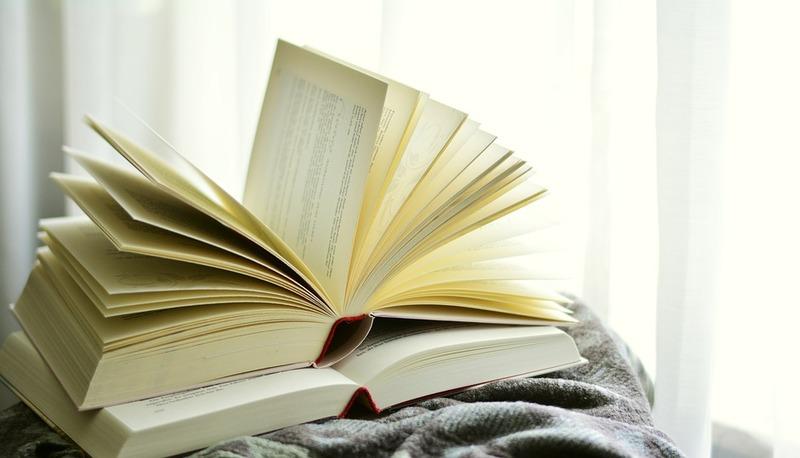
nasce nel 1922, in continuazione al marxismo. L’obbiettivo è quello di ripristinare il marxismo. Nasce a Francoforte come istituto della ricerca sociale, a cui parteciperanno filosofi, sociologi, storici ed economisti. Questo movimento critica la società del tempo per far emergere le contraddizione del capitalismo. Il teorico critico mira alla formazione di una società priva di sfruttamento; si vuole ripristinare la libertà dell’uomo combattendo l’alienazione; ci si rifà a Marx, Hegel, Freud. Questo è il periodo del dopo guerra, con alle spalle l’esperienza di regimi totalitari e del trionfo del progresso. Dapprima si cerca la rivoluzione, ma poi si perda la fiducia in essa in quanto, analizzando i regimi politici, ci si rende conto del primato dello Stato non della società. In questa fase il capitalismo è stato istituzionalizzato: si parla di capitalismo di stato. Con la presa di potere di Hitler molti appartenenti a questa scuola sono emigrati: nonostante ciò si fecero analisi sulle ambiguità della autorità, e sulla tecnologia avanzata presente nella società.
La razionalità è l’interpretazione negativa dell’uomo e della natura, che porta alla distruzione dell’uomo. Teorizza l’istituzionalizzazione del capitalismo come legge economica, da cui scaturisce in forma politica il fascismo, verità della società moderna. Il comunismo è per questo aspetto uguale al fascismo. Opera principale è “Eclissi della ragione”: qui analizza la razioanlità, fondamento della società, vista in modo negativo perché è nata dal bisogno umano di dominare la natura (sostiene la malattia della ragione in opposizione a positivismo e illuminismo e idealismo). Per dominare la natura l’uomo si è servito di un’organizzazione burocratica e impersonale che ha agito impersonalmente riducendo l’uomo a uno strumento, soprattutto nei regimi totalitari: il progresso a disumanizzato l’uomo. Il pensiero può servire a scopi negativi o positivi ma non porta alla verità oggettiva e impersonale poiché ciò va al di la della ragione: non deve quindi stabilire norme sociali, che devono essere stabilite da altre forze. La ragione della società industriale è soggettiva, ha mutato i fini con i mezzi. La ragione non può quindi portare a realtà obbiettive. Questa decadenza del pensiero favorisce l’obbedienza ai poteri costituiti e riduce l’uomo in questo sistema burocratico. La ragione si può quindi dividere in:
• Ragione oggettiva: universale che dovrebbe fondare la realtà, quella dei grandi sistemi filosofici di Platone e Aristotele.
• Ragione soggettiva: si limita a valutare l’efficienza dei mezzi nella società industriale, persegue come unico scopo il dominio della natura e degli uomo, risolve la razionalità nella funzionalità (sapere nella tecnologia)
L’obbiettivo della società industriale è dominare la natura, e ciò tende a rovesciarsi in un dominio dell’uomo sull’uomo. Il prezzo di questo processo è il decadimento di libertà e felicità (episodio Odissea, primo documento borghese occidentale dove il signore, Ulisse, può godere del richiamo pur alienato nel suo ruolo sociale). La verità è intesa come utilità. Un ragione di questo tipo crea nell’uomo le esigenza della produttività. Il pensiero mira ad aumentare la produzione, l’uomo diventa quello che produce. Chi controlla il lavoro, domina gli altri: nella massa l’uomo è annullato. Va criticata la visione utilitaristica della ragione: la filosofia può essere un mezzo per aiutare l’uomo a uscire da questo sistema. Successivamente si stacca dal marxismo negando l’assolutizzazione di ogni cosa, marxismo compreso. Esso è un’illusione e prometteva una rivoluzione inutile in quanto il proletariato è migliorato senza essa. Non c’è più solidarietà e coscienza di classe ma solidarietà universale tra tutti gli uomini che hanno in comune l’interesse a migliorare la vita. Si cerca un mondo dove anche lo spirito possa essere sviluppato: l’uomo ha bisogno di una teologia, intesa come speranza di giustizia, in un mondo ingiusto. La teologia è la rappresentazione della nostalgia e aiuta l’uomo a non farsi ingannare dalle convinzione che la società propone. È differente per questa apertura teologica rispetto a Marx. Dio perciò è una speranza in quanto in una situazione così dolorosa non si può credere ciecamente, ma diventa stimolo nell’agire umano.
Adorno e la dialettica negativa
Opera principale del 1966 è “La dialettica negativa” con cui si oppone a Hegel, secondo il quale la dialettica concilia gli opposti. Secondo Adorno invece la dialettica, strumento di comprensione del reale, nega l’identità tra realtà e pensiero e afferma le contraddizione non conciliate (sintetizzate) che caratterizzano il mondo: non si coglie l’essenza del reale. Attraverso il pensiero non si coglie la totalità della realtà, perciò il filosofo non deve pretendere di cogliere il reale per mezzo del pensiero, questa è un’illusione, e lo dimostra la storia (positivismo, illuminismo, marxismo) in quanto le correnti positive, che cercano di giustificare gli eventi, hanno mascherato le contraddizioni della realtà. Adorno si stacca da queste correnti e vede la realtà com’è: non vi è sintesi, non si isolano gli opposti (come era in Hegel), e il solo compito della dialettica negativa è di portare alla luce il non identico, evidenziando il diverso, il contraddittorio, cancellando il mito della “totalità pacificata”. Egli è infatti promotore di una filosofia materialistica, non più idealista. Per questo la filosofia del dopo Auschwitz (simbolo del fallimento delle precedenti dottrine) assume un ruolo centrale e rivoluzionario. Questo si contrappone alla cultura omologata dal capitalismo. Questa immagine positiva da un’immagine distorta della realtà che favorisce l’asservimento al potere. La società tecnologica usa come mezzo l’industria culturale, ovvero i mass media, mezzo di manipolazione delle coscienze usato dal sistema per conservare se stesso. I Mass media impongono valori e modelli che omologano gli uomini, facendogli perdere la loro individualità e creatività, trasformandoli in passivi. L’uomo è quindi essere generico, indifferenziato dalla massa. Il tempo libero e in particolare il divertimento deve essere un tempo di ricreazione, dove è necessaria la componente creativa, geniale. Anche qui però l’industria stabilisce il divertimento annullando la creatività: in questi processi l’uomo è inconsapevole. L’illuminismo volendo sfatare miti ne sta creando altri, contrariamente a ciò che si prefissava. La visione è pessimistica. Adorno a differenza di Horkheneimer accetta la speranza e la possibilità dell’uomo di agire: la ragione ha trasformato il mondo in un concetto manipolabile e soggiogabile.
Marcuse e la repressione degli istinti
Il suo pensiero è una sintesi tra il pensiero di Freud e Marx. Le opere principali sono “Eros e civiltà”, “Ragione e rivoluzione” e “L’uomo ha la sua dimensione”. In eros e civiltà del 1955 egli afferma che la civiltà si è sviluppata grazie alla repressione degli istinti, della ricerca del piacere. La società ha fatto aumentare la produzione impedendo all’uomo le soddisfazioni naturali. Come Freud egli considera la repressione degli istinti come un costo inevitabile della società e fa inoltre riferimento alla società di classe e a tutti i tipi di società. La società sottomette l’uomo al principio della prestazione: tutte le energie dell’uomo sono impiegate nel lavoro e nella produttività. Il corpo e l’eros vengono diserotizzati: l’eros è funzionale solo alla riproduzione, non per il piacere. Il fine della vita non è più la condivisione del piacere con gli altri ma è la fatica, il lavoro. Ciò diventa un concetto inevitabile per l’uomo. Nell’inconscio dell’uomo questi impulsi sono però rimasti: la dimensione estetica si può manifestare nell’arte. Orfeo e narciso sono l’emblema della ribellione dell’uomo contro la logica della produttività: l’uomo dovrebbe tornare alla ricerca del piacere, a una risessualizzazione. Se l’energia sessuale, funzionale alla riproduzione, si sviluppa quella erotica, ovvero il piacere, no. La liberalizzazione sessuale frutto della società reprime paradossalmente l’erotismo. La ricerca di piacere è l’unico modo di esprimere l’individualità in una società repressa: la società però liberalizzando i costumi ha tolto questo ambito individualistico all’uomo perciò nella realtà industriale è venuto meno il conflitto eros realtà, e la liberà è stata così tolta. Il progresso ha portato alla repressione
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali differenze tra la destra e la sinistra hegeliana?
- Qual è il contributo principale di Feuerbach alla filosofia?
- Come Marx differisce da Feuerbach nella sua analisi dell'alienazione?
- Qual è l'obiettivo della Scuola di Francoforte?
- Quali sono le critiche di Adorno alla dialettica hegeliana?
La sinistra hegeliana adotta una concezione materialistica, vedendo la filosofia come uno strumento di contestazione razionale della religione, mentre la destra interpreta l'idea di Hegel in senso trascendentale, cercando di conciliare l'esistenza di Dio con il materialismo.
Feuerbach è noto per aver fondato l'ateismo filosofico ottocentesco, criticando la religione e affermando che Dio è una creazione umana, una proiezione delle aspirazioni umane.
Marx accetta il concetto di autoalienazione religiosa di Feuerbach, ma critica la sua mancanza di analisi delle cause sociali dell'alienazione, proponendo che l'unica soluzione sia l'azione pratica e rivoluzionaria.
La Scuola di Francoforte mira a ripristinare il marxismo, criticando la società capitalista e cercando di formare una società priva di sfruttamento, combattendo l'alienazione e promuovendo la libertà dell'uomo.
Adorno critica la dialettica hegeliana affermando che non concilia gli opposti, ma piuttosto evidenzia le contraddizioni non risolte del mondo, opponendosi all'idea di una totalità pacificata e promuovendo una filosofia materialistica.







 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo