Concetti Chiave
- Nel Canto IV dell'Inferno, Dante esplora il Limbo, il primo cerchio infernale, luogo di eterni sospiri per coloro che non hanno ricevuto il battesimo.
- Il Limbo ospita non solo bambini, ma anche adulti virtuosi che non conobbero Cristo, vivendo nel desiderio di Dio senza speranza di salvezza.
- Dante introduce un'idea poetica di privilegio per alcuni giusti non battezzati, creando nel Limbo un'area luminosa per gli "spiriti magni".
- Gli "spiriti magni", come Omero e Aristotele, vengono onorati per i loro meriti terreni, rappresentando l'eccellenza in un contesto di eterna oscurità.
- Dante descrive gli spiriti del Limbo attraverso categorie emblematiche, con pochi segni distintivi, evidenziando la loro natura esemplare nel poema.
Canto IV dell'Inferno
Col canto IV siamo nel primo dei nove cerchi infernali (Limbo) nei quali Dante distribuisce i dannati. Limbus significa in latino "orlo": i teologi insegnavano, non senza sottili dispute tra loro, che nell'orlo superiore dell'Inferno, o Limbo, avevano avuto sede i patriarchi e i profeti e forse tutti i credenti ebrei prima che Cristo dopo la sua morte terrene scendesse laggiù per liberarli e portarli con sé in Paradiso; e vi avevano sempre sede i bambini morti prima di ricevere il battesimo.Il Limbo dantesco è immerso nelle tenebre, ed è naturalmente anch'esso soggetto alla legge infernale dell'eternità: non vi si soffre per pene sensibili, ma per un desiderio di Dio, in eterno senza speranza. Non pianti, ma sospiri: che tuttavia fanno tremare l'aria. Nel Limbo, trattando un tema interpretato dai teologi, Dante colloca anche "turbe...molte e grandi", composte, oltre che di bambini, di "femmine e di viri". Sono adulti che si trovano in condizione analoga a quella degli infanti: non peccaro, anzi alcuni di loro ebbero mercedi, meriti terreni; ma ciò "non basta perché non ebber battesmo, / ch'è porta de la fede"; insomma non credettero in Cristo.
Il problema del Limbo
L'uomo, per distinguersi dai bruti, deve adempiere nel grado massimo consentitogli senza naufragare nella superbia il dovere assegnatogli in terra da Dio; deve esercitare al massimo le sue qualità naturali, cioè le virtù cardinali e intellettuali. Queste, senza battesimo, non potranno salvarlo; ma è possibile, si domanda Dante, che i meriti terreni restino senza riconoscimento alcuno nell'oltremondo? A tale problema Dante dà soluzione non propriamente teologica, ma poetica, immaginando con la scorta di Virgilio, nel privilegio del Limbo da lui stabilito per i giusti senza battesimo, un ulteriore privilegio per alcuni di essi, cioè per coloro che tra loro eccelsero.Anche per costoro non ci può essere che il Limbo, ma un luogo appartato in esso, luminoso, mentre nel resto del cerchio c'è buio. Dante li chiama gente di molto valore, "spiriti magni". Oltre al gruppetto di poeti composto da Orazio, Ovidio e Lucano e capitanato da Omero, c'è tra questi magnanimi una schiera di personaggi troiani e romani, combattenti per l'edificazione di Roma, voluta dalla Provvidenza: a cominciare da Elettra, madre di Dardano fondatore di Troia, sino a Cesare. Poi, intorno ad Aristotele, il filosofo per eccellenza, "'l maestro di color che sanno", e di altri due poeti, Orfeo e Lino, che sono in questo gruppo perché tradizionalmente considerati i primissimi poeti-teologi.
Gli spiriti del Limbo
Gli spiriti del Limbo si onorano l'un l'altro: Omero incita gli altri poeti a rendere onore a Virgilio; tutti fanno onore a Dante salutandolo, di che Virgilio magnanimamente si compiace, e ammettendolo nella loro schiera. I componenti della filosofica famiglia mirano Aristotele, e "tutti onor li fanno". Ognuno accetta il giusto riconoscimento dei propri meriti: "fannomi onore, e di ciò fanno bene", dice esplicitamente Virgilio; Dante da parte sua non ha alcuna remora a registrare di esser sesto tra cotanto senno, tra così illustri poeti; e aggiunge che vedendo gli altri magnanimi s'innalza in sé stesso, riconoscendosi dei loro.Il magnanimo ha, per Dante, caratteristiche di costume e di atteggiamento, alle quali il poeta resta sempre fedele nelle sue raffigurazioni.
Un'ultima osservazione sta nel fatto che il poeta procede per categorie, non per individui. Abbiamo anche qui un puro elenco paradigmatico di nomi; e la loro paradigmaticità ed emblematicità sono rafforzate dallo stesso disordine interno in cui sono disposti; e dal fatto, su cui Dante richiama la nostra attenzione, che essi sono solo esempi.
Solo Omero e Cesare hanno segni esteriori che sembrerebbero individualizzarli, ma si tratta di segni anch'essi emblematici, che tendono alla riconoscibilità degli esempi: dalla qualità di poeta epico l'uno, della qualità di guerriero l'altro.
Domande da interrogazione
- Qual è il significato del Limbo nel Canto IV dell'Inferno di Dante?
- Come Dante risolve il problema del riconoscimento dei meriti terreni nel Limbo?
- Chi sono gli "spiriti magni" e quale ruolo hanno nel Limbo?
- Qual è l'atteggiamento di Dante verso gli spiriti del Limbo?
- Come Dante rappresenta gli spiriti del Limbo nel suo poema?
Il Limbo è il primo cerchio dell'Inferno dove si trovano i non battezzati, come i bambini e gli adulti virtuosi che non hanno conosciuto Cristo. Non soffrono pene fisiche, ma vivono nel desiderio eterno di Dio senza speranza.
Dante immagina un privilegio poetico per i giusti senza battesimo, creando un luogo luminoso nel Limbo per gli "spiriti magni", coloro che eccelsero per meriti terreni, come poeti e filosofi illustri.
Gli "spiriti magni" sono figure illustri come Omero, Aristotele e Cesare, che ricevono onore e riconoscimento per i loro meriti terreni. Essi rappresentano un'eccezione nel Limbo, vivendo in un'area luminosa.
Dante si sente onorato di essere accolto tra gli spiriti magni e riconosce il loro valore. Egli si eleva in sé stesso vedendo gli altri magnanimi, accettando il giusto riconoscimento dei propri meriti.
Dante procede per categorie, elencando nomi emblematici senza un ordine preciso. Solo Omero e Cesare hanno segni distintivi, ma anche questi sono emblematici, sottolineando la loro qualità di esempi paradigmatici.

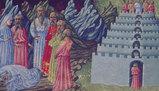





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo