Concetti Chiave
- Il Canto X dell'Inferno è una riflessione sulla Firenze del passato, che Dante esule considera magnanima, attraverso il dialogo con Farinata, capo ghibellino.
- Dante, durante l'esilio, rifiutò di sottomettersi al governo di Firenze, una scelta che condannò anche i suoi figli all'esilio.
- Farinata rappresenta l'ingiustizia subita dai suoi discendenti, resistendo alle leggi che punivano i consanguinei e condividendo con Dante il destino di esilio.
- L'episodio di Cavalcante omaggia il figlio Guido, amico di Dante, evidenziando la sollecitudine paterna e il contrasto con l'immobilità di Farinata.
- Il Canto si conclude con un augurio affettuoso di Farinata a Dante, sottolineando l'ingiustizia subita e il destino comune di esilio, con un tono più umano.
Canto X dell'Inferno
L'episodio che ha per centro il capo ghibellino è una ripresa grandiosa del tema di Firenze, iniziato nel canto VI. Dante è il primo porta a trarre poesia da persone ed eventi contemporanei. Una ripresa nel senso che esso è una rievocazione della Firenze di ieri, che Dante esule, dopo la delusione infertagli dell'attuale, considera magnanima. Egli aveva serbato nel cuore i vecchio Fiorentini, aveva sempre mai rammentati con affezion la loro opera e i loro onorati nomi.
Tappe della vita di Dante
Per comprendere appieno l'episodio, bisogna ricordare alcune circostanza della biografia di Dante.1) Esule, avrebbe avuto varie opportunità di tornare a Firenze, purché si sottomettesse al governo Nero della città, riconoscendo che il suo passato costituiva una colpa. Non sottomettendosi, firmò la condanna non solo sua, ma anche dei figli, giacché la leghe prescriveva che i figli maschi degli esuli dovessero essere banditi anch'essi, appena raggiunti l'età di 14 anni; e infatti essi furono banditi effettivamente. Rifiutò per coerenza politica e rispetto per sé stesso.
2) Quando scriveva questo canto, Dante già da un pezzo aveva fatto parte per se stesso, si era staccato dalla compagnia dei Bianchi fuoriusciti e dei ghibellini loro alleati, anche se il suo pensiero politico inclinava ormai verso il ghibellinismo: improponibile quindi l'interpretazione tradizionale, che vede nel dialogo tra il ghibellino Farinata e il guelfo Dante lo scontro di due uomini di parte avversa.
3) Racconta Leonardo Bruni, documentato biografo, che quando l'imperatore Enrico VII pose l'assedio a Firenze, Dante, pur così fervido partigiano di lui, non volle unirsi al suo esercito, cioè prendere direttamente le armi contro la sua città.
4) Coloro che non tornarono più in Firenze, dopo la definitiva sconfitta del 1266, non furono i ghibellini ma, con altre famiglie, gli Uberti, i quali restarono per sempre banditi, e furono ripetutamente colpiti anche negli averi.
Farinata Il nodo che lega l'anima di Farinata, secondo l'interpretazione che Dante qui ci dà di questa grande personalità, che egli subito desidera di vedere appena sa di essere nel cerchio degli eretici (18), si palesa già nelle prime parole che pronuncia: in tanto prega Dante di fermarsi presso di lui, in quanto si accorge che egli è fiorentino, di quella nobil partia comune, alla quale egli teme d'essere stato troppo molesto.
Il veder Dante vivo e ancor giovane sta al capo ghibellino per escludere che egli possa essere personalmente tra i suoi amici o avversario: donde domanda immediatamente chi siano stati i suoi antenati. Appena saputone il nome, subito li colloca nella storia della sua azione politica. Ma il ricordo punge Dante nel suo orgoglio politico-familiare e lo porta a uno di quei rinfacci che esacerba la piaga più viva di Farinata, colpisce il punto in cui il generale problema politico-morale diventa problema familiare e affettivo. Tanto siamo al culmine del colloquio, che per fare risaltare ciò il poeta a questo punto lo interrompe bruscamente.
Cavalcante
Nell'interruzione s'inserisce l'episodio di Cavalcante, che è un omaggio al figlio di lui, a quel Guido che Dante nella Vita Nuova aveva definito il primo dei suoi amici, insieme al quale e a pochi altri aveva imposto un nuovo stile di lirica. Nella primavera del 1300, Guido era ancora vivo; per potergli rendere omaggio, il poeta immagina di parlare di lui con il padre. Un omaggio all'altezza dell'ingegno, e insieme un'addolorata riserva sul suo materialismo.Nonostante qualche dubbio, si può ritenere che Dante fosse tra i priori che decretarono il confino di Guido a Sarzana, dove si ammalò; poco dopo morì. A parte ciò, l'episodio, inserito in quello di Farinata, sottolinea l'essenza poetica di quest'ultimo: il tema della sollecitudine paterna è riproposto in un registro diverso.
Cavalcante non è un magnanimo come il suo vicino; quello è immobile nel suo dolore non addolcito da lagrime; il padre di Guido invece piange, si drizza di subito, si lascia ricadere, vinto dal suo trepido affetto che muta un sospetto in certezza; respira non nel basto mondo di Farinata, ma in quello della casa, non ha problemi politici, è solo un padre orgoglioso di suo figlio, dolente per la sua morte.
Ultima parte del canto
Torna a campeggiare Farinata. Qui l'immobilità è traduzione fisica esterna d'un pensiero sempre fiso a un punto: l'accanimento di Firenze contro i suoi discendenti è un'ingiustizia; Farinata si ribella alle leggi che rendevano corresponsabili i consanguinei, anche se esse erano allora comuni. Comunque, in presenza di queste leggi, il dovere verso la patria o verso sé stesso può assorbire e annullare il dovere del padre? E' lo stesso problema di Dante.Non passeranno cinquanta mesi, aggiunge subito Farinata, e anche tu saprai quanto...pesa l'arte di rientrare in patria; lo saprai per quel che riguarda te direttamente. In tal modo Farinata accomuna il destino dell'interlocutore al suo; le due famiglie non più contrastanti e a vicenda prevalenti, ma entrambe colpite da una medesima sorte.
Nell'ultima parte dell'episodio la figura di Farinata si addolcisce.
L'uomo già statuario, formula ora per Dante un augurio affettuoso: domanda dolente perché il popolo di Firenze sia così empio, così spietato verso i suoi. La ragione dell'accanimento dei Fiorentini sta nel sangue dei concittadini versato a Montaperti; Dante , che per suo conto non aveva voluto o non vorrà versarlo, mette a nudo la piaga dell'interlocutore. A questo punto la stessa immobilità s'incrina.
Domande da interrogazione
- Qual è il tema centrale del Canto X dell'Inferno?
- Quali sono le circostanze biografiche di Dante che influenzano il Canto X?
- Chi è Farinata e quale ruolo svolge nel canto?
- Qual è l'episodio di Cavalcante e cosa rappresenta?
- Come si conclude il Canto X e quale messaggio trasmette?
Il tema centrale del Canto X dell'Inferno è la rievocazione della Firenze del passato, che Dante esule considera magnanima, e il confronto tra il capo ghibellino Farinata e Dante stesso.
Dante, esule, rifiutò di sottomettersi al governo di Firenze, firmando così la condanna sua e dei suoi figli. Inoltre, pur essendo un fervido sostenitore dell'imperatore Enrico VII, non prese le armi contro Firenze.
Farinata è un capo ghibellino la cui anima è legata al tema dell'ingiustizia subita dai suoi discendenti. Egli rappresenta la resistenza contro le leggi che punivano i consanguinei e condivide con Dante il destino di esilio.
L'episodio di Cavalcante è un omaggio al figlio Guido, amico di Dante. Rappresenta la sollecitudine paterna e il dolore per la morte del figlio, in contrasto con l'immobilità di Farinata.
Il Canto X si conclude con un augurio affettuoso di Farinata a Dante, sottolineando l'ingiustizia subita dai suoi discendenti e il destino comune di esilio. La figura di Farinata si addolcisce, mostrando un lato umano e dolente.

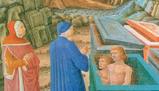





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo