vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Scarica il test di Ammissione a Veterinaria anno 2003 formato PDF
O O O
Rappresenta:
A) un’eredità autosomica dominante
B) un’eredità recessiva legata al cromosoma X
C) un’eredità dominante legata al cromosoma Y
D) un’eredità autosomica recessiva
E) un’eredità poligenica
41. Incrociando una pianta a fenotipo dominante (A) con una a fenotipo recessivo (a) i genotipi delle
piante che si ottengono potranno essere:
A) Aa oppure aa
B) AA oppure aa
C) AA oppure Aa
D) esclusivamente Aa
E) sicuramente diversi dai genotipi dei genitori
42. Responsabili dell’immunità cellulo-mediata sono:
A) linfociti T
B) linfociti B
C) istamina e complemento
D) globuli rossi
E) fagociti
43. Gli osteoblasti sono:
A) i precursori delle cellule dell’osso
B) cellule che demoliscono il tessuto osseo
C) le tipiche cellule del tessuto osseo contenute all’interno di lacune
D) i precursori del tessuto cartilagineo
E) cellule particolarmente abbondanti in caso di osteoporosi
10
M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
44. Il gatto (Felis cattus) e il puma (Felis concolor) appartengono:
A) alla stessa famiglia
B) alla stessa specie
C) a generi diversi
D) a famiglie diverse
E) a ordini diversi Test di Chimica
45. “Tutti gli elementi del VII gruppo del sistema periodico (alogeni) possiedono, nell’ultimo livello, due
elettroni di tipo s e cinque di tipo p, di cui uno disaccoppiato. Essi hanno pertanto tendenza a formare
ioni monovalenti negativi, acquistando un elettrone e comportandosi quindi come energici ossidanti; la
loro alta reattività giustifica altresì il fatto che gli alogeni non sono generalmente presenti in natura
allo stato libero, ma combinati con altri elementi”.
Quale delle seguenti affermazioni PUO’ essere dedotta dalla lettura del brano precedente?
A) Gli alogeni hanno una notevole tendenza a ridursi
B) Gli atomi degli alogeni tendono a cedere elettroni
C) L'elettrone disaccoppiato degli alogeni si trova nell'orbitale s dell’ultimo livello
D) Gli alogeni tendono a formare composti con altri elementi formando legami covalenti
E) Gli alogeni hanno una notevole tendenza ad ossidarsi
46. "Tutti i carbonati degli elementi del II gruppo sono poco solubili in acqua, e si trovano in natura come
minerali solidi; il più comune tra questi composti è il carbonato di calcio, o calcare, che costituisce
uno dei minerali più diffusi; il carbonato di calcio, praticamente insolubile in acqua pura, risulta
invece assai solubile in acqua contenente anidride carbonica; la soluzione acquosa di CO scioglie il
2
carbonato di calcio, perché lo converte in idrogenocarbonato (o bicarbonato), solubile; le rocce
calcaree vengono pertanto erose dalle acque del suolo, tutte contenenti CO ".
2
Quale delle seguenti affermazioni PUO’ essere dedotta dalla lettura del brano precedente?
A) Il calcio è un elemento del II gruppo
B) Il carbonato di calcio ha una notevole solubilità in acqua
C) L'unico carbonato poco solubile in acqua è quello di calcio
D) Il carbonato e il bicarbonato di calcio hanno pressoché la stessa solubilità in acqua
E) Il bicarbonato di calcio si trasforma in carbonato per effetto dell'anidride carbonica
47. “La pressione osmotica del sangue è dovuta principalmente ai sali in esso disciolti; la concentrazione
molare delle proteine, a causa del loro alto peso molecolare, è talmente bassa che, sul totale di circa
7,63 atm (valore della pressione osmotica del sangue a 37° C), il contributo delle proteine è solo di
circa 0,045 atm”.
Quale delle seguenti affermazioni NON può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?
A) Sia i sali che le proteine presentano un elevato peso molecolare
B) Quanto più alto è il peso molecolare del soluto, tanto più bassa è la sua concentrazione molare a
parità di peso
C) Il contributo delle proteine al totale della pressione osmotica del sangue è minore del 1%
D) Il contributo delle sostanze non proteiche al totale della pressione osmotica del sangue è
maggiore del 90%
E) Nel sangue sono disciolte sostanze ad alto ed a basso peso molecolare
11
48. “Esistono vari modi per esprimere la concentrazione di una soluzione; le frazioni molari del solvente e
del soluto, cioè i rapporti tra le moli rispettivamente di solvente e soluto e le moli totali, dipendono dal
valore del peso molecolare del solvente, oltre che, ovviamente, dal valore del peso molecolare del
soluto, mentre la molarità, cioè il numero di moli di soluto in ogni litro di soluzione, è ovviamente
indipendente dal peso molecolare del solvente”.
Quale delle seguenti affermazioni NON può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?
A) Per calcolare le frazioni molari non è necessario conoscere il peso molecolare del soluto
B) La molarità di una soluzione può essere calcolata dividendo le moli di soluto per i litri di
soluzione in cui esse moli sono contenute
C) La frazione molare del solvente si calcola dividendo le moli di solvente per le moli totali
D) La frazione molare del soluto si calcola dividendo le moli di soluto per le moli totali
E) Per calcolare la molarità non è necessario conoscere il peso molecolare del solvente
49. “In genere, se la temperatura viene aumentata, si osserva che, per la maggioranza dei solidi, la
solubilità aumenta, mentre per alcuni altri diminuisce. Il fenomeno contrario si osserva invece a
proposito della solubilità dei gas nei liquidi, dove la solubilità decresce nettamente al crescere della
temperatura. Nella maggioranza dei casi si osserva che la dissoluzione del solido è endotermica, cioè
accompagnata da raffreddamento, e quindi da assorbimento di calore; in qualche caso invece il
processo è esotermico, cioè si ha sviluppo di calore; l'effetto termico nella dissoluzione di un solido
in un liquido è dovuto a due processi principali: il disfacimento del reticolo cristallino, che avviene
sempre con assorbimento di calore, e la solvatazione delle molecole o degli ioni che vanno in
soluzione, processo che avviene sempre con sviluppo di calore”.
Quale delle seguenti affermazioni PUO’ essere dedotta dalla lettura del brano precedente?
A) La dissoluzione di un solido in un liquido può essere accompagnata, a seconda dei casi, da
sviluppo o da assorbimento di calore
B) Il disfacimento del reticolo cristallino di un solido è un processo esotermico
C) La solvatazione degli ioni che vanno in soluzione è un processo endotermico
D) Ad alta temperatura la solubilità dei solidi nei liquidi in genere è assai bassa
E) La solubilità dei gas nei liquidi cresce al crescere della temperatura
50. "La struttura caratteristica delle immine è il doppio legame carbonio-azoto. Questi composti, meno
stabili delle aldeidi e dei chetoni, reagiscono con numerosi reattivi, e solo pochissime immine sono
dotate di stabilità sufficiente per essere isolate".
Quale delle seguenti affermazioni PUO’ essere dedotta dalla lettura del brano precedente?
A) Le immine instabili sono in numero superiore rispetto a quelle stabili
B) I chetoni e le aldeidi sono assai stabili
C) I chetoni e le aldeidi sono assai instabili
D) Non è comunque possibile isolare le immine
E) E’ molto facile isolare le aldeidi ed i chetoni
51. “Tutte le sostanze gassose, se la pressione non è molto elevata (inferiore comunque a 5 atmosfere), e
se la temperatura assoluta è superiore a 200° K, seguono con buona approssimazione la legge secondo
cui il volume varia in misura inversamente proporzionale alla pressione esercitata sulla massa gassosa
(legge di Boyle-Mariotte). Se si riportano i valori del prodotto pV sulle ordinate, e valori di p sulle
ascisse, a temperatura costante, si deve teoricamente ottenere, se la legge in questione viene rispettata,
una linea retta parallela all'asse delle ascisse”. 12
M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Quale delle seguenti affermazioni PUO’ essere dedotta dalla lettura del brano precedente?
A) Alle condizioni TPS (0° C e 1 atm) la legge di Boyle-Mariotte è verificata generalmente con
buona approssimazione
B) Riportando pV in funzione di p si dovrebbe teoricamente ottenere una retta verticale
C) La legge di Boyle-Mariotte è verificata tanto meglio quanto più alta è la pressione
D) La legge di Boyle-Mariotte è verificata tanto meglio quanto più bassa è la temperatura
E) Il grafico teorico di p in funzione di V è una retta parallela all'asse delle ascisse
52. Un valore positivo della variazione di energia libera indica che la reazione è :
A) non spontanea
B) spontanea
C) endotermica
D) esotermica
E) molto veloce
53. La relazione pH + pOH =14 è valida :
A) per tutte le soluzioni acquose
B) per qualsiasi soluzione, anche non acquosa purché contenente un acido e una base
C) solo per soluzioni acquose contenenti un acido o una base
D) solo per soluzioni acquose neutre
E) solo per soluzioni acquose basiche
→
54. Nella reazione Zn + FeCl ZnCl + Fe la specie chimica che si riduce è :
2 2
A) Fe
B) Zn
C) Cl
D) nessuna, si ha solo ossidazione
E) non si tratta di una reazione di ossidoriduzione
55. Mediante una reazione di deidrogenazione, da un alcool secondario si ottiene :
A) nessuno dei composti indicati nelle altre risposte
B) una aldeide
C) una ammide
D) un etere
E) un alchene
56. Il pentene reagisce con l’idrogeno, con l'acqua ossigenata e con lo iodio; si tratta, in tutti e tre i
casi, di reazioni di :
A) addizione elettrofila
B) sostituzione nucleofila
C) addizione nucleofila
D) sostituzione elettrofila
E) meccanismo diverso da quello indicato nelle altre risposte
57. Una delle seguenti caratteristiche è comune allo ione ammonio e al metano:
A) la struttura spaziale
B) la carica elettrica
C) le spiccate proprietà basiche
D) le spiccate proprietà acide
E) l'energia di legame tra gli atomi costituenti le rispettive molecole
13
58. Se un atomo di idrogeno acquista un elettrone, si forma uno ione :
A) idruro
B) idrossonio
C) idronio
D) idrogenuro
E) idrogenato
59. In un disaccaride i due monosaccaridi costituenti sono legati attraverso un legame :
A) glicosidico
B) ionico
C) a ponte di idrogeno
D) secondario
E) peptidico
60. Il ciclopentano: 3
A) possiede atomi di C ibridati sp
B) presenta carattere aromatico
C) è costituito da 6 atomi di C e 6 atomi di H
2
D) possiede atomi di C ibridati

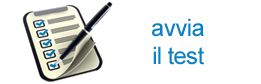






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









