Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
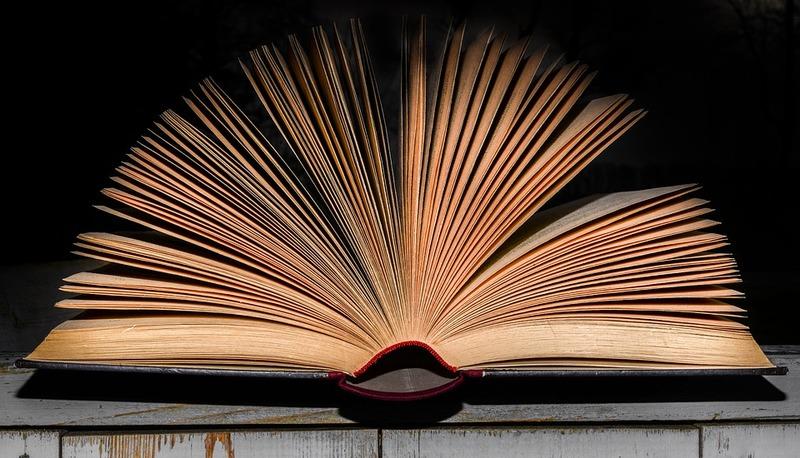 Introduzione
IntroduzioneRaccontare il ventesimo secolo da lontano spettatore, seduto tra le comode poltrone di una sorda platea, aldilà del sanguinoso palco fatto di sofferenza, guerra e morte, potrebbe sembrare alquanto oltraggioso agli occhi di chi in quel palco vi ha recitato e vissuto davvero; vi ha visto crollare la propria casa, vi ha visto perdere i legami più importanti, vi ha visto la morte. E l’ha vista veramente, l’ha vista recitare per un secolo intero la stessa tragedia, senza neanche un attimo di pausa tra una scena e l’altra, senza neanche avere il tempo per una preghiera. Perché la preghiera è per i deboli, per coloro che non hanno il coraggio di tirare avanti con le proprie forze, per coloro che in quel palco non vogliono più recitare, perché pensano che questo spettacolo ormai sia durato fin troppo, e non è più piacevole nemmeno assistervi da lontano spettatore, seduto tra qualche comoda poltrona di una sorda platea.
C’è uno strano comune denominatore che unisce e accomuna gli infiniti personaggi che hanno vissuto e subito l’influenza di questo periodo notevolmente drammatico, come uniti da un invisibile filo e inglobati in una sfera che racchiude poeti, scrittori, pensatori, filosofi, scienziati, fisici, che hanno tutti calpestato il suolo della guerra. Lo hanno vissuto e veduto come ogni altro singolo individuo appartenuto a quel triste periodo, ma loro, però, hanno fatto di più; quell’orrore lo hanno anche scritto, dipinto o cantato, rendendolo non più un’esperienza essenzialmente personale, ma adesso “roba di tutti”, affinché potessimo accorgerci, ora, che la guerra è esistita davvero, e che la morte, la paura e la sofferenza non sono soltanto delle astratte essenze prive di forma, ma, invece, una forma ce l’hanno, e anche ben definita. Questi uomini hanno visto per davvero le più brutali delle sofferenze prendere forme umane, tante e diverse forme simili solo nella crudeltà e nella brutalità, rese manifeste dalla efferatezza, dalla ferocia, dalla disumanità e dalle atrocità delle loro azioni, che, per certi aspetti, piangiamo ancora oggi.
Ma allora il loro insegnamento sembra non essere servito a niente, se ci ritroviamo oggi, nell’anno 2008 di fronte ad aventi, situazioni e persone che da questi eroi del passato non vogliono trarre nessun insegnamento. Ma quale insegnamento? Ci sarà poi davvero un insegnamento da trarre da tutto questo? O l’idea che “la guerra anche se fa male in fondo è utile” primeggia nelle menti e nelle coscienze degli uomini? La guerra serve a raggiungere degli spregevoli obiettivi. Spregevoli e ignobili ma pur sempre importanti. Basti pensare al fatto che se un soldato uccide un nemico viene considerato un eroe durante la guerra, però se lo uccide nel momento sbagliato non è altro che un assassino. Un paradosso su cui probabilmente in pochi riflettono, ma che sembra forse contenere al suo interno il fulcro centrale dell’intera questione, quella cioè, che la guerra e le sue azioni sono giustificabili se alla fine del percorso vi è un reale e concreto obiettivo, capace di scavalcare persino la morte. Non esiste punizione per i crimini di guerra, solo celebrazione, ed è da questo concetto che va letta e analizzata un’opera talmente grande, mostruosa e al tempo stesso reale che ha influito e continuerà ad influire sulle nostre vite, perché le atrocità sono parte integrante dell’essenza umana, senza le quali, forse, l’uomo non si sentirebbe mai veramente realizzato.
Dario
Savarese VF
Esame di Stato
18-27 Giugno 2008
Istituto Provinciale di Cultura e
Lingue
Ninni Cassarà
R accontare il ventesimo secolo da lontano spettatore, seduto tra le comode
poltrone di una sorda platea, aldilà del sanguinoso palco fatto di sofferenza,
guerra e morte, potrebbe sembrare alquanto oltraggioso agli occhi di chi in
quel palco vi ha recitato e vissuto davvero; vi ha visto crollare la propria casa,
vi ha visto perdere i legami più importanti, vi ha visto la morte. E l’ha vista
veramente, l’ha vista recitare per un secolo intero la stessa tragedia, senza
neanche un attimo di pausa tra una scena e l’altra, senza neanche avere il
tempo per una preghiera. Perché la preghiera è per i deboli, per coloro che non
hanno il coraggio di tirare avanti con le proprie forze, per coloro che in quel
palco non vogliono più recitare, perché pensano che questo spettacolo ormai
sia durato fin troppo, e non è più piacevole nemmeno assistervi da lontano
spettatore, seduto tra qualche comoda poltrona di una sorda platea.
C’è uno strano comune denominatore che unisce e accomuna gli infiniti
personaggi che hanno vissuto e subito l’influenza di questo periodo
notevolmente drammatico, come uniti da un invisibile filo e inglobati in una
sfera che racchiude poeti, scrittori, pensatori, filosofi, scienziati, fisici, che
hanno tutti calpestato il suolo della guerra. Lo hanno vissuto e veduto come
ogni altro singolo individuo appartenuto a quel triste periodo, ma loro, però,
hanno fatto di più; quell’orrore lo hanno anche scritto, dipinto o cantato,
rendendolo non più un’esperienza essenzialmente personale, ma adesso “roba
di tutti”, affinché potessimo accorgerci, ora, che la guerra è esistita davvero, e
che la morte, la paura e la sofferenza non sono soltanto delle astratte essenze
prive di forma, ma, invece, una forma ce l’hanno, e anche ben definita. Questi
uomini hanno visto per davvero le più brutali delle sofferenze prendere forme
umane, tante e diverse forme simili solo nella crudeltà e nella brutalità, rese
manifeste dalla efferatezza, dalla ferocia, dalla disumanità e dalle atrocità delle
loro azioni, che, per certi aspetti, piangiamo ancora oggi.
2
Ma allora il loro insegnamento sembra non essere servito a niente, se ci
ritroviamo oggi, nell’anno 2008 di fronte ad aventi, situazioni e persone che da
questi eroi del passato non vogliono trarre nessun insegnamento. Ma quale
insegnamento? Ci sarà poi davvero un insegnamento da trarre da tutto questo?
O l’idea che “la guerra anche se fa male in fondo è utile” primeggia nelle menti
e nelle coscienze degli uomini? La guerra serve a raggiungere degli spregevoli
obiettivi. Spregevoli e ignobili ma pur sempre importanti. Basti pensare al fatto
che se un soldato uccide un nemico viene considerato un eroe durante la
guerra, però se lo uccide nel momento sbagliato non è altro che un assassino.
Un paradosso su cui probabilmente in pochi riflettono, ma che sembra forse
contenere al suo interno il fulcro centrale dell’intera questione, quella cioè, che
la guerra e le sue azioni sono giustificabili se alla fine del percorso vi è un reale
e concreto obiettivo, capace di scavalcare persino la morte. Non esiste
punizione per i crimini di guerra, solo celebrazione, ed è da questo concetto
che va letta e analizzata un’opera talmente grande, mostruosa e al tempo
stesso reale che ha influito e continuerà ad influire sulle nostre vite, perché le
atrocità sono parte integrante dell’essenza umana, senza le quali, forse, l’uomo
non si sentirebbe mai veramente realizzato.
L a guerra è presente nella storia di tutte le civiltà umane conosciute. Mentre
segna la storia delle vicende politiche, balza in primo piano anche
nell’immaginario e nella cultura.
Nel Novecento la guerra cambia completamente volto rispetto al passato, sia
come fenomeno che come presenza nell’immaginario e nel pensiero.
Prima di tutto cambia il modo di combattere.
Il soldato non è altro che un cittadino armato, non più professionista. Non conta
l’abilità ma la massa. Sparisce ogni spazio per l’iniziativa personale e per
l’eroismo. Il soldato si accorge di essere solo un piccolissimo ingranaggio nel
meccanismo della guerra.
Parallelamente, con l’introduzione sempre più massiccia della tecnologia nei
mezzi impiegati e con lo straordinario sviluppo dell’aviazione militare, il
combattente vede aumentare la propria distanza dal nemico e gli è sempre
meno evidente il significato dei propri gesti. Si sviluppano una forma di
alienazione del soldato e una condizione che i piloti statunitensi impegnati
nella guerra del Vietnam chiamavano “moralità d’alta quota”: dall’alto si
riesce a fare ciò che altrimenti sarebbe ripugnante, perché non si percepisce
l’orrore della distruzione e della morte. 3
Cambia, rispetto alla guerra, la condizione dei civili.
Quelli dei paesi coinvolti nel conflitto vivono nell’angoscia di essere colpiti dal
fuoco di un nemico sconosciuto e imprevedibile che viene dall’alto.
L’esposizione dei civili inermi al pericolo del massacro aumenta
progressivamente, tanto che alla fine del secolo la guerra causa più vittime tra
i civili che tra i militari.
Il novecento lascia aperti moltissimi interrogativi sia sulle origini profonde della
guerra che sui suoi futuri sviluppi. Riflettere sul problema della guerra e sulla
sua storia recente significa dunque interrogarsi sulla guerra del futuro,
prendere consapevolezza degli impulsi aggressivi dell’uomo, comprendere di
volta in volta le ragioni profonde della loro manifestazione e abituarsi a
riconoscerle nelle vicende storiche.
N
ell’età moderna si delineano nuovi modi di concepire e di percepire il
fenomeno della guerra, oltre che nuove maniere di combattere.
Il Novecento è segnato dalla “guerra mondiale”: la prima, quella tra il 1914 e
1918, provoca una vera e propria svolta nell’immaginario collettivo. Si inaugura
l’epoca della “guerra totale”, che mobilita tutti i cittadini.
Nel XX secolo la potenza delle armi e le dimensioni della guerra superano ogni
limite, facendo saltare qualsiasi regola. Il conflitto viene assolutizzato: il nemico
va annientato a tutti i costi.
Ma il Novecento è anche un secolo contraddittorio: si sviluppano
contemporaneamente sia un movimento di pensiero e organizzazioni per la
pace che ideologie tendenti a giustificare di volta in volta la guerra, se non ad
esaltarla come fenomeno in sé.
L a portata devastante della Grande Guerra indusse Sigmund Freud a
indagare le cause del comportamento aggressivo dell’uomo e a rivedere la
sua teoria delle pulsioni. Da questo momento, infatti, egli considererà innata
nell’uomo, oltre alla componente del desiderio, anche quella dell’egoismo.
La seconda guerra mondiale sarà ancor più totale della prima e sperimenterà la
tecnica dei bombardamenti a tappeto, già messa in atto durante la guerra
civile spagnola, con cui si uccidono anche moltissimi civili.
Quali sono le cause che spingono gli uomini alla guerra? L’esigenza di dare una
risposta a questo interrogativo diventa fortissima nel secondo Novecento.
Secondo alcuni si tratta di una tendenza innata e dunque ineliminabile.
Secondo altri è invece un prodotto culturale, superabile con una trasformazione
della società e della cultura dominanti.
Se la teoria psicoanalitica legata a Freud considera la guerra come il prodotto di
dinamiche psichiche, gli studiosi di etologia (la scienza che studia il
comportamento degli animali) interpretano la guerra come il prodotto della
velocità di cambiamento delle condizioni di vita dell’uomo, che ha ostacolato la
creazione di adeguati meccanismi inibitori. L’uomo accumula aggressività
perché non trova valvole di sfogo, se non periodicamente nella guerra.
Nella prospettiva di chi si richiama al pensiero di Marx, invece, la guerra è il
prodotto della divisione in classi sociali e dell’affermazione del capitalismo: la
fine di questo sistema economico e sociale comporterebbe anche la scomparsa
della guerra.
Esistono anche delle teorie che non riconoscono nell’uomo una naturale
propensione verso la guerra, perché non considerano l’aggressività come una
componente umana costitutiva. Per esempio, secondo la posizione della Chiesa
4
cattolica la guerra è causata dalla diffusione di certe ideologie che istigano
all’odio e la sua abolizione dalla storia futura è possibile attraverso
l’affermazione dei valori cristiani.
Per Gandhi, fondatore della teoria della non-violenza come metodo di lotta, la
natura autentica dell’uomo è fondamentalmente ostile alla guerra. Egli colloca
alla base del mondo la forza dell’amore e confida proprio in essa per
l’instaurazione della pace.
L a guerra può essere giustificata, sostenuta o addirittura invocata con
motivazioni di vario tipo. La prima metà del Novecento è attraversata da
ideologie belliciste molto influenti, alle quali aderirono anche alcuni
intellettuali.
Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio sostennero la guerra coloniale e poi
la guerra mondiale in nome della patria, dell’estensione e della difesa del
territorio nazionale. I discorsi politici che Pascoli e D’Annunzio pronunciarono in
pubblico riflettono un’ideologia nata con gli Stati-nazione: il nazionalismo, che
mette la “patria” al di sopra di tutti gli altri valori.
Il tono di D’Annunzio preannuncia l’enfasi e l’aggressività dell’ideologia
fascista, che di lì a poco avrebbe dominato in Italia e fuori d’Italia. L’Europa
degli anni Trenta è infatti caratterizzata da un nazionalismo esasperato e
sempre più aggressivo.
Il regime fascista in Italia e quello nazista in Germania si pongono l’obiettivo di
affermare il loro dominio sugli altri popoli e per sostenere questi progetti
espansionistici diffondono, attraverso la scuola, la stampa e la radio, idee
spiccatamente militariste. La guerra è esaltata come momento di espressione
delle più alte virtù e di esibizione della potenza fisica. Il bellicismo si associa
facilmente al maschilismo: la guerra è per gli uomini ciò che per la maternità è
per la donna. L’uomo manifesta la propria vera natura quando diventa
guerriero.
Ma già all’inizio del secolo la guerra era stata esaltata per le sue potenzialità
rigeneratrici. Era una componente fondamentale dell’ideologia del Futurismo, i
cui esponenti confluiranno poi, non per caso, nel movimento fascista.
S
eppure in lieve misura, la Grande Guerra sperimentò i primi prototipi
dell’aviazione, che avrà un peso decisivo nelle guerre successive.
L’impiego degli aerei per lanciare bombe dall’alto diventa massiccio a partire
dalla guerra civile spagnola. La seconda guerra mondiale sarà poi
caratterizzata da veri e propri bombardamenti a tappeto sulle città. Questo
fatto sconvolge le dinamiche della guerra e soprattutto la vita dei civili, assaliti
dall’incubo della distruzione imminente.
I cittadini di molte città europee furono costretti a convivere lunghi mesi con
l’angoscia dell’allarme. L’eventualità di essere colpiti da un fuoco proveniente
dall’alto, imprevedibile e incontrastabile, sconvolse la vita dei civili, che si
trovarono così esposti al pericolo come i militari, diversamente da quanto era
accaduto nella guerra di trincea.
La fine della seconda guerra mondiale fece così emergere in primo piano il
problema della tutela dei civili, esposti alla morte senza possibilità di
difendersi, e quello della salvaguardia dei beni culturali, oggetto di distruzione
indiscriminata. 5
N
egli anni dell’incubo atomico, la guerra è una presenza quotidiana sugli
schermi televisivi e anche in quelli cinematografici.
La possibilità di documentare da vicino la guerra si complica sempre più nel
corso del secondo Novecento. Infatti, la guerra aerea, che si svolge nei cieli, è
difficile da raccontare. I giornalisti possono ricavare informazioni sulla
frequenza e sull’entità delle missioni soltanto dai militari. Così passano sullo
schermo televisivo le interviste ai piloti, che non danno notizie particolarmente








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









